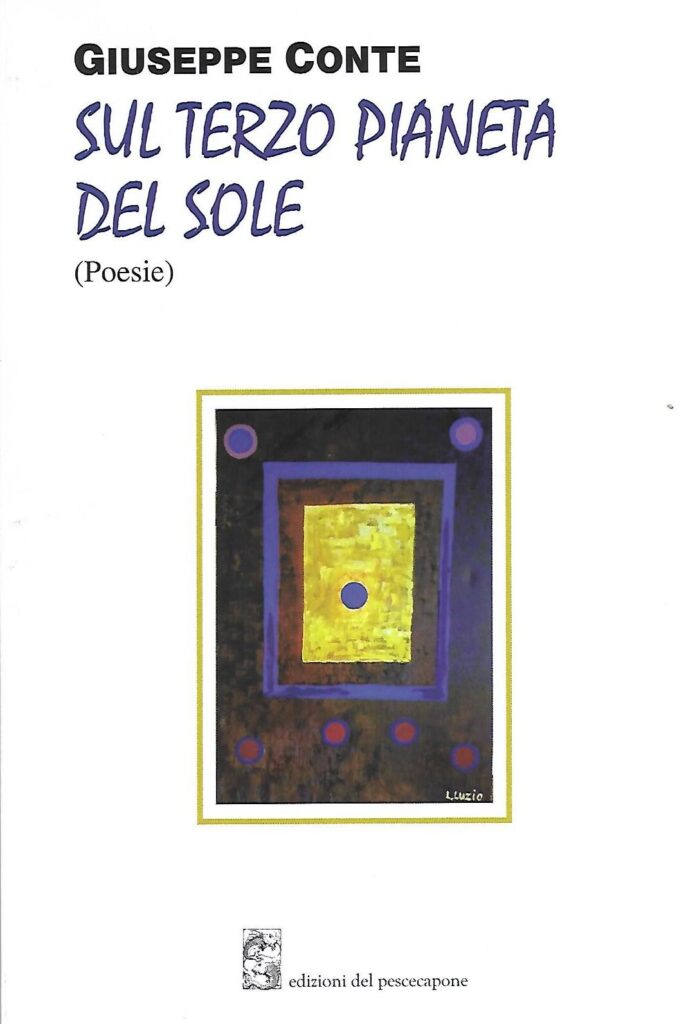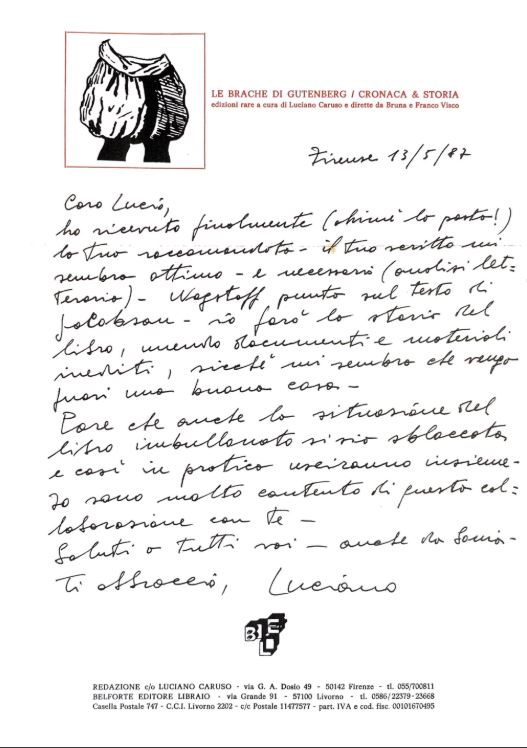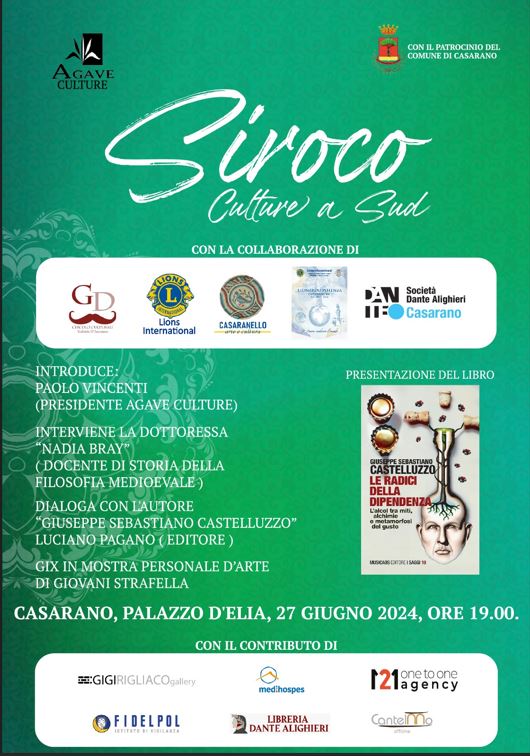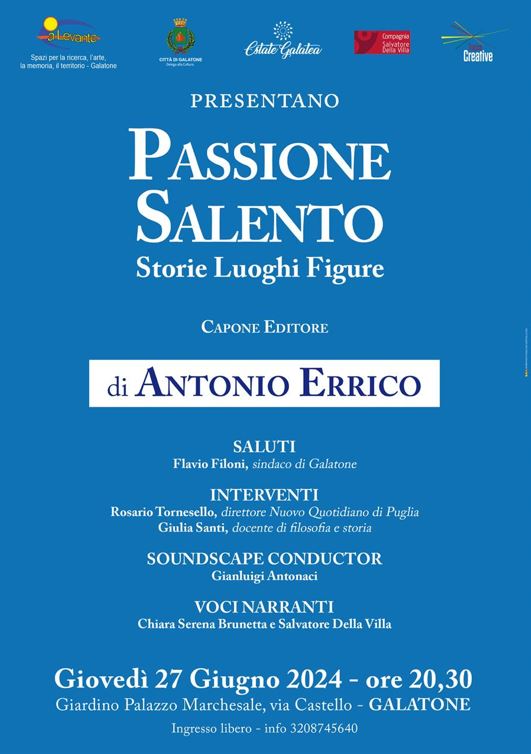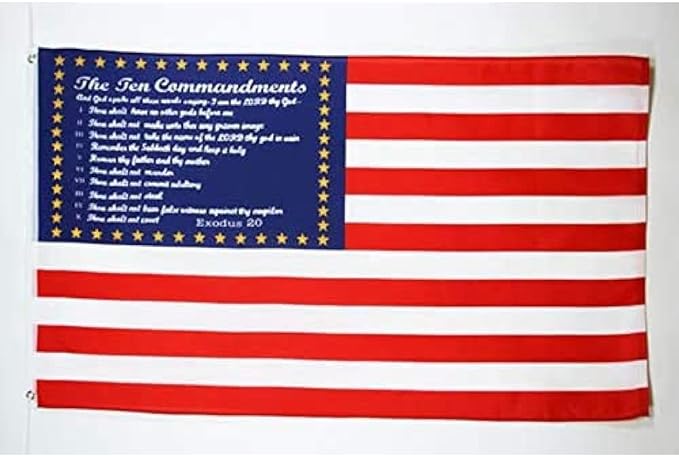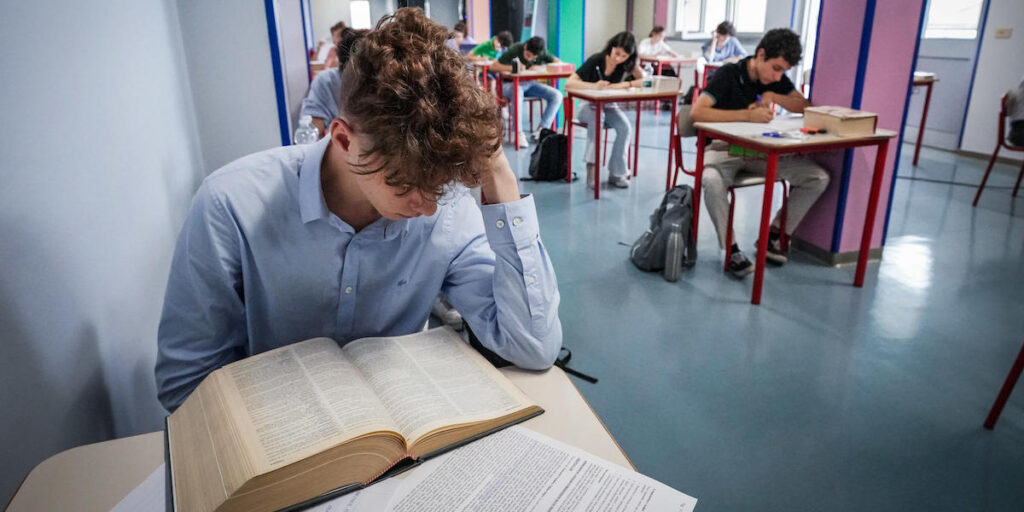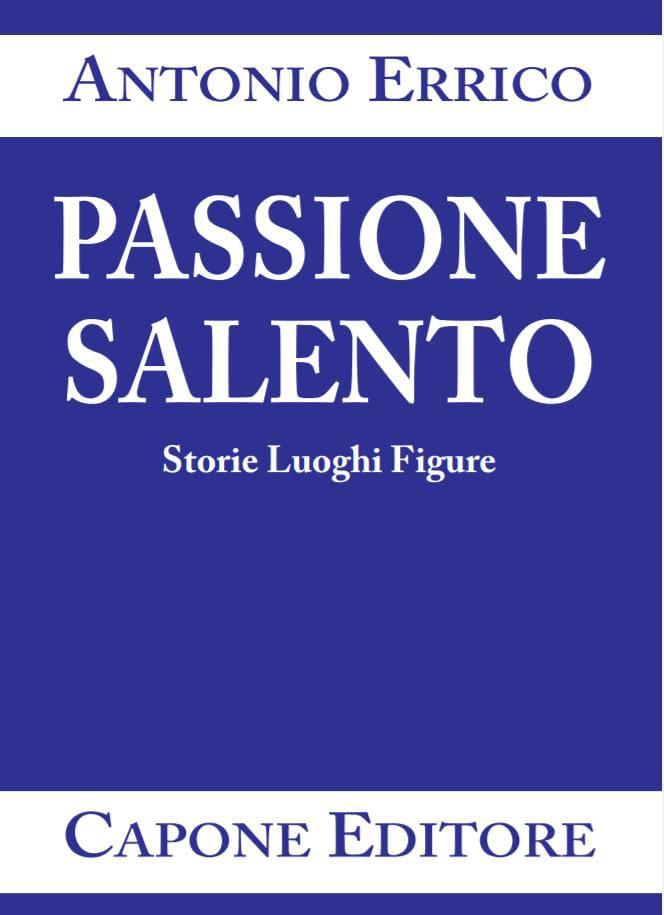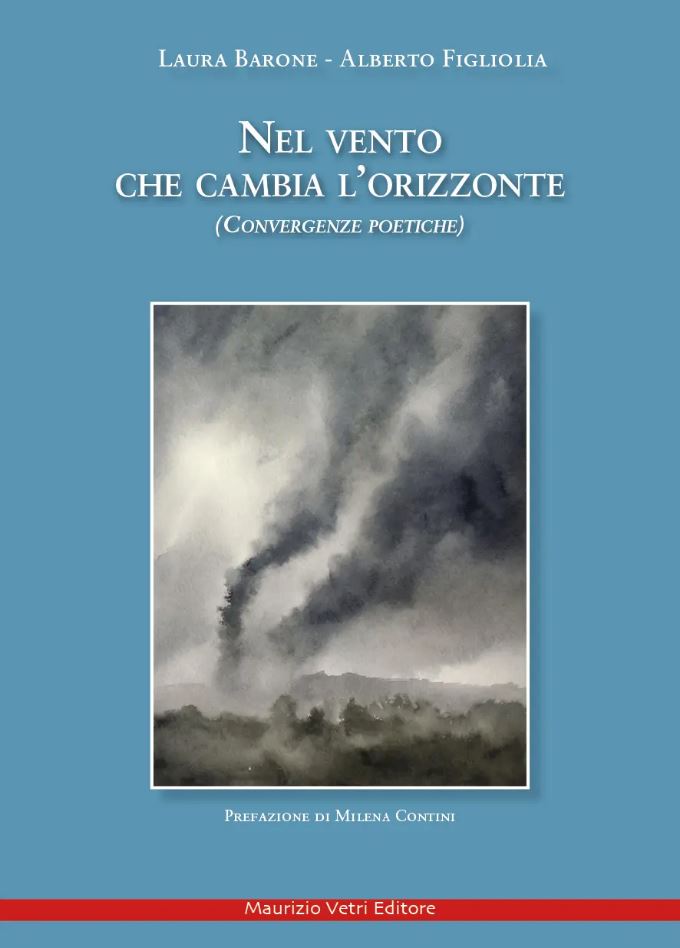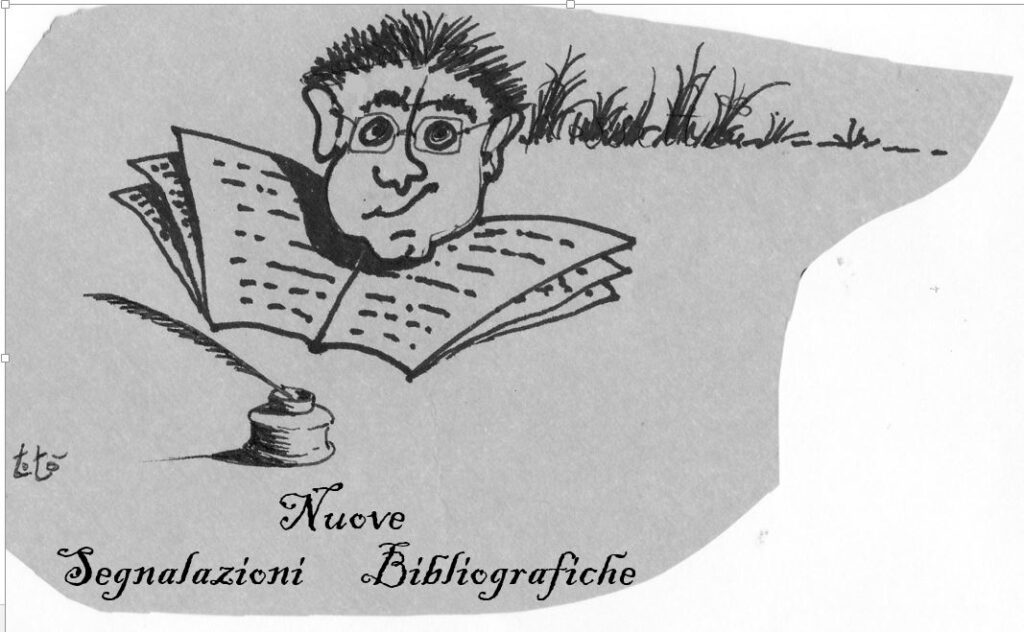di Ferdinando Boero

I presidenti di Regione, dalla Lombardia alla Sicilia, con buona parte di quelle che stanno in mezzo, sono finiti in gabbia per “irregolarità” gestionali. Alcune Regioni funzionano meglio di altre, e riescono a tollerare il malaffare, ma fino a un certo punto. I lombardi, durante il Covid, hanno pagato con molte vite le conseguenze di una sanità sbilanciata e, non paghi, hanno rieletto chi ha gestito malissimo la pandemia. Formigoni artefice del disastro, scontata la pena, vuol tornare in politica: glielo chiedono in tanti, dice. Molti amministratori del sud perseguono l’obiettivo di perpetuare l’accesso ai fondi di coesione, assegnati per far uscire le loro regioni da uno stato di bisogno. Il fine dei fondi è di non averne più bisogno, gli amministratori mirano a continuare ad averne bisogno. Poi non li sanno utilizzare (molti devono essere restituiti) oppure li usano per costruire cattedrali nel deserto che costano tantissimo e che non risolvono i problemi di quelle regioni. La Sicilia è a statuto speciale, e riceve ancora più soldi. Come sono utilizzati? Siamo in democrazia. Se i siciliani vogliono Totò Cuffaro e i lombardi Fontana e li premiano plebisciti… che ne paghino le conseguenze. Ci sono differenze tra nord e sud, ma la qualità della classe politica espressa con il voto democratico non cambia gran che.
Se la popolazione vota persone di questo tipo, da nord a sud, è giusto che siano loro a reggere le sorti delle regioni e del paese! Il principio di responsabilità prevede che chi vota una classe politica che porta alla rovina il territorio, poi ne pagherà le conseguenze. Che fare? L’uomo forte che impone il buon governo? Tutti i tentativi hanno dato pessimi risultati.