di Adele Errico
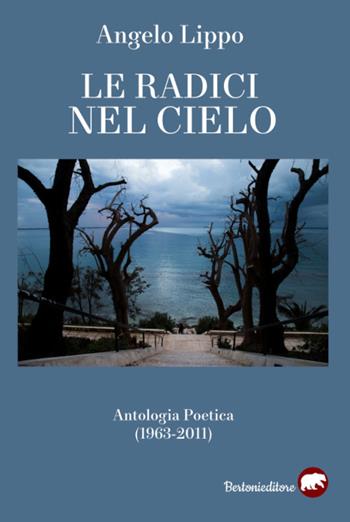
“Appena dodicenne, io/e tu andavi via:/ma lasciasti/per me/bianchi e neri cavalli/dal muso bagnato”. Null’altro era rimasto al dodicenne Angelo Lippo del nonno, se non quei bianchi e neri cavalli dal muso bagnato. Così pensava il bambino di allora scoprendo, poi, che in quell’assenza, in quell’andare via, si generava il sentire poetico che lo avrebbe accompagnato negli anni a venire e che del nonno gli sarebbero rimasti non solo i cavalli, ma tutta l’essenza di quella che sarebbe stata la sua opera. Suo nonno era carrettiere, era uomo del Sud che Angelo Lippo ha raccontato ma che ha anche rifiutato, al quale ha rivolto un “odi et amo” che abita i suoi versi, un Sud che è phàrmakon come medicina e come veleno. L’antologia poetica Le radici nel cielo (Bertoni 2021), voluta dalle figlie Antonella e Pamela e dalla moglie Angela, raccoglie testi scritti da 1963 al 2011 esi presenta, già nel titolo, come rovesciamento: in un mondo in cui le radici affondano nel cielo e non nella terra, dove dovrebbero stare, tutto è possibile, ogni narrazione, ogni contraddizione, ogni amore. Angelo Lippo racconta la sua terra, Taranto, e le persone che la vivono, la abitano, la coltivano. Racconta Taranto come luogo da cui fuggire, da respingere. Racconta l’urgenza dell’allontanamento. E poi, l’urgenza del ritorno. Come scrive Dante Maffia: “E’ evidente che il Lippo di un tempo vive soltanto nel fondo e che le strade di Taranto, il golfo, i ponti, i vecchi vicoli, le piazze, i palazzi, gli altiforni del siderurgico sono finalmente riconosciute come le vene che lo attraversano. Taranto è il sangue che lo tiene in vita, è tutto ciò che ha vissuto, forse il futuro”. In Taranto Lippo vive la lacerazione tra il richiamo della modernità della città e il ritorno ai valori ancestrali della campagna, lo scollamento tra la ricerca del passato e la tensione verso il futuro.






























































