di Antonio Lucio Giannone
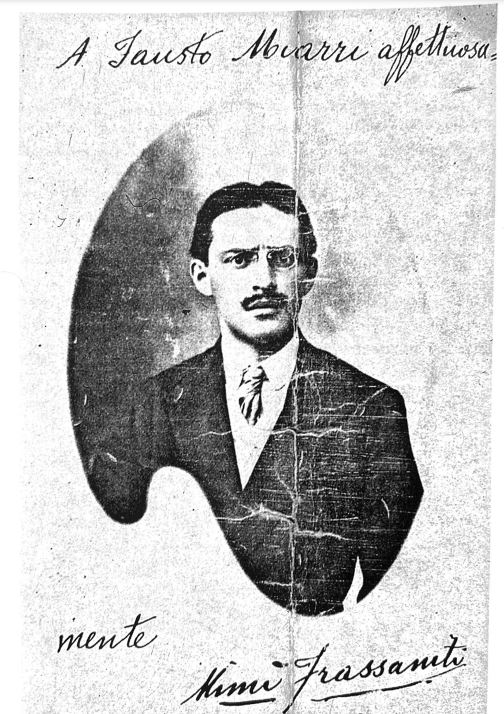
Ma al futurismo Frassaniti dedicò anche, nel 1910, uno studio critico, rimasto inedito e ritrovato manoscritto tra le sue carte[1], che è forse in assoluto, come abbiamo già avuto occasione di sottolineare, il primo tentativo del genere o comunque, in ogni caso, sicuramente uno dei primi in tutta Italia[2]. Questo lavoro, che rivela nel suo complesso un’accurata documentazione e un buon grado di comprensione delle novità del movimento in campo letterario, almeno nella sua fase aurorale, è diviso in varie parti, che affrontano le origini del futurismo, la figura del suo fondatore, F. T. Marinetti, e l’opera dei principali esponenti, Gian Pietro Lucini, Paolo Buzzi, Corrado Govoni, Enrico Cavacchioli e Aldo Palazzeschi. Lo studio è concluso da un capitolo, intitolato Che cosa rappresenta il Futurismo.
Nelle prime pagine, di chiara impronta evoluzionistica, Frassaniti rinviene le origini del futurismo nella rivoluzione francese, che “abbattendo tutte le barriere fece riconoscere ed affermare la coscienza di Sé”[3]. Da essa deriverebbe anche il simbolismo, da lui definito “padre legittimo” del movimento italiano, che con maggiore energia e risolutezza di quello porta avanti il suo programma rinnovatore.
Di Marinetti, prima di prendere in esame le opere, si mettono in rilievo alcuni tratti della personalità, come la grande “energia” e attività, la lotta ai luoghi comuni, la cultura “profonda e fresca”, la fantasia “aperta e smagliante”, la ribellione e soprattutto il costante ricorso alle immagini: “Ora nessuno più di lui ha bisogno – ed è una dote rarissima – di ricorrere al mondo delle imagini per esprimervi un’idea, per magnificare una sua concezione. E queste imagini non sono comuni – ma d’una bellezza nuova; esse hanno l’impronta dell’ orribile e del grandioso della Natura tanto che paiono le cose abituali viste attraverso una lente misteriosa”.




























































