(continuazione)
di Antonio Lucio Giannone
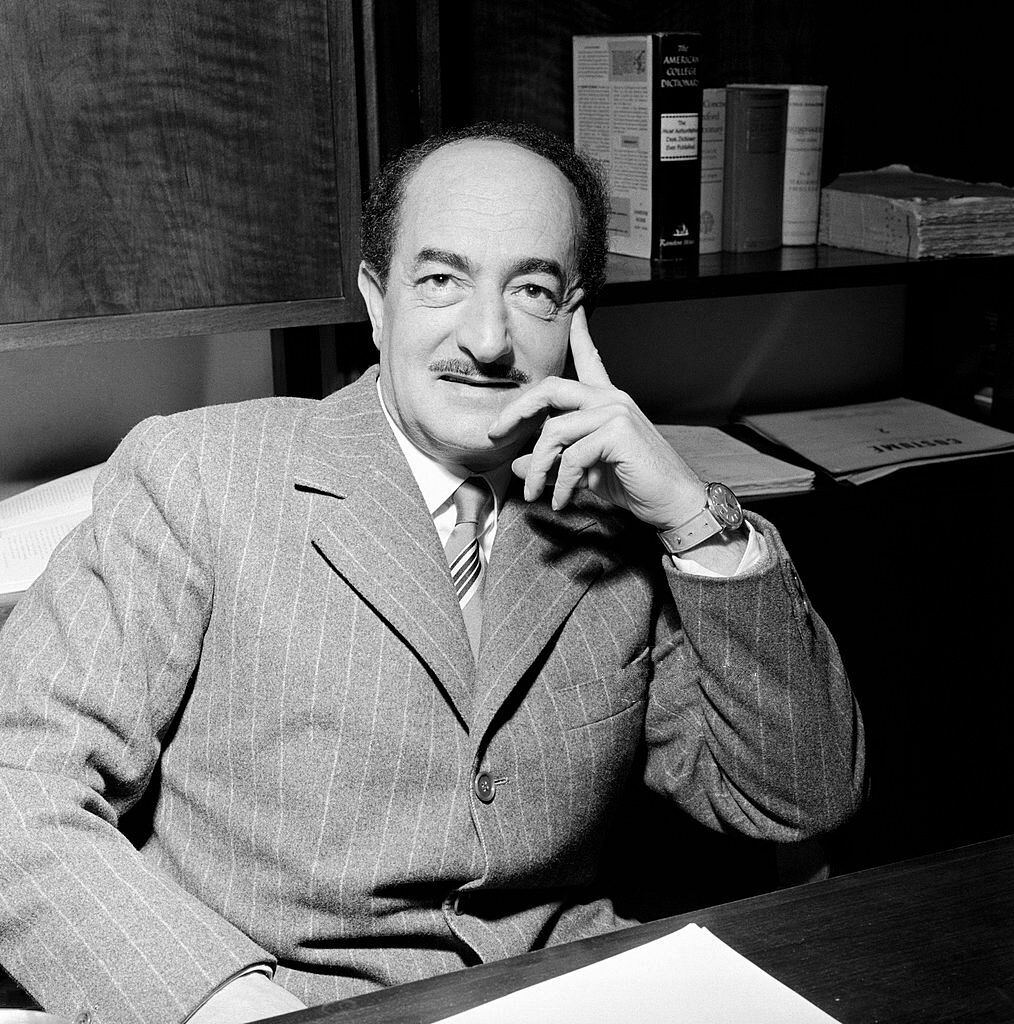
Ma la decisa presa di posizione di Bodini nella recensione all’antologia di Anceschi-Antonielli non poteva non provocare la risposta di Oreste Macrì, il quale, in un articolo apparso su «Letteratura», accusò senza mezzi termini i due antichi compagni di defezione, di essere fuggiti cioè dalle file dell’ermetismo, a cui avevano partecipato, sia pure in maniera diversa, entrambi e respingeva come «una considerazione provincialistica della poesia»[1] la distinzione bodiniana di due linee geografiche all’interno della corrente ermetica, attribuendola proprio all’ «errata e confusa visione storico-letteraria»[2] del «suo maestro»[3] Quasimodo.
A Macrì replicò Bodini sul numero 3-4 con un intervento durissimo, non privo di «punte di feroce ironia e di impietoso attacco personale»[4], contestando in particolare, stavolta apertamente, la teoria delle generazioni, in nome della quale i poeti dovevano «obbedienza ideale a quelle sue classificazioni, pena l’accusa di tradimento per chiunque prenda strade che possano smentirle. Da ciò il veleno contro Quasimodo, che egli si affanna a colpire attraverso me»[5]. E proprio il poeta siciliano, a questo punto, diventa l’oggetto principale di dibattito e di contesa in un certo senso, sentendosi Bodini accomunato a lui nell’accusa di tradimento rivolta da Macrì:
«Non sentiamo davvero il bisogno di difendere Quasimodo, poiché le ragioni per le quali il Macrì lo attacca sono esattamente le stesse per le quali ci sentiamo in debito con lui, e cioè il generoso disinteresse con cui, essendo dei pochissimi che avevano da perdere, non ha esitato a accantonare posizione e carriera letteraria, mostrando che la poesia non è conservazione e rendita, ma totale impegno umano. Se Macrì non si fosse assunto il compito di fare il cane da pastore del gregge ermetico, inseguendo e abbaiando contro chi pecora non è, e ha diritto a seguitare la propria strada, avrebbe potuto accorgersi di quanto fosse naturale e coerente in Quasimodo il trapasso dalla pietà pei suoi oggetti a una partecipazione umana che vale assai più delle squallide bandiere dell’Assenza, sdegnate persino dai venti»[6].






























































