di Giovanni Leuzzi
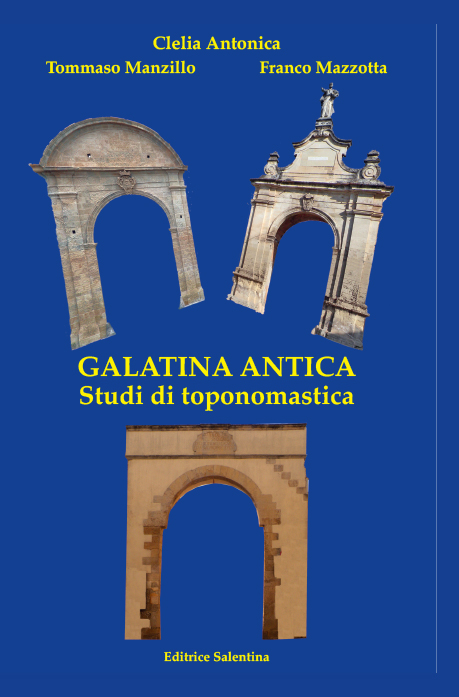
Nessuno può dubitare che, nel campo delle scienze storiche, la toponomastica è disciplina importantissima per le informazioni che essa può fornire non solo sulla storia e geografia dei territori, ma anche, e sono queste recenti acquisizioni metodologiche, sulle caratteristiche dell’ambiente, del paesaggio, sulle antiche attività economiche e perfino sulle connotazioni archeologiche dei luoghi. Da ciò la necessità di approfondire la conoscenza e la corretta interpretazione dei toponimi, che sono, come scriveva il grande filologo greco Antonios Miliarakis (1841-1905), “delle iscrizioni incise nel suolo”. Essi spesso costituiscono l’unica impronta topografica di siti, presenze e luoghi scomparsi non solo dalle carte, ma anche dalla memoria collettiva.
Anche per questa esigenza di correttezza rimane scolpita nella mia memoria l’avvertenza che il nostro Gerhard Rohlfs ci consegna nella premessa del suo Dizionario Toponomastico del Salento, pubblicato a Ravenna da Longo Editore nel 1986, lo stesso anno della morte del grande “archeologo della parola”, laddove Egli scrive: “La spiegazione storica dei toponimi (spesso diventata dominio di dilettanti) è difficilissima scienza”. E, più avanti, nella constatata impossibilità, nonostante ogni sforzo interpretativo, di arrivare per molti toponimi a congetture plausibili, umilmente confessa che “… nel continuo conflitto tra il certo, il probabile e l’ipotetico, alla formulazione di una vana e fantasiosa immaginazione ho preferito spesso un più prudente ignoramus, rassegnandomi ad un semplice elenco dei toponimi senza un commento, lasciandoli come problemi da risolvere ad ulteriori studi ed a futuri ricercatori”.




























































