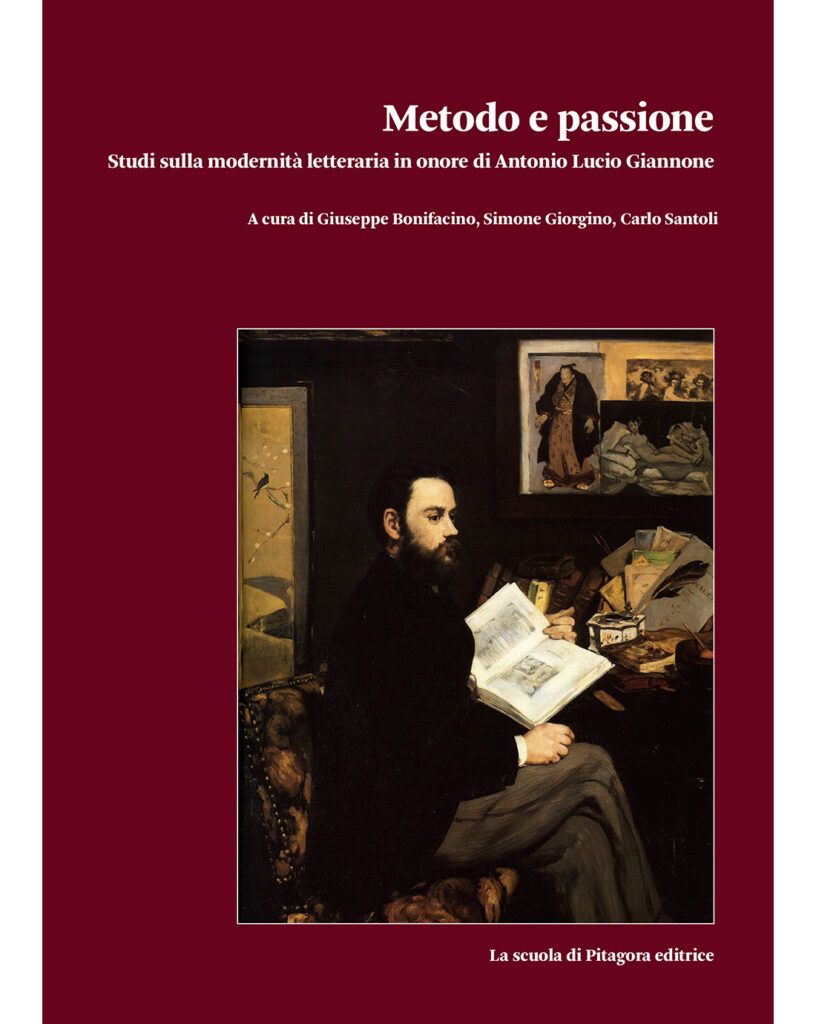Maggio – agosto, 1860
Un anno dopo, tra la tarda primavera e l’estate del ’60, l’entusiasmante liberazione del sud Italia da parte di Garibaldi ispirò un gruppo di sei lettere. Infatti, tredici tra i sessantacinque uomini sbarcati in Irlanda con Castromediano nel ’59, nel maggio dell’anno successivo si sarebbero uniti alla spedizione garibaldina in Sicilia. Uno di loro, Achille Argentino, scrisse a Castromediano da una Palermo devastata dalla guerra poco dopo che le forze di Garibaldi avevano preso possesso della città. Riferiva di star bene, e come lui anche Domenico Damis, Braico e “altri che tu conosci” (probabilmente un riferimento, quest’ultimo, ad altri prigionieri deportati) ma che un altro componente del loro gruppo, Stanislao Lamenza, era caduto in battaglia[2]. Sappiamo da ulteriori fonti che Castromediano utilizzò alcune di queste lettere (nello specifico quelle inviate da Damis e Braico dai campi di battaglia) per scrivere resoconti dell’invasione di Sicilia per il quotidiano torinese L’Opinione. Di tali articoli, inoltrò copie ad alcuni amici, accompagnandoli con altri esempi di pezzi giornalistici sia italiani che stranieri. Castromediano potrebbe anche aver cercato di influenzare l’opinione pubblica britannica attraverso traduzioni inglesi dei suoi pezzi di opinione su questioni italiane ed internazionali[3]. Come sosterrò a breve, questo costante impegnarsi con amici e politici britannici è alla base del suo primo tentativo di pubblicare un memoriale di prigionia.
Le imprese garibaldine dell’estate del 1860 ebbero eco globale. Nicola Schiavoni, uno dei pochi prigionieri deportati rimasti a lungo Inghilterra, scrisse a Castromediano da Londra nel tardo giugno di quell’anno, ricordandogli di come i loro amici in Irlanda, che tanto avevano fatto per accoglierli ed assisterli un anno prima, desiderassero ricevere le ultime notizie dalla Sicilia. Nella lettera, seguendo un ordine che non appare certo casuale, Schiavoni passava dal parlare della sua simpatia personale per amici di Cork all’importanza strategica del supporto politico britannico per l’unificazione italiana, per finire discutendo il comportamento più o meno ammirevole di certi ex compagni di prigionia napoletani. “Mi sono convinto,” scrisse, “che nessuno di quei che abbiamo conosciuto siano maggiori di noi per animo”. Nello specifico, in questo passaggio, sembra che Schiavoni confronti gli uomini rilasciati dalle prigioni di Montesarchio con quelli liberati da altre carceri napoletane, i quali sia Schiavoni stesso che Castromediano avevano conosciuto durante la deportazione del ’59. A Londra, continuava Schiavoni, si diceva che uno di questi, Silvio Spaventa, fosse un uomo pieno di sé[4]. Nisco sollevò una preoccupazione più ampia: in una lettera a Castromediano inviata da Firenze nel tardo maggio di quell’anno, espresse il proprio disgusto per gli esuli napoletani che, lì nel capoluogo toscano, attaccavano uomini rispettabili per darsi arie da rivoluzionari radicali[5]. Come si evince da queste lettere, dunque, la caduta del regime borbonico nel sud Italia non fu solo causa di celebrazioni, neanche tra le più famose vittime del regime stesso.
Dicembre 1860 – maggio 1861
L’ultimo gruppo di dieci lettere del mio campione ruota attorno all’elezione di Castromediano al Parlamento, avvenuta nel gennaio del 1861, e alla transizione in Puglia dal governo borbonico a quello liberale. I mittenti di gran parte di queste lettere sono Schiavoni e Leone Tuzzo, imprigionati con Castromediano a Lecce nell’autunno del ’48 e con lui processati due anni più tardi. A differenza di Castromediano – il quale si recò a Napoli nell’autunno del ’60 ma rimandò il suo rientro a Cavallino e Lecce – Schiavoni e Tuzzo rientrarono a casa e guidarono l’impegno locale nell’elezione di una lista di moderati liberali: i primi rappresentanti parlamentari per la Puglia. Proposero nomi di uomini che, senza eccezioni, erano stati bersagli della repressione borbonica a seguito dei moti del ’48, tra cui tre prigionieri (Castromediano, Schiavoni e Braico) e numerosi esuli. Le lettere inviate a Castromediano esprimono sollievo per i risultati – in larga parte positivi – delle elezioni, ma tradiscono disappunto a seguito di sviluppi negativi nella vita politica della regione. C’erano i mazziniani – un problema prevedibile – ma c’era anche una schiera di individui corrotti e senza scrupoli, i quali cercavano di accaparrarsi posizioni di potere ricorrendo persino alla calunnia di patrioti rispettabili. Tuzzo era poi esasperato dalle manovre ordite contro di lui da nemici politici, i quali gli impedivano di ottenere un incarico amministrativo a Lecce. Fece dunque appello al passato di sofferenza condivisa con Castromediano: “La mia vita logora tra le galere è un fatto, che pochi possono vantare” [6]. Fu proprio in quel periodo che anche Lopresti sollevò una lamentela simile a Castromediano in quanto “compagno di sfortuna”.
Cosa ci dicono, nel complesso, questi tre momenti e i relativi gruppi di lettere sulla relazione di Castromediano con gli altri prigionieri e sul suo approccio alla stesura di un memoriale carcerario? Per rispondere alla domanda, è necessario guardare oltre i sessantanove individui del mio campione di ricerca, e oltre all’archivio Castromediano stesso; è necessario prendere in esame ulteriori fonti, sia edite che inedite. In primo luogo, dobbiamo considerare la personalità di Castromediano al tempo dei suoi primi anni dopo il rientro in Italia, e per tale indagine non esiste fonte migliore che la sua corrispondenza – intima e voluminosa – con le donne di casa Savio, famiglia parte dell’élite torinese: madre e figlia, Olimpia e Adele. Tra la primavera del ’59 e quella del ’61, Castromediano si innamorò di Adele. Il rifiuto dei genitori alla sua proposta di matrimonio lo aveva devastato; il suo sogno d’amore s’era rivelato senza speranze già agli inizi della primavera del ’60. Poi, nell’estate e autunno di quell’anno, la liberazione del meridione e i preparativi per le prime elezioni parlamentari dell’Italia unita lo avevano aiutato a distrarsi. Ma una vena di malinconia è sempre riscontrabile nelle sue lettere a Olimpia e Adele Savio degli anni 1859-1861.
L’amore non corrisposto non fu l’unica fonte d’infelicità per Castromediano. Nel settembre del ’59, ben prima che la sua proposta di matrimonio fallisse, si era aperto a Olimpia Savio confessandole in lettera i suoi rancori e i suoi dolori; o per meglio dire, le angosce da ex prigioniero che fatica a riadattarsi alla libertà. Le catene e le segrete per le quali era passato lo avevano privato delle illusioni di gioventù e lo avevano restituito alla società profondamente intollerante verso la superficialità, sia da parte di uomini che di donne. Dubitava persino della sincerità del pubblico internazionale – il cosiddetto “mondo civilizzato” – che si era precipitato a celebrare lui e i suoi compagni la primavera precedente.
“L’Irlanda e l’Inghilterra ci festeggiarono al pari dei principi, quella coll’entusiasmo del cuore, questa con quello della mente. Eppure il crederebbe? Fra quelle accoglienze, tra quelli applausi, tra quelle feste v’era un certo che il quale m’umiliava, il quale mi metteva in sospetto della sincerità delle dimostrazioni – vo’ dire il calcolo e la curiosità colle quali ogni cosa ci si prodigava – l’essere divenuti spettacolo altrui, moda, cosa nuova venuta dall’Asia o dall’America, come prestigio di giocoliere, ove tutti seguon la calca per soddisfare un futile piacere, o anche per imitare l’esempio di chi prima accorreva”[7].
Dieci mesi dopo, Castromediano scrisse a Michele Pironti, spiegandogli i motivi del suo fastidio nei confronti del trattamento dei prigionieri in Gran Bretagna. Pironti era stato uno di quei prigionieri il cui cattivo stato di salute aveva impedito la deportazione per mare nell’inverno del ’59. Castromediano tentò di chiarirgli vantaggi e svantaggi dello sbarco in Gran Bretagna: da un lato, aveva formato amicizie durature con potenti personaggi politici come William Gladstone e Lord John Russell – uomini il cui supporto politico per l’Italia si era rivelato cruciale – e dall’altro aveva incontrato delle difficoltà a ottenere il supporto inglese. Sbarcati in Inghilterra, infatti, Castromediano e gli altri si erano resi subito conto che l’appoggio ricevuto “non era che entusiasmo diretto alle nostre persone”; e per quanto riguardava l’Italia, “gli inglesi nulla capivano e di nulla volevansi impacciare, non essendo informati né dei nostri diritti, né dei nostri bisogni, né intendevano i desideri e le necessità di una Italia grande e forte!”[8].
Per Castromediano, il rapporto ambivalente col pubblico britannico e l’élite politica ebbe un ruolo fondamentale anche nei primi approcci alla stesura del suo memoriale di prigionia. Nel marzo del 1859, ad appena dieci giorni dallo sbarco a Queenstown, Castromediano pubblicò una lunga narrativa (o se vogliamo un breve memoriale) sul Southern Reporter and Cork Commercial Courier. Un esperimento che decenni dopo il nostro liquidò come scritto male e tradotto peggio, seppur riconoscendo che fu ben accolto dai lettori inglesi e ristampato a Londra come pubblicazione seriale. Ovunque andasse trovava copie del suo scritto, persino in casa di Gladstone[9]. Tuttavia, è importante ricordare che l’accoglienza britannica nei confronti dei prigionieri non era stata né immediata né priva di equivoci. Sebbene molti quotidiani inglesi espressero apertamente il proprio supporto per gli esuli napoletani a pochi giorni dal loro sbarco in Irlanda, ci furono articolisti che criticarono l’uso della forza esercitata per impossessarsi della nave mercantile americana David Stewart, ingaggiata dal governo borbonico per trasportare i detenuti da Cadice a New York. A peggiorare le cose, si era sparsa la voce che il capitano della nave, Samuel Prentiss, descrivesse il dirottamento come parte di una cospirazione mazziniana[10]. Infine, il supporto degli inglesi ai prigionieri in fuga andava di pari passo con l’avversione diffusa nei confronti dei Borboni. Per questo fu inevitabile che i racconti dei prigionieri, non solo della loro fuga per mare ma anche e soprattutto della loro prigionia, riaprissero il dibattito già avviato dal celebre pamphlet di Gladstone del ’51, Two Letters to Lord Aberdeen, sulla fondatezza o meno dell’infame reputazione di cui godeva il governo borbonico[11]. La domanda implicita che aleggiava sulle pagine dei quotidiani inglesi che trattavano i prigionieri liberati era sempre la stessa: possiamo credergli? Fu questo il contesto in cui Castromediano scrisse la prima versione del suo memoriale.
In proposito della crudeltà del regno borbonico, l’articolo di Castromediano sul Southern Report non lasciava margini per dubbi o dibattiti. Riprendeva il discorso lì dove l’aveva lasciato il pamphlet di Gladstone, con il racconto di ciò che era accaduto dopo il 1851, quando le autorità avevano trasferito un gruppo di prigionieri politici di alto profilo nelle remote prigioni collinari di Montefusco e Montesarchio. In Gran Bretagna, all’epoca, queste prigioni facevano notizia, e Castromediano raccontò ai suoi lettori delle crudeltà che lui e i suoi compagni vi avevano subito. Erano stati maltrattati fisicamente, continuamente perquisiti e tenuti sott’occhio, separati dai famigliari, esposti al clima e abbandonati a morire durante l’epidemia di colera del 1855. La sequenza di episodi ben dettagliati occorsi tra il ’52 e il ’58 occupava ben tre colonne del Southern Report e aveva una lunghezza complessiva di circa tremila parole, ossia l’equivalente di otto o nove pagine del memoriale che Castromediano avrebbe pubblicato al termine della sua vita. Un catalogo completo dei “fatti e delle sofferenze” – scrisse nell’incipit del suo pezzo – “avrebbero riempito un volume”. È allettante tracciare una linea diretta tra queste affermazioni del ’59 e la potente apertura del memoriale che Castromediano infine pubblicò nel 1895: “Dal primo metter piede nelle carceri di Lecce nacque in me l’idea di scrivere queste memorie, e fin d’allora promisi, colà, ai miei compagni, d’esser lo storico dei loro dolori”[12].
In almeno un’occasione, Gladstone consigliò a Castromediano di moderare i toni del suo memoriale (che sia già in fase di scrittura o anche solo di progettazione). In una lettera dell’8 giugno 1859, spiegava che sebbene nessuno in Inghilterra avrebbe obiettato ad una “narrazione calma e imparziale delle sofferenze dei prigionieri napoletani” un pezzo “scritto con una veemenza pari – ad esempio a quella dei miei scritti sullo stesso” avrebbe invece potuto danneggiare la causa degli ex prigionieri[13]. Gladstone non si soffermò sull’ironia del consiglio; la sua mente politica gli suggeriva che seppure nel ’51 era stato opportuno per un conservatore britannico come lui scagliarsi contro il governo napoletano, nel ’59 non era il caso di far apparire le vittime di quello stesso governo come rivoluzionari vendicativi. Non ci fu bisogno d’aggiungere altro. Castromediano comprese che lo spettro della rivoluzione repubblicana poteva costare all’Italia il supporto internazionale necessario al raggiungimento dell’indipendenza.
Come reagì Castromediano al consiglio di Gladstone? La necessità di compiacere o rassicurare i lettori britannici influì sulla sua idea di ciò che il suo memoriale avrebbe potuto o dovuto ottenere? In Carceri e galere politiche, Castromediano attribuì all’inglese il merito di averlo incoraggiato a scrivere. Inoltre, la sua corrispondenza con la famiglia Savio dimostra che in origine sperava di pubblicare il memoriale proprio in Inghilterra. C’è naturalmente il caso che i motivi di tale speranza fossero economici; Castromediano puntava ad accrescere le proprie entrate in un momento della sua vita in cui cercava di passare da un buon partito davanti ai genitori di Adele Savio. Ma pare altrettanto probabile che i motivi fossero invece esclusivamente patriottici, ovvero assicurarsi il supporto inglese per la causa italiana, rammentando agli influenti lettori inglesi il perché il regime napoletano meritasse di cadere[14]. Negli anni successivi, nonostante il fiasco dei suoi propositi matrimoniali, Castromediano incaricò Adele di tradurre le numerose lettere e gli articoli di giornale che continuava a ricevere dagli amici britannici. Manca tuttavia la prova che le abbia anche proposto un incarico più impegnativo, come la traduzione completa del suo memoriale. Infatti, nel corso degli anni ’60, il proposito di pubblicare il memoriale in inglese andò a poco a poco a morire[15]. Quello che infine pubblicò nel 1895-96 non porta tracce di un testo redatto per compiacere il pubblico britannico, ma riflette piuttosto la risolutezza di Castromediano nel redigere un volume che porti le prove della sofferenza subita dai suoi compagni di cella.
Tra le caratteristiche di Carceri e galere politiche c’è l’indifferenza del suo autore nei confronti della politica internazionale. Così come Garcea, Palermo e Settembrini prima di lui, Castromediano terminò il suo memoriale con quello che lui stesso definì il “romanzesco episodio” della fuga dei prigionieri per mare nel 1859 e la calorosa accoglienza da questi ricevuta in Gran Bretagna[16]. Tuttavia, il punto di vista centrale del memoriale – ben stabilito nel corso delle prime 450 pagine – è quello di una solitudine opprimente. In un’occasione, a seguito del suo interrogatorio a Napoli, Castromediano riuscì a riportare ai suoi compagni di cella le ultime notizie di politica internazionale; ma momenti come questo di contatto con la realtà esterna sono rari, e interrompono a malapena la meditazione dell’autore sugli effetti tremendi di una detenzione prolungata. La maggior parte degli “avvenimenti” riportati nel memoriale riguardano incidenti apparentemente minori, descrizioni di punizioni crudeli e sofferenze personali che mantengono solo un legame flebile e vago con ciò che accadeva nel mondo esterno. Il messaggio implicito che Castromediano voleva trasmettere ai suoi lettori era il seguente: ciò che Gladstone aveva scritto nel 1851, ciò che la stampa straniera aveva riportato nel corso degli anni ’50, e persino ciò che alcuni compagni di prigionia avevano scritto nelle loro memorie non era tutta la storia.
Entrando nell’archivio Castromediano, mi aspettavo di rinvenire fonti precise sul come l’autore avesse scritto il proprio memoriale, e in particolare più esempi del suo sforzo di raccogliere informazioni dai prigionieri salpati con lui da Napoli a Queenstown. Mi resi presto conto di aver commesso un errore strategico. Castromediano probabilmente si era annotato fatti chiave su questi uomini non appena sbarcato in Irlanda. Lo suggerisce lui stesso nel memoriale in coda al profilo di Vito Porcaro, un prigioniero incontrato per la prima volta a bordo della nave da guerra napoletana Stromboli, nel gennaio del 1859. I dettagli della tortura subita da Porcaro nella prigione di Santa Maria Apparente, a Napoli, “non son cose queste che lessi nei libri o appresi da documenti; ma mi furono ripetute dallo stesso Porcaro”[17]. Tuttavia, non appena ho messo da parte le aspettative iniziali e ho iniziato a consultare l’archivio, mi sono imbattuto in ulteriori lettere spedite da ex prigionieri. Non sorprende che molte provenissero da vittime della repressione governativa di Lecce a seguito del ’48, da parte di uomini che avevano perso i contatti con Castromediano durante gli anni ’50 ma che avevano poi cercato il suo aiuto non appena questi era tornato alla ribalta come candidato in Parlamento. Questi uomini – umili prigionieri – erano sfuggiti all’attenzione di Gladstone, impegnato nella preparazione del suo Letters to Lord Aberdeen nel 1851, nonché a quella di numerosi giornalisti, ma avevano ispirato Castromediano a diventare uno “storico dei loro dolori”.
Non appena si avviò la campagna elettorale per il Parlamento nel dicembre 1860, amici e conoscenti da Lecce e dintorni presero a scrivere a Castromediano, raccontandogli persecuzioni subite e i tentativi vani di trovare un impiego dopo la caduta della monarchia borbonica. Due di queste lettere provenivano da uomini che avevano con lui condiviso il carcere a Lecce per diversi mesi tra il 1850 e il 1851, a seguito della loro attività rivoluzionaria nella cittadina di Oria. Nel gennaio del ’61, Luigi de Angelis scrisse a Castromediano: “Caro Duca, in questa lettera vi dirò tutta la mia vita politica, ed i miei patimenti”. E seguitava a raccontare tre anni di latitanza, quattro di prigione, uno e mezzo di esilio in tre città differenti, nonché perquisizioni settimanali e ancora latitanza. Sei mesi più tardi, in un’altra lettera, Salvatore Calcagni faceva leva in modo più marcato sul suo legame con Castromediano in quanto “ex-compagno di sventura nell’orrido Carcere Centrale di Lecce”. Anche Calcagni aveva perso i contatti con Castromediano negli anni ’50 tra latitanza, prigione ed esilio in altre città italiane, ma sperava che il tempo condiviso dietro le sbarre fosse sufficiente a “rinnovare i nostri fraterni legami, ed unire i nostri cuori”[18]. La maggior parte di queste lettere culmina in dolorose confessioni sulla disperata necessità di trovare un impiego. Una, inviata da Raffaele Albanese nel maggio del ’61, apriva “Signor Duca gentilissimo, Non sapendo qual via trovare per tirare innanzi la vita, mi dirigo a Lei, sapendo il suo amore e la sua generosità fin da quando eravamo insieme in carcere nelle Centrali. La mia famiglia è numerosa, e le persecuzioni ci han lasciato la miseria”[19]. Fu proprio in questo periodo che anche Lopresti gli chiese aiuto. I “compagni di sfortuna” di Castromediano erano molti e sparsi ovunque, e non esitavano a scrivere delle loro difficoltà. Tali appelli certamente diminuirono quando Castromediano lasciò il parlamento nel 1865, ma non cessarono del tutto[20].
Tra le centinaia di lettere che Castromediano ricevette tra l’inverno e la primavera del ’61, ve ne sono due di Francesco Saverio De Julio, il quale era stato cappellano nel carcere di Montefusco dal marzo 1853 al giugno 1854. La prima di queste, datata 4 febbraio 1861, rende esplicito il fatto che Castromediano aveva richiesto informazioni sull’amministrazione di Montefusco per includerle nel memoriale. La seconda, 17 marzo 1861, è una lunga e dettagliata risposta a una lettera Castromediano, la quale conteneva domande specifiche su una serie di questioni, come ad esempio sulla successione dei guardiani e sulla catena di comando della prigione, nonché sugli individui responsabili per le punizioni aggiuntive inflitte a lui e ai suoi compagni. De Julio aveva perso il suo incarico per essersi opposto ai maltrattamenti nei confronti dei detenuti, ma a quanto pare aveva continuato a vivere a Montefusco. Tra il novembre del ’60 e il febbraio del ’61, Castromediano lo invitò a casa di Poerio a Napoli per raccogliere ulteriori informazioni sulla sua attività di cappellano carcerario. In cambio, De Julio gli chiese una copia del suo “libretto”, quando questo fosse stato pronto[21].
Nel loro insieme, le lettere ricevute da Castromediano solo nel 1861 rispecchiano lo spirito del memoriale che avrebbe pubblicato poco prima della sua morte, trentaquattro anni più tardi. Lettere che contengono slanci d’indignazione, confessioni struggenti, resoconti dettagliati di malattie devastanti e distruzioni di intere esistenze, e che al tempo stesso sono documenti di prima mano sulla crudele amministrazione carceraria dei Borbone. Ulteriori ricerche nell’archivio Castromediano chiariranno senza dubbio come e quando l’autore raccolse le informazioni sugli altri prigionieri e sulle condizioni e amministrazioni delle carceri che compaiono nel memoriale. E, se avremo fortuna, sarà Antonio Lucio Giannone ad occuparsi dell’argomento.
Tradotto dall’inglese da Dario Marcucci, City University of New York
[Questo saggio è stato pubblicato per la prima volta, in inglese, col titolo nel Primo tomo del vol. Metodo e passione. Studi sulla modernità letteraria in onore di Antonio Lucio Giannone,Napoli, La Scuola di Pitagora, 2022, pp. . L’autore, Steven Soper, è professore di Storia dell’Europa moderna presso l’Università della Georgia (USA)]
Appendice I
Presenza o assenza dei 69 ex-prigionieri nella sezione Corrispondenza dell’Archivio Sigismondo Castromediano di Lecce.
Giuseppe Abbagnale, Filippo Agresti, Michele Aletta, Achille Argentino, Felice Barilla, Francesco Bellantonio, Ferdinando Bianchi, Domenico Bozzelli, Cesare Braico, Michelangelo Calafiore, Raffaele Crispino, Vincenzo Cuzzocrea, Domenico Damis, Carlo De Angelis, Camillo De Girolamo, Francesco De Simone, Giuseppe Del Drago, Domenico Dell’Antoglietta, Vincenzo Dono, Antonio Esposito, Giustino Faivano, Filippo Falconi, Salvatore Faucitano, Gregorio Filace, Antonio Garcea, Rocco Geraci, Achille Grilli, Stanislao Lamenza, Emilio Maffei, Pietro Marrelli, Gaetano Mascolo, Raffaele Mauro, Ignazio Mazzei, Stefano Mollica, Pasquale Montani, Rocco Morgante, Antonio Nicolò, Tommaso Notaro, Giuseppe Pace, Nicola Palermo, Girolamo Palumbo, Luigi Palumbo, Luigi Parente, Carlo Pavone, Angelo Pellegrini, Giuseppe Maria Pessolani, Emilio Petrucelli, Giuseppe Pica, Raffaele Piccolo, Carlo Poerio, Luigi Praino, Francesco Procenzano, Vito Purcaro, Giambattista Ricci, Raffaele Ruocco, Angelo Salsa, Nicola Schiavoni, Ovidio Serino, Luigi Settembrini, Filadelfo Sodano, Francesco Surace, Silvio Spaventa, Raffaele Travia, Giuseppe Tripepe, Aniello Ventre. PLUS: Domenico Lopresti, Nicola Nisco, Michele Pironti, Leone Tuzzo.
Doppio grassetto = Individui che scrissero una o più lettere a Castromediano dopo il loro rilascio.
Grassetto = Individui che, sebbene non abbiano scritto a Castromediano, sono citati in una o più lettere di ex prigionieri esaminate nel mio campione.
Caratteri standard = Individui che non compaiono come mittenti e che non vengono citati.
Appendice II
Tre gruppi di lettere inviate da ex prigionieri a Sigismondo Castromediano
- aprile-luglio 1859. Lettere da: Vincenzo Dono (6), Nicola Nisco (3*), Nicola Schiavoni (1) e Giuseppe Pace (1). * Una tra le lettere di Nisco non riporta la data, ma fa riferimento al suo recente rilascio e viene spedita da Torino. Il che fa pensare che Nisco l’abbia inviata nell’aprile o nel maggio del 1859. Queste lettere fanno riferimento ai seguenti ex prigionieri presi in esame nel mio campione: Domenico Lopresti, Carlo Poerio, Cesare Braico, Stefano Mollica, Ovidio Serino, Luigi Palermo, and Silvio Spaventa.
- maggio-agosto 1860. Lettere a Castromediano da: Nicola Nisco (3), Achille Argentino (1), Stefano Mollica (1), e Nicola Schiavoni (1). Queste lettere fanno riferimento ai seguenti ex prigionieri presi in esame nel mio campione: Carlo Poerio, Cesare Braico, Domenico Damis, Stefano Lamenza, Silvio Spaventa, Carlo De Angelis, and Giuseppe Pica.
- dicembre 1860-marzo 1861. Lettere a Castromediano da: Leone Tuzzo (5), Nicola Schiavoni (4), e Domenico Lopresti (1). Queste lettere fanno riferimento ai seguenti ex prigionieri presi in esame nel mio campione: Cesare Braico, Carlo Poerio, and Giuseppe Pica. Cinque lettere non datate – tre da Schiavoni, una da Argentino e una da Braico – potrebbero essere state inviate a Castromediano in questo periodo.
Appendice III
Lettera di Domenico Lopresti a Sigismondo Castromediano. Reggio Calabria, 13 febbraio 1861. Archivio Castromediano-Gorgoni, Lecce.


[1] La frustrazione di Vincenzo Dono nei riguardi di Poerio traspare soprattutto in due lettere, entrambe spedite da Firenze e datate 14 maggio 1859 e 27 maggio 1859. PAC-G. Corrispondenza, n. 233 e 238. Da parte sua, Poerio era esasperato da Dono e da altri beneficiari insoddisfatti del fondo per gli esuli napoletani. Cfr. La lettera al direttore della commissione responsabile del fondo, Antonio Panizzi, inviata da Poerio da Torino a Londra il 3 giugno 1859. Carte di Panizzi. British Library. MS 36719. Per le altre nove lettere di questo gruppo, si veda l’Appendice II.
[2] Lettera di Achille Argentino a Sigismondo Castromediano. Palermo, 8 giugno 1860. PAC-G. Corrispondenza, n. 290. Varianti del cognome Lamenza compaiono come La Menza e Lamensa, quest’ultima usata da Argentino nella sua lettera. Per le altre cinque lettere di questo gruppo, cfr. Appendice II.
[3] Per l’utilizzo di Castromediano delle lettere di Damis e Braico in Sicilia, si veda la sua missiva a Olimpia Savio del 10 giugno 1860, in Marcellan (ed.), Cara Adele, caro Sigismondo, p. 79.
[4] Lettera di Nicola Schiavoni a Sigismondo Castromediano. Londra, 24 giugno 1860. PAC-G. Corrispondenza, n. 295.
[5] Lettera di Nicola Nisco a Sigismondo Castromediano. Firenze, 23 maggio 1860. PAC-G. Corrispondenza, n. 287. Nisco scrisse ancora a Castromediano a fine agosto, da Londra. Al tempo, lavorava fianco a fianco con il Conte Camillo Benso di Cavour per assicurare il controllo piemontese di Napoli prima che vi arrivasse Garibaldi con le sue truppe. Nella sua lettera del 23 agosto, 1860, Nisco riferisce a Castromediano che la situazione a Napoli è buona: “i Reazionari sono avviliti: la Guardia Nazionale è messa su”. PAC-G. Corrispondenza, n. 300.
[6] Lettera di Leone Tuzzo a Sigismondo Castromediano. Lecce, 3 marzo 1861. PAC-G. Corrispondenza, n. 494. Per le altre nove lettere del gruppo, cfr. Appendice II.
[7] Lettera di Sigismondo Castromediano a Olimpia Savio. Torino, 20 settembre 1859, in Marcellan (ed.), Cara Adele, caro Sigismondo, cit., p. 19.
[8] Lettera di Sigismondo Castromediano a Michele Pironti. Torino, 13 luglio 1860, in Carolina Pironti, “Carlo Poerio e Sigismondo Castromediano: Lettere inedite,” Nuova Antologia, Vol. 157, f. 962 (16 gennaio 1912), p. 322.
[9] Lo scritto di Castromediano comparve alle pp. 2-3 dell’uscita del 16 marzo 1859 del Southern Reporter and Cork Commercial Courier sotto l’intestazione “To the Editor of The Daily Reporter.” Fu poi ampiamente ristampato su altre pubblicazioni, tra cui il londinese Morning Post del 21 marzo 1859. Ad oltre un mese dalla sua prima uscita a Cork, venne poi ancora ristampato, ad esempio il 28 aprile 1859 sullo Stirling Observer. Lo stampatore londinese G. Abington colse l’occasione di pubblicarlo in un’edizione a sé dal titolo Horrors of Neapolitan Dungeons. La pubblicità per quest’uscita comparve sul London City Press per settimane, a partire dal numero del 26 marzo 1859. Ho ottenuto questi dati attraverso una ricerca effettuata con diverse parole chiave, includendo variazioni ed errori ortografici (e.g., “Cabel” e “Cabellino” al posto del termine standard per il titolo di Castromediano, Duca di Caballino) sull’archivio britannico digitale per i quotidiani, British Newspaper Archive, www.britishnewspaperarchive.co.uk (10 gennaio 2021). Castromediano racconta i successi di quella pubblicazione in Carceri e galere politiche, Vol. 2, pp. 194-195.
[10] Il giorno dopo lo sbarco a Queenstown, il Cork Examiner riportò l’“opinione” di Prentiss secondo la quale Raffaele Settembrini fosse stato mandato a salvare i prigionieri, tra cui il padre, Luigi Settembrini, dall’“Italian Society in London.” Cork Examiner 7 marzo 1859. Altri giornali di Cork, tra cui il Southern Reporter, accorsero alle difese dei prigionieri, spazzando via le voci che questi fossero “enemies of the Catholic faith” [nemici della fede cattolica]; e assicurando i lettori che per via della loro età e condizione fisica fossero “incapable of using violence towards the captain or crew”
[incapaci di esercitare violenza nei confronti del capitano o della ciurma]
; ribadendo infine il supporto per i prigionieri su diversi giornali londinesi (The Times, The Morning Post e il London Daily News) and nella House of Commons. Vedi Cork Constitution, 8 marzo 1859; Southern Reporter and Cork Commercial Courier, 7 marzo 1859 e 9 marzo 1859.
[11] L’uscita del 9 marzo 1859 del Cork Daily Herald contiene uno scambiato di battute tra un critico del governo napoletano e uno scettico del “all the raw-head-and-bloody-bones stories about the King of Naples.” [tutte le storie da far rizzare i capelli sul regno di Napoli].
[12] “To the Editor of The Daily Reporter”; Castromediano, Carceri e galere politiche, Vol. I, p. 9.
[13] Castromediano, Carceri e galere politiche, Vol. 2, p. 290. Nel memoriale, Castromediano non cita la lettera di Gladstone. Questa compare invece intera nell’appendice creata da Brizio De Sanctis per l’edizione postuma (1896) del secondo e ultimo volume del memoriale. Si riportano di seguito in originale le parole di Gladstone da me citate nel testo: “a calm and dispassionate narration of the sufferings in the prisons of Naples” e “written with heated expressions, for example equal to that of my own writings on this subject”.
[14] Riguardo agli intrecci tra le vicende editoriali in Inghilterra e la corte ad Adele Savio si veda la lettera di Castromediano al suo amico e amministratore delle sue tenute, Pasquale De Meis. Torino, 8 dicembre 1859, in Marcellan (ed.), Cara Adele, caro Sigismondo, pp. 36-38. Grosso modo in quegli anni, Castromediano propose un “Memorandum” all’editore (ed ex esule napoletano) Giuseppe Del Re, nella speranza che questi lo aiutasse a pubblicarlo in un quotidiano inglese. Del Re spiegò che avrebbe avuto bisogno di una traduzione inglese del […] ma che sperava di aiutare Castromediano a rendere questo […] Non è chiaro se il pezzo in questione fosse un estratto dal memoriale o un articolo di opinione sulla corrente situazione politica italiana. Lettera di Giuseppe Del Re a Sigismondo Castromediano. Milano, 20 gennaio 1860. PAC-G. Corrispondenza, n. 277.
[15] Nel giugno del 1865, Olimpia Savio incoraggiò Castromediano a pubblicare il memoriale in inglese, e cinque anni dopo ancora si chiedeva se egli fosse ancora interessato alla cosa. Si veda Marcellan (ed.), Cara Adele, caro Sigismondo, pp. 198, 263.
[16] Castromediano, Carceri e galere politiche, Vol. 2, p. 172.
[17] Castromediano, Carceri e galere politiche, Vol. 2, p. 134.
[18] Lettera di Luigi De Angelis a Sigismondo Castromediano. Oria, 11 gennaio 1861. PAC-G. Corrispondenza, n. 382; Lettera di Salvatore Calcagni a Sigismondo Castromediano. Oria, 24 June 1861. PAC-G. Corrispondenza, n. 619. La lettera di Calcagni è corredata da una nota ricevuta quattro mesi dopo che lo informava che non ci sarebbe stato un ruolo per lui nella Guardia Nazionale di Terra d’Otranto. Il Ministro degli Interni, Marco Minghetti, si occupò del caso di Calcagni in una nota del 9 agosto 1861. PAC-G. Corrispondenza, n. 678.
[19] Lettera di Raffaele Albanese a Sigismondo Castromediano. Lecce, 6 maggio 1861. PAC-G. Corrispondenza, n. 562. Albanese scriverà a Castromediano ancora due volte nel corso del 1861: giugno 13 e dicembre 11.
[20] Nel 1876, un altro ex compagno di prigionia, Nicola Donadio, chiese a Castromediano di aiutare il figlio a trovare una posizione amministrativa nella lotteria di Bari. Donadio chiuse la sua breve lettera così: “Sicuro di fare una tale grazia a chi per bene nove lunghi anni le fu compagno della catena…” Lettera di Nicola Donadio a Sigismondo Castromediano. Bari, 16 febbraio 1876. PAC-G. Corrispondenza, n. 2459.
[21] Lettere di Francesco Saverio De Julio, entrambe da Montefusco, del 4 febbraio e 17 marzo 1861. PAC-G. Corrispondenza, n. 423 e 510. Nella prima missiva, De Julio chiede Castromediano di inviargli una copia del “libretto”. In entrambe le lettere, chiede a Castromediano di estendere i suoi saluti ad alcuni degli altri prigionieri conosciuti a Montefusco, inclusi Poerio, Nisco, Braico, Schiavoni e Pica.
(fine)