Tra tali studiosi, un ruolo di primo piano lo ha svolto Antonio Lucio Giannone, sia attraverso le sue pubblicazioni che dietro le quinte. Nel trittico di saggi dedicati al memoriale di Castromediano, Giannone sostiene con forza l’inclusione di quest’opera accanto a lavori più celebri e celebrati del Risorgimento, quali, ad esempio, Le mie prigioni (1832) di Silvio Pellico e Le ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini (1879-1880)[2]. L’obiettivo principale dello studioso, però, non è la riorganizzazione di vecchi e nuovi canoni letterari, bensì una comprensione più profonda delle dinamiche risorgimentali nel meridione. Giannone è stato il primo a includere Carceri e galere politiche in ciò che egli definisce “un compatto e fondamentale corpus” di memoriali di prigionia nel sud Italia. Tra questi si annoverano quelli di alcuni compagni di cella di Castromediano nelle carceri di Montefusco e Montesarchio: Nicola Palermo, Antonio Garcea e Cesare Braico, i quali pubblicarono le loro memorie. Un quarto ex prigioniero, Nicola Nisco, scrisse proprio di Montefusco e Montesarchio in una storia del regime Borbonico[3]. Nonostante questi resoconti differiscano l’uno dall’altro – Castromediano arrivò persino a rimproverare bonariamente Palermo per aver descritto i fatti “coi colori delle rose”[4] – condividono tutti aspetti significativi. In proposito, Giannone rileva come diversi temi e scene ricorrenti (ad esempio descrizioni dettagliate delle catene dei prigionieri, i pestaggi subiti da Garcea, la visita a Palermo da parte del padre e il tentativo delle autorità di estorcere a Castromediano una richiesta di grazia) siano volti ad enfatizzare il senso di eroismo e abnegazione dei protagonisti, così da trasformare tale corpus di memoriali in una potente epica del Risorgimento meridionale[5].
Con altrettanta perspicacia, Giannone traccia un parallelo tra le memorie di Castromediano e il romanzo di Anna Banti Noi credevamo. Pubblicato nel 1967 con scarso successo di pubblico, Noi credevamo è recentemente tornato alla ribalta a seguito dell’adattamento cinematografico di Mario Martone. Banti romanza la vita di un suo antenato, Domenico Lopresti, nato a Catanzaro nel 1816, imprigionato con Castromediano durante gli anni ’50 e morto a Torino nel 1887. A tutt’oggi, quella di Lopresti rimane una figura semisconosciuta e citata in poche fonti, tra cui l’imponente studio sui prigionieri politici borbonici di Attilio Monaco, uscito quasi un secolo fa[6]. Banti conosceva Lopresti attraverso racconti di parenti e documenti d’archivio ai quali aveva accesso. Tali documenti sono andati perduti, così che rimane difficile stabilire oggi quanto in Noi credevamo sia pure finzione e quando abbia fondamento storico. Tuttavia, ciò che è certo è l’uso creativo che la scrittrice fece del memoriale di Castromediano. Giannone non è stato il primo studioso a tracciare un parallelo tra Noi credevamo e Carceri e galere politiche, ma è stato senz’altro il primo a condurre un’analisi comparatistica dettagliata dei due testi. I risultati di questa analisi sono illuminanti[7].
A prima vista, i parallelismi tra il memoriale di Castromediano e il romanzo di Banti appaiono flebili. Come nota Giannone, Castromediano cita Lopresti solo quattro volte nell’arco delle 560 pagine del suo memoriale, e tra queste, l’unica citazione sostanziale occupa appena sei righe:
“E sarebbe anche colpa non fare almeno un cenno fugace di Lopresti, giovine anch’egli ben educato, colto e distinto. Uscito di galera, fu ritenuto altri sette mesi nelle più malsane ed oscure prigioni di Napoli, tra gli stenti e le privazioni, e corse pericolo di perdervi gli occhi, senza che gli arrecassero soccorso: malattia che lo aveva minacciato anche a Montefusco”[8].
Ma Giannone aggiunge prontamente che il memoriale ha fornito a Banti anche una serie di dettagli narrativi e descrittivi; un aspetto, questo, che chiarisce le ragioni per cui la scrittrice fa di Castromediano “una sorta di deuteragonista” di Noi credevamo[9]. Nel romanzo, Castromediano appare come il miglior amico di Lopresti durante la prigionia, nonostante le loro divergenze politiche. In seguito, usciti dal carcere, negli anni successivi all’unità d’Italia, i due prendono strade diverse, continuando però a condividere un acuto disinganno che arriva a sfiorare un profondo senso di esclusione. Entrambi faticano a dare forma definitiva ai memoriali composti in carcere: Lopresti diffida dell’operazione letteraria che rischierebbe di trasformare un’esperienza degradante in racconto epico, mentre Castromediano sembra incapace di mettere su carta una versione accettabile delle sue memorie.
Il meticoloso studio di Giannone sulla presenza di Castromediano in Noi credevamo si avvia e conclude esaminando le riflessioni di Lopresti sulla memorialistica di prigionia. All’inizio del romanzo, Lopresti solleva dei dubbi sulla sincerità dei memorialisti, e ricorda con rammarico un teso scambio di vedute avuto con il “buon Castromediano.” Intenzionato a comporre un memoriale, Castromediano aveva chiesto a Lopresti di aiutarlo a ricordare “certe circostanze della comune e disumana cattività.” Lopresti gli aveva dato un consiglio schietto: “per parlare di Montefusco e Montesarchio, bisognava raccontar tutto, e non tacere le cose meno onorevoli per noi.” Più avanti, dopo la descrizione di come i due prigionieri avessero stretto un’improbabile ma intensa amicizia dietro le sbarre, Lopresti riconsidera l’episodio con un senso di rimorso ancora più forte. Chiarisce inoltre che l’imbarazzante conversazione alla quale si fa riferimento all’inizio del romanzo era avvenuta a Torino, non molto più tardi della scarcerazione dei due uomini: “E fu allora che, annunciandomi il proposito di scrivere le sue memorie carcerarie, mi pregò di aiutarlo: al che risposi come di sopra ho notato, scoraggiandolo con acri osservazioni”[10].
Da questo episodio emergono due dettagli significativi. Per prima cosa, si evince come Castromediano abbia consultato terzi per redigere Carceri e galere politiche. Al di là della lunga lettera inviata all’editore di un giornale irlandese e pubblicata nel marzo del 1859, la versione composta agli inizi degli anni ’60 è andata perduta. A seguito di ciò, rimane difficile stabilire se Castromediano l’abbia composta affidandosi esclusivamente alla sua memoria o se invece abbia raccolto informazioni aggiuntive da altri, come ad esempio i prigionieri che salparono con lui da Napoli all’Irlanda o gli ex detenuti conosciuti dopo il suo rientro in Italia, tra i quali Lopresti. Né ci è dato di sapere se tali pagine perdute esagerassero le virtù dei prigionieri politici o, per dirla con le parole di Lopresti in Noi credevamo, lasciassero troppo al non detto. Ciò di cui siamo invece certi invece, grazie all’evidenza fornitaci da Giannone, è che la versione del memoriale completata poco prima della morte, nel 1895, attinge alle memorie di Nicola Palermo, pubblicate nei primi anni ’60. Banti, inoltre, suggerisce che le fonti di Castromediano non si limitassero solo alla carta stampata ma includessero anche racconti e ricordi sparsi di altri prigionieri[11].
Il secondo aspetto che emerge dall’episodio succitato è che Castromediano era determinato a ricordare e descrivere fedelmente le prigioni di Montefusco e Montesarchio. Tali luoghi evocativi – le “segrete” e il “castello” – occupavano un ruolo centrale nella copertura della stampa internazionale sulle sofferenze dei prigionieri napoletani negli anni ’50. Tuttavia, proprio la sovrabbondanza di storie sensazionalistiche su prigionieri malandati incatenati in oscuri sotterranei portò inevitabilmente alcuni lettori a chiedersi se la stampa (o addirittura i prigionieri stessi) stesse esagerando riguardo alla crudeltà del governo Borbonico. Esiste la possibilità che Castromediano, con i suoi scritti, volesse rivelare al mondo intero, una volta per tutte, la “disumanità” delle carceri borboniche. Montefusco è inoltre lo sfondo di quello che Giannone definisce “l’episodio centrale” del romanzo di Banti e uno degli eventi più drammatici del memoriale di Castromediano: la sua temporanea uscita di prigione, fatto che portò molti compagni di cella a sospettare che stesse cercando di ottenere la grazia, ossia che volesse usare i suoi contatti da aristocratico proprietario terriero per assicurarsi la libertà e abbandonare i compagni al loro destino. L’episodio è raccontato da Palermo nel suo memoriale. Come sottolinea Giannone, Castromediano polemizzò con la versione raccontata da Palermo. Per ironia della sorte, proprio alla luce dello scambio tra Castromediano e Lopresti in Noi credevamo riportato poco sopra, ciò che infastidì Castromediano fu il fatto che la descrizione di Palermo lasciava molto al non detto. Nello specifico, ometteva quanto gli era accaduto quando le autorità lo avevano trasportato da Montefusco a Napoli. Nel suo memoriale, Castromediano aveva descritto l’episodio mancante, ovvero l’interrogatorio affrontato a Napoli durante il quale la promessa di un rilascio anticipato si aggiunse alle pressioni per indurlo ad ammettere la sua colpa e quella di altri. Fu motivo di orgoglio e onore per Castromediano l’aver rifiutato di collaborare[12].
Entrambi gli aspetti di questa scena del romanzo di Banti richiamano all’attenzione l’idea chiave di Giannone sul memoriale di Castromediano: in quanto parte di un corpus di testi che si intrecciano, richiamandosi l’un l’altro e sovrapponendosi, esso non restituisce solo i ricordi di un singolo uomo, ma anche la complessa storia – ricca di slanci patriottici e pur sempre credibile – del Risorgimento nel meridione.
Giannone ha redatto i suoi saggi senza il beneficio di una risorsa in gran parte inesplorata: l’archivio Castromediano a Lecce. Lo studioso non era conoscenza, ad esempio, che tale archivio conserva quattro lettere spedite da Lopresti a Castromediano (e abbiamo buoni motivi per sospettare che la Banti possedesse alcune delle risposte). Conserva inoltre lettere spedite da Palermo, Garcea, Braico e Nicola Tisco. Tra le lettere di Lopresti, due in particolare sembrano provenire direttamente dalle pagine di Noi credevamo. In quella del 13 febbraio del 1861, Lopresti chiese a Castromediano di aiutarlo a ribaltare una subdola vendetta burocratica che aveva subito, ossia il trasferimento dall’ufficio doganale di Napoli a quello di Reggio Calabria. Tra le conseguenze dell’indesiderato trasferimento c’era la perdita della disponibilità di un oculista, di cui Lopresti aveva bisogno per recuperare dai danni subiti a causa del prolungato confinamento nelle buie celle borboniche. Due settimane prima che Lopresti scrivesse questa lettera, Castromediano era stato eletto al primo parlamento dell’Italia unita assieme a Carlo Poerio e ad altri che avevano condiviso le carceri con Lopresti negli anni ’50. A tutti i suoi ormai potenti “compagni di catena,” Lopresti rivolse il seguente appello:
“Persuaso che i miei onorevoli compagni di catena, meritamente circondato da fama grande, e da poteri, non vorranno permettere, senza spendere una parola a cui si conviene, che uno de’ più onorati compagni della loro sventura dovesse rimanere accoppato dalla forza di ciurmadori, e ladroni, io con fiducia fo ricorso all’amicizia, ed alla bontà onde mi onorano perché volessero provocare gli ordini del mio pronto richiamo in Napoli, promettendo sinceramente che anche infermo spiegherò quella alacrità che à il debito di spiegazione colui che sente altamente l’amore soave della Patria diletta”[13].
Tre mesi più tardi, Lopresti scrisse a Castromediano ringraziandolo dei suoi sforzi, e informandolo che la propria posizione non era migliorata, così che gli chiese ancora di portare il proprio dramma all’attenzione dell’intero gruppo dei compagni di prigionia coinvolti negli affari di governo, “persone che han meco divisa una catena”, uomini che avevano il dovere di difendere il loro “compagno di sventura”[14].
L’archivio Castromediano è ricchissimo di lettere di compagni di prigionia. Tra l’ottobre del ’48 e il gennaio del ’49, Castromediano condivise le celle di cinque prigioni diverse con oltre cento individui. Lo sappiamo perché fu Castromediano stesso a corredare le sue memorie di lunghe liste di nomi. Ad esempio, cita quaranta detenuti andati a processo con lui a Lecce nell’estate del ’50 (“sento il dovere di riportare i nomi”), e ancora quarantanove uomini trasferiti con lui nelle carceri di Montefusco nel febbraio del ’52. Include inoltre nel memoriale diversi profili biografici, compreso quello brevissimo di Lopresti e otto più dettagliati di compagni a Montefusco[15]. Tali riflessioni generano alcune domande: furono lettere come quella di Lopresti a portare Castromediano ad arricchire le sue memorie con la presenza di così tanti compagni di prigionia? Furono i patimenti subiti da uomini come Lopresti dopo il rilascio ad allontanare Castromediano dall’idea di comporre un memoriale più convenzionale, di taglio eroico, insomma un memoriale che registri gli eventi “coi colori delle rose”?
Queste sono domande piuttosto specifiche, e ne producono di più generali: ad esempio, accade alla maggior parte dei prigionieri di mantenersi in contatto dopo la liberazione? E ancora, sono i prigionieri politici particolarmente propensi a mantenere forti legami e scambiarsi memorie collettive – ad esempio, in quanto fieri “nemici dello stato” o miserevoli “compagni di sfortuna” – o proprio come i prigionieri comuni tendono a lasciarsi alle spalle la loro esperienza in cella e a cercare relazioni nuove? Gli storici affrontano di rado interrogativi del genere, in parte perché la vita in prigione genera materiali di ricerca più avvincenti di quella dopo la prigione, e in parte perché le fonti necessarie per affrontare tali interrogativi spesso mancano. Generalizzare non è semplice[16].
Diversi anni fa, durante una breve visita all’archivio Castromediano di Lecce, ho condotto il seguente esperimento. Con l’inventario indicizzato di Rossellina D’Arpe alla mano, ho cercato lettere dai, e riferimenti ai, sessantacinque prigionieri che salparono con Castromediano da Napoli all’Irlanda nell’inverno del 1859. Nel gruppo figuravano anche i tre memorialisti citati precedentemente (Palermo, Garcea e Braico) e altri che trascorsero diversi anni dietro le sbarre a Montefusco e Montesarchio con Castromediano. Ho inoltre consultato l’archivio alla ricerca di accenni a Lopresti e a tre altri individui che avrebbero abbandonato la prigione nel gennaio del ’59 se una grave malattia non li avesse costretti a lascare le carceri anticipatamente o a rimanere indietro[17].
Tuttavia, nonostante l’archivio Castromediano contenga circa cinquemila documenti relativi alla corrispondenza dell’autore, non offre comunque un quadro completo né privo di imprecisioni delle sue relazioni interpersonali. Prima di tutto, si tratta di un epistolario per lo più unilaterale: la maggior parte dei documenti relativi al periodo successivo alla sua scarcerazione consiste in lettere ricevute, non inviate. Il prezioso inventario delle lettere redatto da Fabio D’Astore, Mi scriva, mi scriva sempre, contribuisce a colmare lacune significative, ma non è completo. In secondo luogo, l’archivio tende a relegare in secondo piano amici celebri di Castromediano come Poerio, Settembrini e Silvio Spaventa, le cui lettere potrebbero esser state restituite loro, o trasferite in altri archivi regionali e nazionali. Infine, il fatto che Castromediano abbia vissuto a Torino tra il 1859 e il 1865 e lì abbia stretto contatti con ex prigionieri, potrebbe aver ridotto le necessità di corrispondere con questi. Tenendo a mente tali riserve, quali sono i risultati del mio esperimento?
Diciassette tra gli individui del mio campione (24,6%) scrissero a Castromediano un totale di ottantasette lettere tra il 1859 e il 1883, molte delle quali datate negli anni subito successivi alla scarcerazione. Il peso di questi dati è aperto ad interpretazioni. Il numero di corrispondenti e lettere è sorprendentemente alto o prevedibilmente modesto? E cosa possiamo dedurre dalla concentrazione di lettere negli anni 1859-1862? Potrebbe indicare che i legami formati da Castromediano con i suoi compagni di prigionia non fossero particolarmente stretti. Ma potrebbe anche riflettere la scelta consapevole di evitare ricordi di un passato angosciante. In Noi credevamo, Banti coglie il disagio che alcuni prigionieri devono aver provato nell’imbattersi, da uomini liberi, in ex compagni di cella. Proprio il suo protagonista, Lopresti, ribadisce i limiti delle amicizie strette in prigione attraverso racconti di conversazioni impacciate occorse in tali incontri: “Dopo un abbraccio formale, rimanevamo imbarazzati parlando di cose insignificanti, il tempo, la salute… Sapevamo ben poco, adesso, l’uno dell’altro ed esitavamo a chiedere notizie delle famiglie, forse menomate.” Mentre si separavano, facendo programmi poco convinti di rivedersi ancora, “una sorta di malinconica intesa” li portava rapidamente a prendere strade diverse[18].
Per capirne di più delle relazioni tra i prigionieri dopo la prigionia, è necessario concentrarsi sulle lettere indirizzate a Castromediano. Nelle pagine che seguono, discuterò due risultati della mia ricerca. In primo luogo, diversi gruppi di lettere indirizzate al nostro tra il ’59 e il ’61 ci offrono uno spaccato su quei sentimenti diffusi di orgoglio e disincanto politico che portarono Castromediano a interrogarsi su quanto lui e i suoi compagni abbiano effettivamente ottenuto rimanendo per una decade nelle carceri borboniche. In secondo luogo, ulteriori fonti risalenti agli anni ’59-’61 ci forniscono i primi indizi dell’impegno di Castromediano a redigere un memoriale che non si concentri esclusivamente sulla sua esperienza personale o sulla grande portata degli eventi internazionali negli anni ’50, ma anche sul trattamento crudele inflitto dal governo borbonico a centinaia prigionieri politici.
Prima di discutere le mie scoperte, devo confessare di non aver trovato, nella corrispondenza, una chiave per valutare l’impatto dei primi memorialisti delle carceri borboniche – Palermo e Garcea – su Castromediano. Garcea scrisse a Castromediano nel novembre del 1861, nel maggio del ’62 e infine nell’ottobre del ’72, ma nessuna tra queste missive si sofferma sul tempo trascorso insieme dietro le sbarre, né tantomeno sui tentativi dell’uno o dell’altro di redigere un memoriale. Riguardano, più semplicemente, opportunità di lavoro di amici e famigliari. Nella prima di queste, Garcea fa riferimento alla propria salute cagionevole, e nell’ultima riassicura l’amico che “io sono sempre il medesimo, che non dimentico mai quel legame che ci tenne uniti e che difficilmente si potrà dimenticare”, prima di firmarsi come “Vostro sempre sincero Amico, e Compagno di sventura”[19]. Per quanto riguarda Palermo, la sua unica lettera è datata marzo 1865, ossia due anni dopo la pubblicazione del suo memoriale. Palermo la apre con leggerezza, riportando notizie di famigliari, per poi focalizzarsi sul tema principale: la richiesta a Castromediano (al tempo ancora membro del parlamento) di intercedere in aiuto del fratello perché ottenga un nuovo incarico governativo[20].
Se le lettere di Palermo e Garcea sono scarse e soprattutto relativamente silenziose sull’esperienza condivisa della prigionia, esistono tuttavia tre gruppi significativi di lettere indirizzate a Castromediano dai sessantanove soggetti presenti nel mio campione di ricerca. Il primo gruppo risale alla tarda primavera e inizio estate del ’59, il secondo alla tarda primavera e all’estate del ’60, e il terzo all’inverno tra il ’61 e il ’62.
(continua)
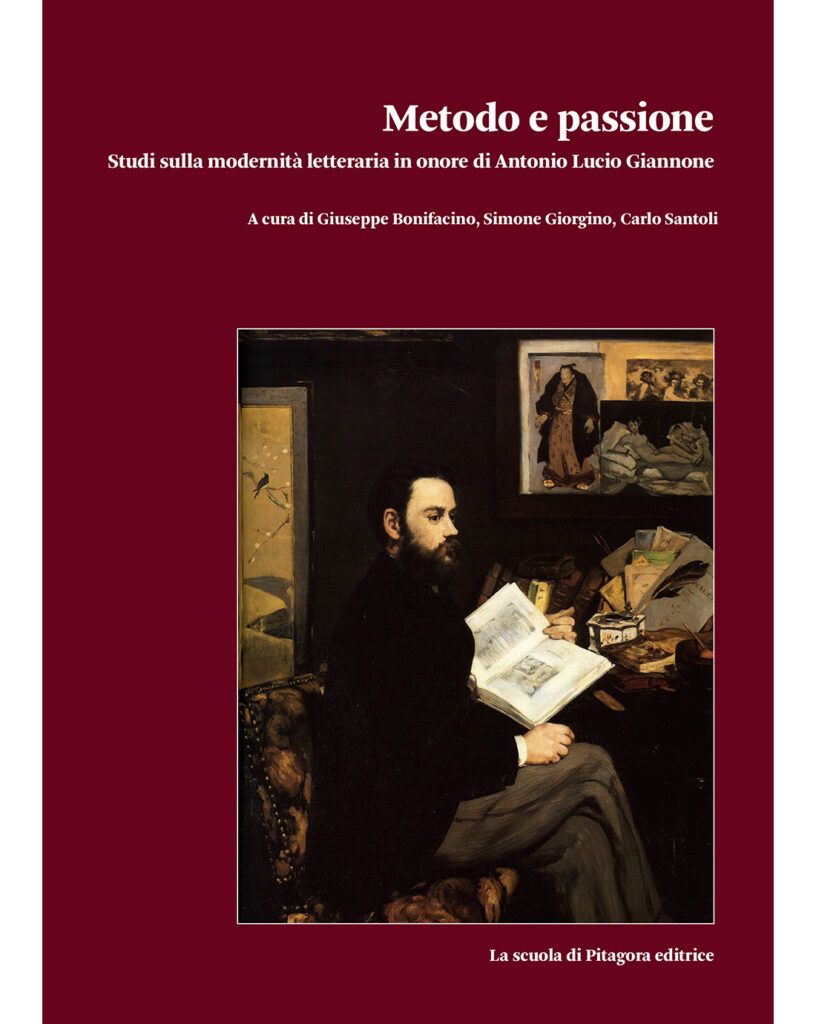
Tradotto dall’inglese da Dario Marcucci, City University of New York
[Questo saggio è stato pubblicato per la prima volta, in inglese, col
titolo Scattered friends and collected memories: the unpublished letters of
fellow prisoners to Sigismondo Castromediano, nel Primo tomo del vol. Metodo e passione. Studi sulla modernità
letteraria in onore di Antonio Lucio Giannone, Napoli, La Scuola di Pitagora, 2022, pp.
95-124. L’autore, Steven Soper, è professore di Storia dell’Europa moderna
presso l’Università della Georgia (USA)]
[1] Fabio D’Astore, “Mi scriva, mi scriva sempre…”: Regesto delle lettere edite ed inedite di Sigismondo Castromediano (Lecce: Pensa, 1998); Carceri e galere politiche: Memorie del Duca Sigismondo Castromediano. Due volumi. (Lecce: Congedo, 2005), ristampa dell’originale pubblicato nel 1895-1896 a Lecce da Tipografica Editrice Salentina; Sigismondo Castromediano, Diario (1847-1851), Giovanna Rosalio (ed.) (Lecce: Congedo, 2013); Alessandro Laporta, Il duca bianco di Cavallino: Nuovi contributi (Lecce: Congedo, 2013); Antonio Lucio Giannone and Fabio D’Astore (eds.), Sigismondo Castromediano: il patriota, lo scrittore, il promotore di cultura. Atti del Convegno Nazionale di Studi (Cavallino di Lecce, 30 novembre-1 dicembre 2012) (Lecce: Congedo: 2014); Fabio D’Astore (ed.), Manoscritti giovanili di Sigismondo Castromediano: Archivio Castromediano di Lymburg (Lecce: Congedo, 2015); Maria Alessandra Marcellan (ed.), Cara Adele, caro Sigismondo: Millerose fu cominciamento di un sogno… Carteggio Savio-Castromediano (Lecce: Congedo, 2018); Antonio Lucio Giannone (ed.), Tra realtà storica e finzione letteraria: Studi su Sigismondo Castromediano (Lecce: Pensa, 2020).
[2] Pubblicati in origine tra il 2010 e il 2014 in riviste e in un volume di atti di conferenze, i tre studi di Giannone su Castromediano compaiono ora nella sua raccolta di saggi, Sentieri nascosti: Studi sulla Letteratura italiana dell’Otto-Novecento (Lecce: Milella, 2016). Il primo di questi studi, “Sigismondo Castromediano e la memorialistica risorgimentale” (pp. 15-36), mette a confronto i testi di Castromediano, Pellico e Settembrini.
[3] Ibid.,p. 18. Nicola Palermo, Raffinamento della tirannide borbonica ossia i carcerati in Montefusco (Reggio Calabria: 1863); Giovannina Garcea, Antonio Garcea sotto i borboni di Napoli e nelle rivoluzioni d’Italia dal 1837 al 1862. Racconto storico (Torino: 1862); Cesare Braico, “Ricordi della galera,” in Lecce 1881 (Lecce: Salentina, 1881); Nicola Nisco, Gli ultimi trentasei anni del Reame di Napoli (1824-1860), Vol. 2: Ferdinando II (Napoli: Morano, 1889). Elenco il memoriale di Palermo prima di quello di Garcea perché uscito originariamente in una serie di articoli sul giornale fiorentino La Nazione, tra il 1860 e il 1861. Nel paragonare questo corpus di testi al memoriale di Settembrini, Giannone individua una differenza chiave: Settembrini fu incarcerato lontano dagli altri memorialisti, sull’isola di Santo Stefano, e il suo memoriale fu pubblicato postumo nel 1879-1880, prima di quello di Braico e dell’opera di Nisco sul regime Borbonico. Al corpus trattato da Giannone, aggiungiamo le opere di Antonio Nicolò, Narrative of My Ten Years’ Imprisonment in the Dungeons of Naples (London: A. W. Bennett, 1861), e Carlo De Angelis, Memorie, Matteo Mazziotti (ed.) (Roma: Società Dante Alighieri, 1908). Giannone discute il libro di Nicolò nel saggio recentemente uscito, “Memorialistica meridionale del Risorgimento: nuove acquisizioni,” in Sinestesie, Anno XXXII (2024), pp. 27-41.
[4] Antonio Lucio Giannone “Epopea risorgimentale nel Sud: Castromediano e altri memorialisti,” in Sentieri nascosti, p. 41.
[5] Id., pp. 42-62.
[6] Attilio Monaco, I galeotti politici napoletani dopo il Quarantotto, 2 vol. (Roma: Treves, 1932).
[7] Giannone, “Il ‘più reale tra noi’: la figura di Sigismondo Castromediano nel romanzo di Anna Banti, Noi credevamo,” in Sentieri nascosti, pp. 63-80; Yannick Gouchan, “‘Le idee di cui mi ero lungamente esaltato?’: il Risorgimento e i suoi protagonisti meridionali nel romanzo Noi credevamo di Anna Banti,” in Giannone (ed.), Tra realtà storica e finzione letteraria, pp. 43-67; Anna Nozzoli, “Anna Banti e il Risorgimento senza eroi,” in Enza Biagini (ed.), L’Opera di Anna Banti. Atti del Convegno di studi: Firenze, 8-9 maggio 1992 (Firenze: Olschki, 1997, pp. 179-190.
[8] Castromediano, Carceri e galere politiche, Vol. I, p. 351. Come indicato da Giannone, il ritratto che Castromediano fa di Lopresti ricorda quello restituitoci da Nicola Palermo in un memoriale composto molti anni prima. Vedi Giannone, “Il ‘più leale tra noi'”, cit., pp. 65-67.
[9] Banti segue il racconto di Castromediano passo dopo passo, “dalla detenzione a Procida ai trasferimenti a Montefusco prima e a Montesarchio poi”. Giannone, “Il ‘più reale tra noi'”, cit., pp. 67-68.
[10] Anna Banti, Noi credevamo (Milano: Mondadori, 1978), pp. 47-48, 119; Giannone, “Il ‘più leale tra noi'”, cit., pp. 68-69, 78-80.
[11] Fabio D’Astore ha esaminato le tre diverse fasi del lavoro di Castromediano sul memoriale (1848-1851; 1859-1880; e 1880-1895), e ha fornito diversi esempi delle varie revisioni presenti nelle versioni finali dell’opera. Cfr. “Passi inediti di un manoscritto delle Memorie di Sigismondo Castromediano,” in Giannone e D’Astore (eds.), Sigismondo Castromediano, pp. 87-118. La corrispondenza privata tra Castromediano e Olimpia e Adele Savio conferma che il lavoro sul memoriale rallentò nel 1865 e riprese solo alla fine del 1880, quando un gruppo di “bravi giovani” leccesi lo convinse a pubblicarne un estratto su un annuario locale. In proposito, cfr. la lettera di Castromediano ad Adele Savio del 25 dicembre 1880, in Marcellan (ed.), Cara Adele, caro Sigismondo, pp. 310-311.
[12] Giannone, “Epopea risorgimentale,” pp. 54-57, e “Il ‘più leale tra noi'”, pp. 75-78; Castromediano, Carceri e galere politiche, Vol. 2, pp. 39-66; Banti, Noi credevamo, pp. 110-126. Castromediano espresse il proprio disappunto riguardo alla descrizione dell’episodio fatta da Palermo non appena questa uscì sulle pagine della Nazione nell’estate del 1860. In proposito, cfr. la sua lettera a Olimpia Savio datata agosto 29, 1860, in Marcellan (ed.), Cara Adele, caro Sigismondo, pp. 118-119.
[13] Lettera di Domenico Lopresti a Sigismondo Castromediano. Reggio Calabria, 13 febbraio 1861. Conservata nell’archivio privato della famiglia Castromediano-Gorgoni a Lecce [da qui in poi abbreviato in PAC-G]. Corrispondenza n. 436. Cfr. Appendice III.
[14] Lettera di Domenico Lopresti a Sigismondo Castromediano. Napoli, 18 maggio 1861. PAC-G. Corrispondenza, n. 573. L’espressione “compagni di sventura” e le sue variazioni (“compagni d’infortunio,” “compagni di sciagura,” ecc.) proliferava durante il Risorgimento. Appare, ad esempio, nelle memorie e nelle lettere di diversi celebri prigionieri a Spielberg negli anni ’20 e ’30 dell’Ottocento (Silvio Pellico, Alexandre Andryane, Federico Confalonieri), e nei tributi biografici di Atto Vannucci ai “martiri della libertà” italiani.
[15] Castromediano, Carceri e galere politiche, Vol. I, pp. 105-106, 283-285, 341-352.
[16] Persino raccolte di lettere di prigionieri più celebri, edite in più volumi e riguardanti periodi più ampi delle loro vite, possono risultare fuorvianti. Si prenda, ad esempio, il più celebre tra i prigionieri politici del Risorgimento: Silvio Pellico. Il primo dei molti volumi della sua corrispondenza fu pubblicato due anni dopo la morte, avvenuta nel 1854. In esso sono contenute diverse lettere a Federico Confalonieri e Pietro Borsieri, due dei circa quaranta uomini imprigionati con Pellico nella fortezza di Spielberg negli anni ‘20. Sappiamo da diverse fonti che Pellico scrisse anche ad ex compagni di prigionia, tra cui Piero Maroncelli, Alexandre Andryane e Giovanni Arrivabene, ma sarebbe necessaria un’attenta analisi di dozzine di memoriali e raccolte di corrispondenze per determinare la portata e l’importanza di queste lettere. In proposito, si veda Guglielmo Stefani (ed.), Epistolario di Silvio Pellico (Firenze: Le Monnier, 1856); e, come esempio di un recente studio sulla corrispondenza di Pellico con i suoi ex compagni di prigionia, si veda l’agile volume curato da Cristina Contili, Silvio Pellico, Lettere agli ex compagni di prigionia allo Spielberg: Alexandre Andryane e Pietro Borsieri (Raleigh, North Carolina: Lulu, 2017).
[17] Cfr. Appendice I. Nel suo memoriale, Castromediano cita tutti i sessantacinque uomini partiti con lui da Napoli nel gennaio del ‘59 tranne uno: Giuseppe Tripepe. Cfr. Castromediano, Carceri e galere politiche, Vol. II, pp. 120-124. A parte Lopresti, i tre nomi nuovi emersi nella mia ricerca sono quelli di Nicola Nisco, Michele Pironti, e Leone Tuzzo. Per quanto ne so, il preziosissimo inventario dell’archivio Castromediano realizzato da Rossellina D’Arpe è ad oggi inedito.
[18] Banti, Noi credevamo, cit., pp. 31-32.
[19] Lettere di Antonio Garcea a Sigismondo Castromediano. Località assente, 26 novembre 1861; Mondovì, 19 maggio 1862; Reggio, 29 ottobre 1872. Ora in PAC-G. Corrispondenza, n. 764, 1018, 2205.
[20] Lettera di Nicola Palermo a Sigismondo Castromediano. Messina, 18 marzo 1865. PAC-G. Corrispondenza, n. 1712. Castromediano ricevette anche due lettere dalla vedova di Garcea, Giovannina Bertola Garcea, subito dopo la morte del marito, occorsa nella primavera del 1878. Nella prima missiva, Giovannina tributa un appassionato ricordo ai ranghi sempre più ridotti di “tanti uomini forti, veri martiri della patria,” che hanno sofferto le “terribili galere del despota” per l’Italia unita. Scrisse entrambe le lettere da Velletri, una il 17 maggio e una il 2 giugno. PAC-G. Corrispondenza, n. 2749 and 2757.




























































