di Adele Errico
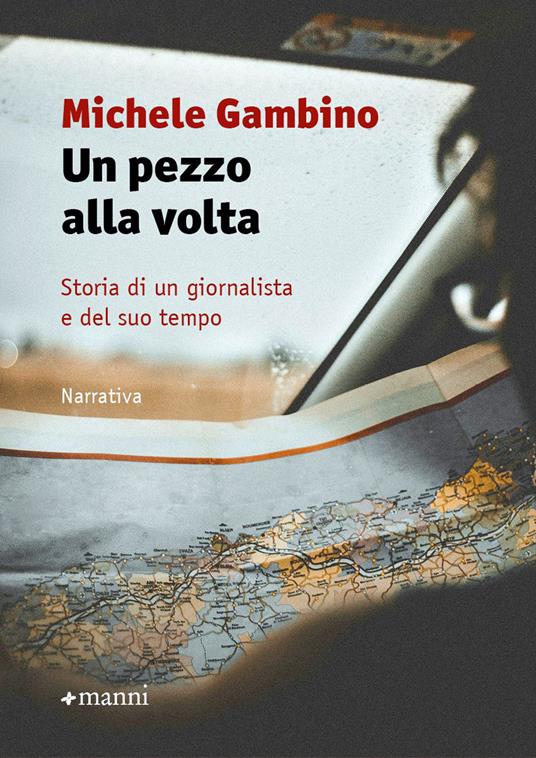
Un pezzo alla volta (Manni, 2024) di Michele Gambino mi ha fatto pensare a un testo che di solito si legge a scuola, di solito in terza superiore, ed è una lettera che Petrarca scrive ad un suo amico, monaco agostiniano, in cui racconta dell’”ascensione al Monte Ventoso”. In quella lettera, nelle parole di quel giovane Petrarca alla ricerca di qualcosa che è convinto troverà in cima al monte – in quella sofferenza del fisico e dell’animo, in quella eterna sospensione nel dubbio, nella foschia del monte, nel non dare ascolto alle parole del vecchio pastore che, prima della partenza, gli dice che in cima non avrebbe trovato nulla – c’è qualcosa che ho ritrovato nell’ultimo libro di Gambino. Una fame. Quella di chi desidera, vuole. Si tende e si incrina, cade e si rialza e ancora inciampa e risorge. Gambino ripercorre in questo libro una carriera giornalistica intensa scegliendo la forma del “memoir” per dare ordine e struttura alla passione che ha guidato ogni moto della sua esistenza. Reporter militante fin dalla sera in cui dice ai suoi genitori che avrebbe lasciato l’università per fare il giornalista, Gambino fa quel giornalismo che rovina le suole delle scarpe. Perché non è solo giornalismo di scrittura ma di corse, di notti, di aerei, di cose che a vederle non ci si abitua mai. Come i morti ammazzati. Quelli che fa la mafia. Comincia a lavorare con Giuseppe Fava nel 1980 ed è con lui che comincia per Gambino “l’educazione di cronista”: “Nei bagni pubblici di Amsterdam i gabinetti hanno una mosca nera disegnata sul fondo della tazza. Gli uomini indirizzano il getto sulla mosca e i gabinetti restano puliti. Ho letto che funziona a meraviglia. Tutti noi avremmo bisogno, al momento giusto, di una mosca in fondo alla tazza, che ci indichi un obiettivo (…) Quel che conta è avere la propria mosca nel water. Per me Giuseppe Fava è stato quella cosa lì”.




























































