di Simone Giorgino
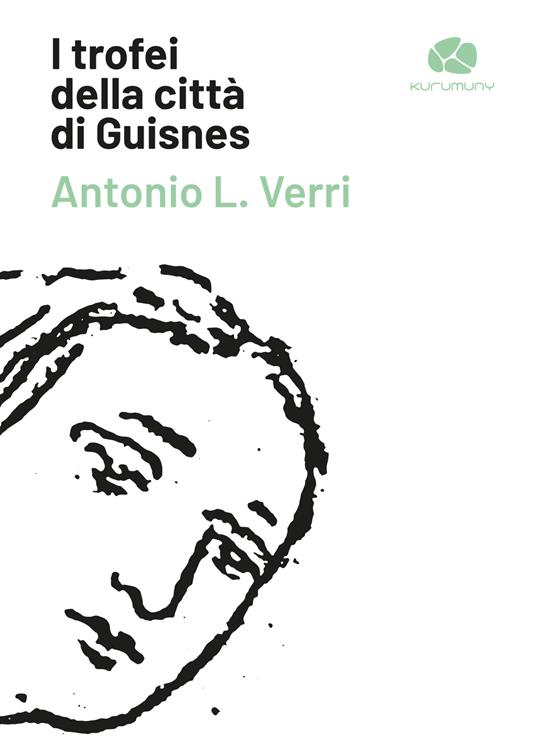
In una lettera a Maurizio Nocera del 5 aprile 1988, Antonio Verri scrive: «Sono cinque giorni che non esco di casa. Letteralmente. Mezz’ora fa ho portato il tutto in copisteria. Di questo romanzo ricorderò sempre l’immensa stanchezza, il collo continuamente dolorante dopo otto-dieci ore al tavolo […]. Il romanzo. I miei Trofei. L’ho riletto, trovo che sia un buon romanzo e non credo di essere cattivo lettore […]. Del romanzo non so parlarne adesso, so solo che l’ho fatto in meno di tre mesi […], quando ho scritto a [Giorgio Bàrberi] Squarotti che lavoravo su di un romanzo irridente, visionario: beh, non lo avevo neanche pensato, non conoscevo un cavolo della storia che poi sarebbe stata».
Il libro «irridente» e «visionario» che Verri si apprestava a pubblicare avrebbe presentato alcuni tratti distintivi della sua ricerca espressiva più matura: l’eccentrica sperimentazione di un linguaggio alchemico, un esercizio di stile attraverso il quale si rivendica la sovrana libertà di una scrittura che danza sul baratro dell’insignificanza, sull’oltraggio del senso, con la vertigine eufonica che ha già in sé la profezia di un’inevitabile caduta. Uno strabiliante congegno linguistico che ambisce a essere non una rappresentazione ma una ricreazione (nel senso di nuova creazione, ma anche nel senso di gioco, di ludo verbale) della polimorfa varietà del mondo nell’esiguo spazio delle pagine di un libro.
Arrischiare un sunto dei Trofei della città di Guisnes – che ritorna in libreria nel giorno del trentesimo anniversario della scomparsa di Verri, con una brillante introduzione di Mario Desiati, nella collana Declaro dell’editore Kurumuny – è un’impresa ardua, considerata la fragilità della trama e il groviglio di storie e personaggi che vi si intrecciano.




























































