di Simone Giorgino
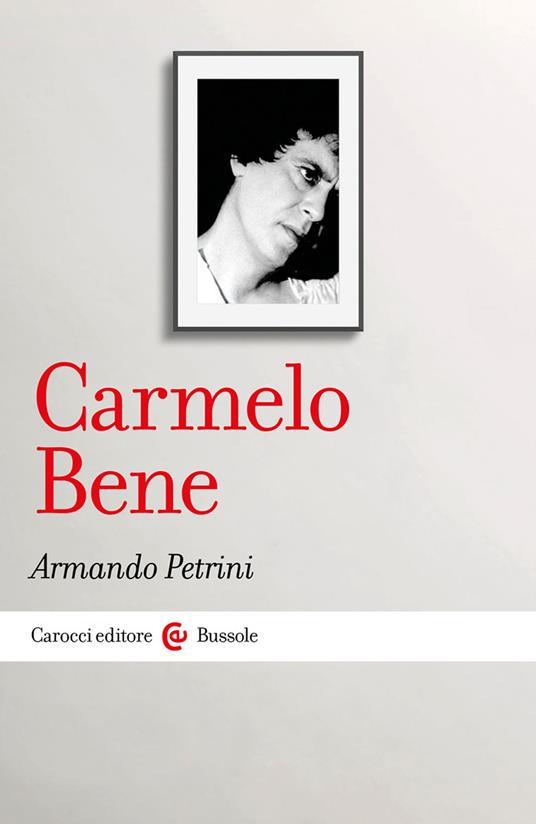
La paradossalità, che è la caratteristica essenziale della poetica di Carmelo Bene, può dare a volte adito – e alibi – ad alcuni fraintendimenti, «soprattutto laddove non li si contestualizzi all’interno di un pluridecennale e complesso corpo a corpo con il teatro», spiega Armando Petrini nel suo ultimo saggio, intitolato semplicemente Carmelo Bene, pubblicato lo scorso dicembre da Carocci (Roma 2021, pp. 128).
Petrini, docente di Storia del teatro all’Università di Torino e già autore del notevole Amleto da Shakespeare a Laforgue per Carmelo Bene (ETS, 2004), ci ricorda che la contraddizione fondamentale della sua opera consiste nell’«esprimere un fatto d’arte, ai massimi livelli possibili, e contemporaneamente indicarne l’avvenuta impossibilità».
E propone un inquadramento storico-critico di questa «ricerca impossibile», ricostruendo l’effervescente contesto in cui si sviluppa. Un brodo di coltura che dà conto delle sperimentazioni pressoché coeve di de Berardinis, Quartucci, Grotowski, del Living Theatre.
Secondo Petrini, il lavoro di Bene è suddivisibile in due fasi, ovviamente non impermeabili fra loro: dagli esordi alla metà degli anni Settanta; e da qui alla sua scomparsa, avvenuta nel 2002.




























































