Sin dal momento della pubblicazione, Il marito di Elena alimentò tra i lettori, i critici, i letterati un ampio e articolato dibattito al riguardo della collocazione crono-tematica dell’opera all’interno della parabola ideologico-creativa dello scrittore siciliano: dibattito ancor vivo e, secondo me, lungi dall’esser definitivamente conchiuso, nonostante i non pochi e spesso approfonditi saggi critici dedicati al romanzo e le numerose (ben sei vivente l’autore) e apprezzabili edizioni che si sono succedute nel corso degli anni, fino alla recente, pregevolissima edizione critica del 2019, magistralmente curata da Francesca Puliafito nell’ambito del progetto dell’edizione nazionale delle opere di Verga coordinato dalla Fondazione Verga[4].
Non mancarono gli apprezzamenti, talvolta in dialettica contrapposizione con la ’fredda’ accoglienza riservata ai Malavoglia, usciti da poco; anzi, alcuni critici, dopo aver «rammemorato talune ’stranezze’ tecnico-stilistiche presenti nei Malavoglia (serie di scene e di dialoghi, intenzionali sgrammaticature), segnalavano con indubbia adesione il nuovo romanzo verghiano, pure come clamorosa smentita di quell’erroneo preconcetto dell’arte oggettiva, precedentemente assorbito (Vita dei campi-Malavoglia) dallo scrittore siciliano nella sua esclusiva assolutezza»[5].
Su posizioni decisamente opposte, tra le due guerre, i giudizi di alcuni tra i critici più noti (Croce, Russo e altri), i quali espressero non poche riserve sul Marito di Elena, quasi schiacciato tra i Malavoglia e Mastro don Gesualdo e considerato un romanzo «vistosamente minore per la ripresa-congedo di moduli tematico-stilistici preveristi»[6]. Il Momigliano, invece, «colse nel romanzo la matura e disillusa concezione di vita dello scrittore siciliano, felicemente concretizzatasi in personaggi vivi e psicologicamente ben delineati»[7]. Anzi, per il Momigliano, «in tutta l’opera di Verga, il motivo più ricco di pensosità e di perplessità è quello del Marito di Elena, che si sviluppa da una meditazione sapiente sulla fatalità psicologica della vita»[8]. Ciò che sanciva, agli occhi del critico, una linea di continuità evidente con l’intero percorso creativo dello scrittore catanese:
L’irresolutezza penosa di Cesare destinato dal suo temperamento a soffrire per tutta l’esistenza piuttosto che affrontare una battaglia breve ma aspra, urta contro l’inerte e molle egoismo di Elena: e di qui deriva inevitabilmente la vicenda di quel matrimonio. Ma le convinzioni che suggeriscono al Verga le sfumature del lento dramma coniugale, sono le medesime da cui nascono la storia logica e malinconica dell’amore di Enrico e di Eva, le pene dei diseredati, le traversie costanti dei Malavoglia, le amarezze immutabili di don Gesualdo, il cinismo elegante di suo genero e del suo seguito[9].
Tuttavia, pure dopo il secondo conflitto mondiale i giudizi furono poco disponibili nei confronti del Marito. Anche se qualche critico ha individuato nel romanzo elementi che farebbero pensare a una tappa riconducibile al ciclo dei Vinti per la presenza di evidenti consonanze ideologiche (mito della roba, ansia di promozione sociale, ecc.)[10], molti studiosi, al contrario, hanno evidenziato una sorta di ritorno alla narrativa preverista, fino a prospettare improbabili proiezioni autobiografiche, addirittura tali da autorizzare l’ardita individuazione dello «specifico spazio biografico entro il quale collocare il romanzo in questione»[11] e tali, quindi, da portare ad escludere categoricamente qualsiasi possibilità di inserimento del Marito all’interno del ciclo dei Vinti. Secondo M. Dillon Wanke, ad esempio, è possibile collegare «la storia dell’adultera Elena con la vita sentimentale dello scrittore»[12]: giacché il Verga «viveva negli anni dall’’80 all’’83 una vicenda di adulterio non meno difficile e segreta di quella narrata nel Marito di Elena, in qualità di amante di Giselda Fojanesi Rapisardi»[13], Cesare, il protagonista del romanzo, tradito dall’adultera Elena, «rappresenterebbe il rimosso-rovescio del vissuto esistenziale dello scrittore (Verga amante della Fojanesi)»[14]. Per la Dillon Wanke, cioè, «si attuerebbe nel romanzo una contaminazione arte-vita»[15] mediante il «rovesciamento dei ruoli (marito-amante), che potrebbe descriversi freudianamente, come rimozione del reale stato dei fatti, espressa nei termini virtuali del dover essere»[16]. Tale ipotesi, per certi versi suggestiva, presenta però un vulnus, perché non tien conto del fatto che, ben prima dell’incontro con la Fojanesi a Firenze (settembre 1880), il Verga si era già dilungato sul Marito di Elena in una lettera spedita al Treves il 9 gennaio 1879:
Catania, 9 gennaio 1879
Caro Treves,
risentimento no! Anzi se qualche cosa mi pungeva del vostro articolo era il credere di scorgerne in voi.
Vi manderò dentro l’anno, se volete, per la vostra «Illustrazione» Il marito di Elena abbozzato quando non sapevo nulla di un Mari d’Ida rappresentato al Manzoni. Il titolo non sarebbe nulla, e potrebbe cambiarsi, ma per me risponde perfettamente al tipo, studiato dal lato opposto a quello che la società è abituata a coprire di ridicolo e di disprezzo, lo schizzo di un marito ingannato il quale non avrebbe altro torto che di amare la moglie colla cecità di un amante, la delicatezza, la generosità anche, vista da un certo lato, che si potrebbe cercare nella sua fiducia esagerata, le lotte segrete, i patimenti, le concessioni e gli abbassamenti morali e graduali di questo disgraziato; la semplicità con cui, quando ha ucciso l’ultimo amante della moglie, dà la testa per salvare la riputazione di colei, che ne ha solo per lui, della riputazione, agli occhi di lui soltanto, e che l’ha coperto di disonore. Insomma un disgraziato che grado grado si abitua a tutte le viltà, per un sentimento generoso in fondo. Ma anche la viltà non è la peggiore delle disgrazie?
Tutto ciò preso dal punto di vista sociale, anzi mondano, reso leggermente, ironicamente, come si potrebbe solo parlare di quel poveraccio di suo marito in un salotto, fatto risaltare delicatamente per via dei contrasti. Di scogli non ce ne saranno punto, perché, come vi ho detto, dev’essere una narrazione quale si potrebbe fare in conversazione, da gente che sappia glisser sui punti scabrosi, e velarli con quella vernice di buona compagnia che il soggetto richiede. Se vi va ditemelo, se no vi manderò altra cosa.
Intanto abbiatevi una stretta di mano dal vostro aff.
G. Verga[17]
L’importanza di questa lettera, pubblicata da G. Raya nel 1986, non era sfuggita a G. Rizzo, il quale, nel suo fondamentale saggio Filologia ed esegesi verghiana: le due redazioni del Marito di Elena[18], insiste sul fatto che tale lettera «merita una particolare attenzione perché fa piena luce su una prima fase redazionale del Marito, collocabile nell’estate-autunno del 1878»[19], periodo particolarmente fervido per l’attività creativa del Verga fra il progetto malavogliesco e le novelle di Vita dei campi e molto impegnativo ai fini della definitiva maturazione delle scelte in direzione del canone verista dello scrittore siciliano, il quale, come si legge nella lettera, proponeva al Treves l’invio entro l’anno del romanzo, abbozzato quando non sapeva nulla di un Mari d’Ida, commedia in tre atti di A. Delacour e G. Mancel, rappresentata al Teatro Manzoni di Milano il 26 ottobre 1878 e pubblicata nel 1880 (Milano, Libreria editrice).
Una prima e importante indicazione, dunque, riveniente dalla lettera del Verga riguarda la data di stesura e, di conseguenza, il travagliato iter redazionale del romanzo: certamente va respinta l’ipotesi secondo la quale il Verga compose Il marito di Elena subito dopo la pubblicazione dei Malavoglia (1881) e, anzi, per alcuni critici, in controtendenza rispetto agli assunti narrativi del romanzo di Padron ’Ntoni, quasi indispettito dalla fredda accoglienza riservata al romanzo[20]; ma, forse in maniera più perentoria, risulta assolutamente infondata l’ipotesi che vorrebbe rintracciare la genesi del romanzo in personali coinvolgimenti biografico-emozionali (incontro-rapporto con Giselda Fojanesi Rapisardi), evidentemente inficiata da palesi incongruenze cronologiche.
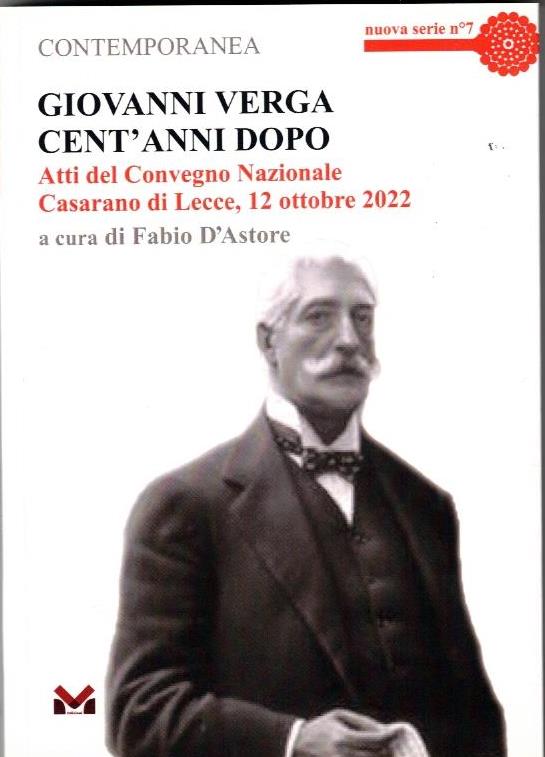
Non sembrano esserci dubbi: la prima fase redazionale del romanzo, o almeno l’abbozzo, va fissata nell’estate-autunno 1878, sulla base della inconfutabile prova rappresentata dalla lettera prima citata: «Caro Treves, […] vi manderò dentro l’anno, se volete, per la vostra «Illustrazione» Il marito di Elena», scriveva il Verga nei primi giorni del 1879.
E, a proposito della trama, aggiungeva:
Il titolo non sarebbe nulla, e potrebbe cambiarsi, ma per me risponde perfettamente al tipo, studiato dal lato opposto a quello che la società è abituata a coprire di ridicolo e di disprezzo, lo schizzo di un marito ingannato il quale non avrebbe altro torto che di amare la moglie colla cecità di un amante […]; la semplicità con cui, quando ha ucciso l’ultimo amante della moglie, dà la testa per salvare la riputazione di colei, che ne ha solo per lui, della riputazione, agli occhi di lui soltanto, e che l’ha coperto di disonore. Insomma, un disgraziato che grado grado si abitua a tutte le viltà, per un sentimento generoso in fondo. Ma anche la viltà non è la peggiore delle disgrazie?[21]
Indicazioni chiare, scelte nette, cronologicamente e tematicamente riconducibili alla fase della definitiva adesione del Verga alla poetica verista, in sintonia con l’esplicita condivisione di talune istanze del naturalismo. Sembrano evidenti i riferimenti soprattutto alle teorie di Zola e al pensiero di Taine più che una presunta influenza del modello flaubertiano di Madame Bovary, romanzo non particolarmente apprezzato dal catanese, che pur riconoscendo ‘una certa bravura di mano maestra’ per ciò che atteneva allo stile, non condivideva il soverchiante ‘realismo dei sensi’, che, a suo dire, impediva di ‘affezionarsi’ ai personaggi:
Il romanzo di Flaubert è bello, almeno per la gente del mestiere, ché gli altri hanno arricciato il naso. Ci son dettagli e una certa bravura di mano maestra da cui c’è molto da imparare. Ma ti confesso che non mi va; non perché mi urti il soverchio realismo, ma perché del realismo non c’è che quello dei sensi, anzi il peggiore, e le passioni di quei personaggi durano la durata di una sensazione. Forse è questa la ragione che non ti fa affezionare ai personaggi del dramma, malgrado il drammatico degli avvenimenti scelto con parsimonia maestra. Ma il libro è scritto da scettico, anche riguardo alle passioni che descrive, o da uomo che non ha principi ben stabiliti, il che è peggio[22].
Sicché, Il marito di Elena va piuttosto considerato «un riattraversamento critico e meditato del modello archetipico rappresentato da Madame Bovary»[23], nella direzione di un’approfondita indagine tesa a stabilire scientificamente quanto e come le inscindibili interdipendenze ambiente-carattere e luoghi-circostanze-educazione agiscono condizionando le passioni umane nel loro farsi. In particolare, per quanto riguarda i protagonisti del romanzo, Cesare «aveva ricevuto un’educazione quasi claustrale», impartitale dallo zio canonico don Anselmo, il quale, dopo la morte del padre del giovane, lo «aveva preso a ben volere per quel fisico intristito che gli sembrava una garanzia contro i rischi del matrimonio»[24]; pertanto:
L’influenza di siffatta adolescenza in quel temperamento delicato aveva sviluppata una sensibilità inquieta, una delicatezza di sentimenti affinati dalle abitudini contemplative, dalla stessa severa disciplina ecclesiastica che li rendeva timidi, raccolti e meditabondi[25];
Elena, invece, che abitava con i genitori nella corte della «stessa casa, di faccia al quartierino» dove viveva Cesare con altri quattro studenti, e la sorella Camilla
avevano ricevuta un’educazione quasi fossero destinate a sposare dei principi. Si udivano parlare inglese e francese sul terrazzino, suonavano il piano come non dovessero far altro tutta la vita, e di tanto in tanto mettevano alla finestra per asciugare dei dipinti che sembravano meravigliosi da lontano. Contuttociò […] Elena, la quale leggeva dei romanzi, quando non suonava il pianoforte, guardava con certi occhi, allorché era per la strada o sul terrazzino, come se aspettasse il personaggio romanzesco che doveva offrirle la mano, il cuore e una carrozza a quattro cavalli[26].
Siffatti principi di interdipendenza il Verga aveva perentoriamente enunciato nella dedicatoria indirizzata a Salvatore Farina, premessa alla novella L’amante di Gramigna, composta nel 1879; come è stato acutamente scritto, anzi, «il testo teorico con il quale l’abbozzo ha maggiori punti di contatto è sicuramente la prefazione all’Amante di Gramigna», giacché risultano «stringenti corrispondenze, anche a livello lessicale, in particolare nella ripresa dell’idea di causa ed effetto che coinvolge lo svolgimento misterioso e contraddittorio delle passioni umane e dei fenomeni psicologici.»[27]. Nella lettera al Farina, in effetti, lo scrittore catanese fissò i caratteri essenziali e peculiari della ‘nuova’ arte verista, inverati nell’Amante di Gramigna (sesto racconto di Vita dei campi), probabilmente l’esempio più significativo dell’adesione del Verga ai canoni del naturalismo, per l’essenzialità della narrazione, fedele al vero e ridotta all’essenziale, e per le scelte stilistico-strutturali, scarne e senza ‘intromissioni’ da parte dell’autore:
Caro Farina, eccoti non un racconto ma l’abbozzo di un racconto. Esso avrà almeno il merito di essere brevissimo e di esser storico ˗ un documento umano, come dicono oggi […]. Io te lo ripeterò così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e crudo, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore[28].
Consequenziali le scelte stilistico-strutturali, scarne e senza ‘intromissioni’ da parte dell’autore, così da far sembrare l’opera d’arte ‘essersi fatta da sé’:
Quando nel romanzo l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, […], il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie che la mano dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sorta spontanea come un fatto naturale; senza serbare alcun punto di contatto col suo autore[29].
Su tali presupposti teorici nell’estate-autunno del ‘78 lo scrittore catanese aveva ’abbozzato’ il romanzo e, sebbene nella lettera al Treves si dichiarasse disponibile a modificare il titolo, secondo Rizzo, «il dotto rinvio letterario (Menelao-Elena) rispondeva perfettamente al tipo del marito ingannato, studiato però dal lato opposto a quello che la società è abituata a coprire di ridicolo e di disprezzo»[30]. Insomma, il progetto appare ben chiaro, almeno per quanto riguarda il profilo del protagonista, e talune svolte dell’intreccio sembrano orientate decisamente nella direzione della «definitiva calibratura del personaggio nella serie dei ’vinti’ per fiacchezza di volontà»[31], per irresolutezza, per ‘viltà’: «Insomma, un disgraziato che grado grado si abitua a tutte le viltà, per un sentimento generoso in fondo. Ma anche la viltà non è la peggiore delle disgrazie?», aveva scritto nella lettera al Treves. Così nel romanzo, quando ormai risultano evidenti agli occhi dello stesso protagonista i reiterati tradimenti di Elena con il barone don Peppino, con il dissoluto Cataldi, con il poetastro Fiandura:
Quando il marito offeso non schiaccia la donna sotto il tacco, al primo momento, non ha altro di meglio a fare che prendere il cappello e andarsene. Se la donna ha il tempo di dire due parole, di spargere una lagrima, di fare un gesto, il marito perdona, e nove volte su dieci si rassegna. […]. Sì, l’amava ancora il disgraziato! Era geloso al modo dei deboli, senza aver la forza di rompere la sua catena […] Sì, una viltà! Ma non è la peggiore delle disgrazie esser vile?[32]
Cesare non pare discostarsi molto da altri personaggi verghiani; egli «ha un mito ed è l’amore di Elena; vive di quell’amore come padron ‘Ntoni della casa e don Gesualdo della roba: lì è la sua vita e la sua condanna»[33]. Si possono cogliere, dunque, già nell’abbozzo-prima stesura del Marito di Elena, elementi di contiguità con il progettato ciclo della Marea-Vinti: non solo quelli appena ricordati ma numerosi altri: si pensi, ad esempio, agli artifici narrativi precisati nella lettera («dal punto di vista sociale, anzi mondano, reso leggermente, ironicamente, […] come in un salotto»), alla tecnica narrativa indicata per una rappresentazione d’ambiente mondano, tutta «oggettivizzata, filtrata nella forma del romanzo-conversazione, come una coralità colta dal vivo»[34] («Una narrazione quale si potrebbe fare in conversazione da gente che sappia glisser sui punti scabrosi»): tutti elementi che sembrano preannunciare quei canoni dell’impersonalità dell’arte, con l’eclisse dell’autore, la prospettiva dei personaggi come filtro della narrazione, il rifiuto delle intromissioni dell’autore onnisciente, puntualmente e magistralmente perseguiti nei Malavoglia ma minuziosamente enunciati ˗ come si è già detto ˗ nella dedicatoria dell’Amante di Gramigna.
Poi, per la probabile risposta negativa ricevuta dal Treves e certamente per il dolore causatogli dalla perdita della madre, il Verga abbandonò il romanzo e quando superò il ’triste periodo’ si dedicò alla stesura di Padron ’Ntoni (divenuto poi I Malavoglia). Nonostante il parziale insuccesso dell’opera, lo scrittore siciliano, com’è noto, rimase persuaso della «giustezza delle scelte operate»[35] («Se dovessi tornare a scrivere quel libro, lo farei come l’ho fatto», confidò in una lettera a Luigi Capuana l’11 aprile 1881) e progettò subito di dedicarsi al Mastro don Gesualdo, pure per le sollecitazioni che in tal senso gli venivano dagli amici e dallo stesso Treves, il quale, anzi, in una lettera del 10 aprile 1881, lo esortò vivamente a «pensare a Don Menelao e a Don Gesualdo»[36].
La risposta del Verga non si fece attendere e il 18 aprile 1881, tra l’altro, assicurò l’editore milanese sull’avanzato stato dei lavori del Marito di Elena («Io sto lavorando per voi al vostro Marito di Elena che ho rifatto di sana pianta»[37]).
Cosa significa ‘rifatto di sana pianta’? È verosimile pensare che il Verga, per tacitare in qualche modo le pressanti sollecitazioni del Treves, raccontò una bugia e scrisse ‘l’ho rifatto’ invece di precisare ‘lo sto rifacendo’, assumendosi l’impegno della consegna a breve scadenza contando molto probabilmente sull’abbozzo steso nell’estate-autunno del 1878 e poi riposto nel cassetto. Sennonché, quell’abbozzo dovette sembrargli inadeguato «alla luce delle più sicure e più consapevoli scelte ’veriste’ maturate nel corso della stesura»[38] dei Malavoglia; subito, pertanto, lo scrittore catanese «avvertì il bisogno di una sua globale revisione»[39], di una nuova stesura, completamente diversa rispetto a quella annunciata nella lettera del gennaio ’79.
Progettò di cambiare l’ambientazione (ci torneremo più avanti) e modificò radicalmente l’impianto diegetico, per quanto mantenne inalterato il profilo del protagonista: un marito ingannato, tradito, disposto ad accettare il disonore, vile, il quale, però, mentre nella prima stesura, in un’impennata d’orgoglio, reagiva in qualche maniera e assassinava l’ultimo amante della moglie, riportando così una qualche ‘vittoria’, nella seconda stesura, uccide la moglie e risulta pertanto completamente e definitivamente ‘vinto’, avendo eliminato l’unica ragione di vita: Elena.
Siffatte significative e non lievi modifiche evidentemente allungarono i tempi di composizione e di pubblicazione del romanzo, ma lo allinearono, o almeno lo avvicinarono, alle scelte in direzione ’verista’, convintamene operate dal Verga e costantemente perseguite, oltre che nei Malavoglia anche nel Marito. Ecco perché, pure sulla scorta delle affermazioni dello stesso scrittore che «ritenne i due romanzi inscindibilmente legati tra di loro, affini e congiunti come fratelli»[40], il Marito va considerato, «tra il 1878 e il 1881, impegnata prova narrativa su un intreccio di tensioni tematico-stilistiche d’impianto positivistico-naturalistico, fortemente connesse con il ciclo dei Vinti, e cioè a ridosso, contemporaneamente e subito dopo i Malavoglia»[41].
Di tale impegno danno atto le numerose lettere e, soprattutto, il manoscritto del Marito, conservato presso la Biblioteca Universitaria di Catania con segnatura Ms.U.239.83[42], un autografo che rappresenta le ultime volontà dell’autore, «ma attesta pure un faticoso e complesso percorso correttorio»[43]. Di sicuro, questo conservato a Catania è il manoscritto che servì per la stampa: lo dimostrano, ad esempio, i nomi e le indicazioni del proto (ad esempio, “letto”, “lasciato”), le numerose varianti e gli altrettanto numerosi rifacimenti di intere parti, tutti accolti nella stampa finale, come ha magistralmente dimostrato Francesca Puliafito nella recente edizione critica prima citata, allestita in maniera impeccabile dal punto di vista filologico.
Senza addentrarmi troppo nello specifico (sarebbe oltretutto impossibile ricostruire tutti i passaggi, considerato che Verga soppresse alcuni fogli, utilizzò il verso di altri, talvolta il verso di fogli di altre opere, non di rado sovrappose strisce di carta sulla precedente scrittura), mi limito a segnalare, ad esempio, la numerazione dei fogli, a proposito della quale Gino Rizzo, con la consueta acribia, notava:
Se si fa attenzione alla numerazione dei fogli del manoscritto, risulta subito evidente che l’ultimo assetto del Marito fu raggiunto dopo non poche perplessità sullo stesso ordito del romanzo. Ne è chiara e lampante testimonianza proprio il fatto che su numerosi fogli (questo avviene per una buona parte dell’autografo) si sono succedute varie numerazioni a penna e a matita colorata, sovrapposte o espunte da marcati tratti di penna, pure con salti rilevanti[44].
La pagina 5 del manoscritto dimostra, ad esempio, come il Verga, nella fase finale della stesura del romanzo, mutò l’ambientazione del racconto; sostituì Catania-Mineo con Napoli-Avellino e dintorni, senza tuttavia modificare sostanzialmente la descrizione dei luoghi, le cui linee rimangono inalterate, in un tentativo non proprio felicemente riuscito di cercare di dissimulare, attraverso una toponomastica più anodina, quelle istanze lirico-autobiografiche evidenti nell’originaria ambientazione e non proprio in linea con il canone veristico della rappresentazione del fatto ‘nudo e crudo’. Da segnalare poi il fatto che, secondo alcuni critici, esiste una incongruenza evidente tra alcune epoche dei fatti (ottobre, la vendemmia, ecc.) e la descrizione della campagna circostante, lussureggiante come nella stagione estiva e che ben s’attaglia all’esuberanza e alla deflagrante grazia muliebre di Elena.
Ben più significativo però appare il netto e deciso stravolgimento dell’impianto diegetico del romanzo: Cesare, il marito di Elena, non uccide l’ultimo amante della moglie ma la moglie. Sicché, dall’originario romanzo giudiziario, nel quale la scena, in un’aula di tribunale, si apriva con l’arringa dell’avvocato difensore, si passa ad indagare a tutto tondo l’aspetto psicologico dei personaggi, scavando nell’animo di essi per «comprendere e spiegare le passioni umane e le cause degli eventi che ne scaturiscono»[45], in linea pure con talune istanze del naturalismo ˗ lo si è già detto ˗ per ciò che riguarda le interconnessioni ambiente-carattere o le leggi del bisogno.
Il marito di Elena, dunque, fu scritto in due stesure, la prima nel 1878 e la seconda e definitiva nel 1881, negli anni decisivi della maturazione ‘verista’ dello scrittore catanese, «col radicale mutamento di prospettive ideologico-letterarie secondo autonoma e individualizzata assunzione della poetica veristica: impersonalità dell’arte, artificio della regressione, narratore popolare, utilizzazione dell’erlebte rede, ecc.»[46].
E allora il lettore viene immediatamente catapultato in medias res, nel bel mezzo della vicenda senza «l’artificio ‘falso e insopportabile’ della messa in scena (descrizione-studio-profilo-presentazione dei personaggi)»[47]. In conformità con le scelte già operate nei Malavoglia e, soprattutto, con quanto avverrà nel Mastro, il Verga avvia il romanzo con il trambusto in casa di Elena per la fuga di costei, spostando in avanti (cap. III) la presentazione del protagonista, non più psicologicamente già formato sin dall’inizio, e in linea con quanto accadrà in casa Trao in apertura del Mastro Don Gesualdo, con la «connessa sottolineatura di suoni e immagini (picchiò, strillare, gridare, guaire, correndo all’impazzata, insaccarsi nel vestito, assettava la camicia, ecc.)», per trasformare la scrittura in visione di veristica matrice sin dall’avvio del romanzo»[48]. E pur tuttavia, permangono nell’opera taluni echi di «irrisolti e contraddittori dinamismi interni: paese-nido / paese pregiudizio-pettegolezzo; mito della famiglia / suo sfacelo; figura materna / adultera; mito della roba / suo disfarsi nel lusso-apparenze»[49]. Allo stesso modo convivono scelte strutturali e linguistiche diversamente connotate: ad esempio, la considerazione senz’altro riconducibile ai modi dell’autore onnisciente «Dio solo può sapere quali idee passassero in mente a quel marito e a quella moglie, seduti tanto vicini sul medesimo balcone»[50] e, nel contempo, il lungo passo, reso con la tecnica del discorso indiretto libero[51], dal quale emerge, quando Elena cede alle avances del barone, la corale e collettiva condanna del paese, «microcosmo astioso e malevolo, impietoso e bisbigliante, vociferante, chiuso nel cerchio di un nefasto chiacchericcio»[52].
Ecco! Quando il Verga scrive al Treves «l’ho rifatto di sana pianta», probabilmente si riferisce all’impianto diegetico dell’intero romanzo e, in particolare, all’avvio, alle prime pagine, scritte certamente ex novo dopo il primo abbozzo-stesura (lo dimostra il fatto che esse appaiono decisamente più pulite, per così dire), nel quale tuttavia (siamo nel 1878-1879) già baluginavano alcuni evidenti motivi di matrice verista.
Alcune brevi considerazioni e mi avvio alla conclusione: nei primi due capitoli il nome del protagonista è Anselmo, sostituito poi nella revisione finale da Cesare: dunque, il nome scelto per il protagonista in una seconda fase redazionale è Anselmo. Perché? Probabilmente, il Verga aveva pensato di affidarsi al collaudato ‘schema parentale’ presente nei Malavoglia (Padron ’Ntoni-‘Ntoni) e riproporlo, con tutte le implicazioni, nel Marito di Elena (il canonico zio Don Anselmo-Anselmo); poi però, forse anche per lo scarso favore con cui era stato accolto il primo romanzo ma più verosimilmente per altre considerazioni (necessità di ripensare in toto il profilo diegetico del Marito ma impossibilità di dilatare ulteriormente i tempi di consegna al Treves del manoscritto, ad esempio), decise di abbandonare quello schema, almeno in parte. Al contrario, tuttavia, risultano evidenti talune affinità sia con i Malavoglia che con il successivo Mastro Don Gesualdo, a testimonianza di un processo di adesione ai canoni del verismo in atto alla fine degli anni Settanta ma già avviato dal Verga intorno al 1874-1875.
Qualche esempio: la casa dove abitano i parenti di Cesare, con una «finestra tutta verde del noce dell’orto» (cap. IV)[53], in qualche misura richiama la Casa del nespolo; come il giovane ‘Ntoni, che ha ‘infranto’ le regole, non può far ritorno alla casa del Nespolo, così Cesare, dopo la fuga, ripeterà alla madre (cap. IV): «No, mamma! Io non posso più tornare a casa»[54]. E ancora, come nella Prefazione ai Malavoglia il Verga aveva scritto: «Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso…»[55], così, nel Marito, nel momento in cui la madre di Cesare, Barbara, deve far ritorno al paese da cui si era allontanata per andare a trovare il figlio (cap. IV), conclude: «[Cesare] rifletteva che sua madre andava calmandosi essa pure, pensando alla famigliuola che l’aspettava al villaggio. Così la fiumana della vita li ripigliava e li allontanava sempre più»[56].
E si potrebbe continuare con numerosi altri esempi; aggiungo soltanto che in taluni passi, soprattutto nelle sequenze descrittive, non è difficile cogliere somiglianze con il Mastro Don Gesualdo: ad esempio, la dettagliata descrizione delle terre del barone (uno degli amanti di Elena) riecheggia per strutture linguistico-lessicali l’’amorevole’ passare in rassegna dei suoi possedimenti di Gesualdo[57] e, in qualche misura, pure l’ossessivo attaccamento alla ‘roba’ di Mazzarò.
Non sempre le scelte risultano particolarmente felici; talvolta, anzi, la prosa appare incistata per ridondante e insistito ricorso a echi letterari di sicura ascendenza ma poco funzionali alla fluidità del racconto: cito solo un paio di esempi. Nel cap. III, per descrivere i momenti iniziali del rapporto tra Cesare ed Elena, in particolare le prime visite di Cesare a casa di Elena, il Verga ricorre ad un’evidente eco dantesca: «Ella [Elena] non aveva detto al giovane avvocato venti parole, quantunque fossero stati soli e senza alcun sospetto un centinaio di volte […]»[58], che riprende il celeberrimo «soli eravamo e sanza alcun sospetto» pronunciato da Francesca (Inferno, V, 129); nel cap. VII, per rendere le angosce, le sofferenze di Cesare, tutto preso dalla preoccupazione di rendere felice Elena, anche a discapito del proprio benessere, ancora un’altra evidente eco dantesca: «Per lui solo le meditazioni penose, i tentativi umili, l’andar su e giù per le scale altrui […]»[59].
In conclusione, le due stesure del Marito di Elena (1878 e 1881) recano evidente testimonianza di un lungo e tormentato percorso ideologico-letterario, di un iter compositivo che presenta «nuclei tematico-espressivi che talora si confrontano e si contrappongono ad indicare fondamenti ideologici diversi e comunque in continuo sviluppo e progressivo chiarimento in un tempo di accelerata maturazione delle scelte veriste del Verga»[60]. Forse progettato all’inizio come ‘un intermezzo-passatempo’, non può essere considerato un ritorno ai moduli preveristici, né alla stregua di una sorta di reazione alla pessima accoglienza riservata ai Malavoglia. Tanto che, quando riprese l’abbozzo del 1878-’79, il Verga avvertì la necessità di ‘rifarlo di sana pianta’; altro che qualche ritocco, qualche aggiustamento: quel ‘marito ingannato’, del quale lo scrittore parlava nella lettera al Treves, connotandolo già nel 1878 con le caratteristiche tipiche dei ‘vinti’ del ciclo, reclamava ora un definitivo profilo in quella direzione. Ciò che dilatò oltre ogni previsione i tempi di composizione e, quindi, di consegna del manoscritto, per il quale il Verga aveva già percepito il compenso. Egli, però, non riuscì a completare come avrebbe voluto il rifacimento del romanzo; a proposito del protagonista si rammaricò per essersi «incaponito a spiegare minuziosamente come si arrivi ad esser tanto abbietti»[61]; con riferimento all’opera nel suo complesso, confidò al Capuana: «La prima parte può andare ma la seconda è una spina per la mia coscienza» e bollò come ‘aborto’ quel ‘cornuto Marito di Elena, dichiarandosi addirittura ‘indispettito’ e manifestando incredulità e insofferenza per la ‘balorda’ preferenza accordata al Marito a ‘discapito’ dei Malavoglia («Quel che più m’indispettisce è la preferenza balorda accordata dal pubblico e dalla critica a questo aborto a discapito dei Malavoglia»[62]).
Per diverse ragioni, insomma, Il Marito di Elena non convinse nemmeno lo stesso autore, tanto da
indurlo a confidare al Capuana: «Detesto Il
marito di Elena, ma troppo tardi»[63].
Il romanzo, infatti, avrebbe richiesto un rifacimento più completo, più
radicale, un’elaborazione più lunga e articolata; ormai, però, era troppo
tardi: gli impegni assunti con il Treves andavano onorati, e rapidamente;
perciò il Verga dovette ultimare e consegnare in tempi rapidi, sul finire del
1881, il manoscritto dell’opera, la quale, pertanto, pur considerando
l’«intreccio di tensioni tematico-stilistiche d’impianto
positivistico-naturalistico»[64]
che essa sussume, appare una prova narrativa non pienamente riuscita.
[1] M. Vitta, Introduzione, in G. Verga, Il marito di Elena, a cura di M. Vitta, Milano, Mondadori, 1980 (poi ristampato nel 1995), p. 5.
[2] Alla fine del cap. XIV si legge: «Sì, l’amava ancora il disgraziato! Era geloso al modo dei deboli, senza aver la forza di rompere la sua catena, colla vaga speranza che non osava confessare a se stesso di riconquistare il suo affetto a furia di generosità, di devozione, di rassegnazione persino! – Sì, una viltà! Ma non è la peggiore delle disgrazie esser vile?»: cfr. G. Verga, Il marito di Elena, ed. critica a cura di F. Puliafito, Novara, Interlinea, 2019, p. 176.
[3] T. Iermano, Un dramma intimo, in G. Verga, Il marito di Elena, a cura di T. Iermano, Cava de’ Tirreni, Mephite, 2004, p. 8.
[4] Per l’abbondante messe di studi sul romanzo e per le numerose edizioni, cfr. almeno le esaustive indicazioni che si trovano in G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana: le due redazioni del Marito di Elena, in Id., Filologia e critica tra Sei e Ottocento, Galatina, Congedo, 1996; la ricca Nota bibliografica in T. Iermano, Un dramma intimo…,cit.; F. Puliafito, Introduzione, in G. Verga, Il marito di Elena, cit.
[5] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…, cit., p. 97.
[6] Ivi, p. 98.
[7] Ibid.
[8] A. Momigliano, Verga, in Id., Dante, Manzoni, Verga, Messina-Città di Castello, D’Anna, 1944, p. 216.
[9] Ibid.
[10] Cfr. F. Portinari, Le ‘vampire’ del Maestro, in Le parabole del reale. Romanzi italiani dell’Ottocento, Torino, Einaudi, 1976.
[11] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…, cit., p. 102.
[12] Ibid.
[13] M. Dillon Wanke, “Il marito di Elena”, ovvero dell’ambiguità, in Verga inedito, in «Sigma», X, 1-2, 1977, p. 132.
[14] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…, cit., p. 103.
[15] Ivi, p. 102.
[16] M. Dillon Wanke, “Il marito di Elena”…, cit., pp. 133-134.
[17] G. Raya, Verga e i Treves, Roma, Herder, 1986, pp. 45-46.
[18] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…, cit.
[19] Ivi, p. 104. Anche per altri critici la lettera appare imprescindibile ai fini della «ricostruzione della genesi testuale del romanzo»: cfr., ad esempio, F. Puliafito, Storia del testo, in G. Verga, Il marito di Elena, cit., p. XI.
[20] L’11 aprile 1881 lo stesso Verga aveva scritto all’amico Luigi Capuana: «I Malavoglia hanno fatto fiasco, fiasco pieno e completo»: cfr. G. Raya, Carteggio Verga-Capuana, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1984, pp. 111-112.
[21] G. Raya, Verga e i Treves, cit., pp. 45-46.
[22] Così si espresse il Verga in una lettera del 14 gennaio 1874 a L. Capuana: cfr. G. Raya, Carteggio Verga-Capuana, cit., p. 29.
[23] T. Iermano, Un dramma intimo…, cit., p. 8.
[24] G. Verga, Il marito di Elena, ed. critica a cura di F. Puliafito, cit., p. 20.
[25] Ivi, p. 22.
[26] Ivi, p. 23.
[27] F. Puliafito, Storia del testo, in G. Verga, Il marito di Elena, cit., p. XVI.
[28] G. Verga, L’amante di Gramigna, in Id., Tutte le novelle, Milano, Mondadori, 1975, vol. I, pp. 199-200.
[29] Ivi, p. 200.
[30] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…,cit., p. 105.
[31] Ivi, p. 106.
[32] G. Verga, Il marito di Elena, ed. critica a cura di F. Puliafito, cit., pp. 174-176.
[33] G. Mariani, Linee dell’arte verghiana, in Id., Ottocento romantico e verista, Napoli, Giannini, 1972, p. 348.
[34] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…,cit., p. 106.
[35] Ivi, p. 112.
[36]G. Raya, Verga e i Treves, cit., p. 54.
[37] Ivi, p. 55.
[38] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…,cit., p. 114.
[39] Ibid.
[40] Ivi, p. 117.
[41] Ivi, p. 118.
[42] Per la puntuale descrizione del manoscritto cfr. F. Branciforti, Lo scrittoio del verista, Novara, Interlinea, 2022; T. Iermano, Notizie del manoscritto, in G. Verga, Il marito di Elena, a cura di T. Iermano, cit.; F. Puliafito, Testimoni autografi e a stampa, in G. Verga, Il marito di Elena, ed. critica a cura di F. Puliafito, cit.
[43] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…,cit., pp. 118-119.
[44] Ivi, pp. 119-120.
[45] F. Puliafito, Storia del testo, in G. Verga, Il marito di Elena, cit., p. XIII.
[46] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…, cit., p. 128.
[47] Ivi, p. 119.
[48] Cfr. Ivi, p. 120 e P. Torricelli, Il fuoco in casa Trao. Prosa di suoni e immagini nel primo capitolo del «Mastro Don Gesualdo», in «Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di Messina», 7, 1989.
[49] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…, cit., p. 129.
[50] G. Verga, Il marito di Elena, ed. critica a cura di F. Puliafito, cit., cap. VIII, p. 111.
[51] Ivi, cap. XVI, pp. 186-187.
[52] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…, cit., p. 130.
[53] G. Verga, Il marito di Elena, ed. critica a cura di F. Puliafito, cit., p. 35.
[54] Ivi, pp. 39 e 41.
[55] G. Verga, I Malavolgia, a cura di T. Di Salvo, Bologna, Zanichelli, 1999, p. 4.
[56] G. Verga, Il marito di Elena, ed. critica a cura di F. Puliafito, cit., p. 44.
[57] Cfr., ad esempio, Ivi, cap. V, p. 60.
[58] Ivi, p. 28.
[59] Ivi, p. 93. Riecheggiano le parole con le quali Cacciaguida si rivolge a Dante: «lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale» (Paradiso, XVII, 60).
[60] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…, cit., p. 129.
[61] Lettera al Capuana del 10 agosto 1881: cfr. G. Raya, Carteggio Verga-Capuana, cit., p. 130.
[62] Ivi, pp. 154-155.
[63] Ivi, p. 130.
[64] G. Rizzo, Filologia ed esegesi verghiana…,cit., p. 118.






























































