Così, altra volta, Henry-scultore-Moore m’intratteneva – esperanto improvvisato – sulle temperature della luce. Un gran sofà. Montale casualmente alla mia destra, e Bodini-dimonio oltre Montale.
L’Eusebio mi passava inopportuno un acquerello dopo l’altro, ch’io lo porgessi a Moore da visionare. Eseguivo, tacendo dell’autore, che Moore non ravvisò esser Montale. E subito fu gara divertita, infantile, a bersagliare i ceppi soffocati nel camino degli appallottolati messaggi del vate donpasqualizzato in pietra. E Moore se la spassava come un matto. Sbirciava quei disegni fintattento da dritto a lato a manca, poi a rovescio; s’illuminava e, strizzato un occhio, m’invitava a quel basket da salotto[1].
Questo brano compare anche, con qualche variante, nella Vita di Carmelo Bene, dove termina con un altro riferimento a Bodini e ai suoi ben noti e incontrollabili movimenti corporei: «Vittorio Bodini sghignazzava, tra i suoi tic, come una civetta ammattita»[2].
Un’altra volta, invece, descrisse l’ultimo incontro con lui, ai limiti del verosimile, allorché andò a trovarlo in una clinica romana la notte prima della sua morte portando con sé due bottiglie di pregiato vino francese e provocando l’allarmata reazione da parte degli infermieri:

L’indimenticabile Vittorio Bodini (il più significativo poeta salentino che, bevutissimi, m’intratteneva sulla grandiosità della lingua e della letteratura spagnola, soprattutto da Góngora a Cervantes. Moriva d’irrimediabile cirrosi e cancro al fegato, in una clinica romana. Reiterava in coma il mio nome. Avrei preferito serbarne la figura vivacissima, tarantolata dai tic. Ma non potei sottrarmi all’ultimo brindisi. Mi presentai armato di due rosse bottiglie di Borgogna. Spirò raccomandandomi (in merito a quel santo dei voli mai più da me inscenato: «Comico, devi farlo comico!»). Mi vedo ancora cinturato da infermieri impazziti, scioccozelanti che, trasportandomi via, mi dicevano: «Pazzo sconsiderato! assassino! irresponsabile! Ché non si rende conto della disfunzione epatica del suo amico!». La mia “vittima” era già spirata… [3].
Questo rapporto sfociò anche, come vedremo più avanti, in un progetto televisivo che all’ultimo momento non andò in porto, nonché in una singolare forma di collaborazione, in quanto Bodini interpretò una piccola parte nel film Don Giovanni di Bene, girato nel 1970, l’ultimo suo anno di vita, e un fotogramma spesso riprodotto su giornali e riviste ci trasmette l’immagine spettrale del poeta tutto avvolto in una trama fittissima di ragnatele.
Ma nell’opera di Bodini e Bene esistono anche aspetti comuni, che riguardano proprio il «reale-immaginario»[4] del Salento, che Bene preferiva chiamare il «sud del Sud dei santi»[5] anche per distinguerlo dal resto della Puglia. In un nostro precedente lavoro[6], in particolare, abbiamo individuato tre punti di contatto tra i due: la riflessione sul barocco, che è al centro del presente scritto; la figura, esemplare per entrambi, di san Giuseppe da Copertino, menzionata pure nel brano poc’anzi citato[7]; la presa di Otranto e l’eccidio degli ottocento otrantini da parte dei Turchi nel 1480. Si tratta di fenomeni, personaggi e vicende di carattere identitario che servono loro per scavare in profondità nella storia e nella società salentina. Proprio il film Don Giovanni ci introduce alla riflessione dei due artisti sul barocco, su cui in questi ultimi tempi sono emersi nuovi, sorprendenti e significativi documenti. Per Bodini, inoltre, lo studio del grande barocco letterario spagnolo e dei suoi autori più rappresentativi, da Cervantes a Góngora, da Quevedo a Calderón, fu anche, com’è noto, un aspetto importante del suo lavoro di ispanista e di traduttore[8].
Ebbene, uno degli scritti centrali della poetica bodiniana è Barocco del Sud, apparso per la prima volta in una rivista fiorentina nel 1950[9]. Esso si colloca in un periodo particolare dell’attività dello scrittore che era appena tornato a Lecce dalla Spagna, dove si era trattenuto quasi tre anni, e aveva messo al centro dei suoi interessi e della sua immaginazione la propria terra indagandola nei suoi aspetti più profondi. Nel 1952 infatti, con le Edizioni della Meridiana di Milano, pubblica la raccolta poetica La luna dei Borboni, che si apre con i seguenti versi, quasi programmatici: «Tu non conosci il Sud, le case di calce / da cui uscivamo al sole / come numeri / dalla faccia d’un dado»[10]. Quando l’anno dopo, esattamente il due marzo, questa prosa apparve sulla «Gazzetta del Mezzogiorno», venne intitolata, probabilmente dalla redazione di quel quotidiano, Psicologia del barocco leccese, per definirne meglio il contenuto, proprio perché quella di Bodini era una riflessione sul barocco della sua città che diventa poi la chiave di lettura (o una delle chiavi di lettura) della propria terra, come si può notare leggendo alcune sue poesie (e basti pensare a quella intitolata Lecce, compresa in origine nella raccolta Dopo la luna, del 1956[11]).
Ma come interpreta il barocco leccese Bodini, che ha avuto anche il merito di riscoprire questo fenomeno, a lungo sottovalutato se non disprezzato da studiosi e viaggiatori?[12] Non tanto e non solo appunto come un fenomeno storicamente determinato che pure caratterizza lo stile architettonico delle chiese e dei palazzi di Lecce, la quale per lo scrittore è ancora a tutti gli effetti una «città del Seicento» dove anzi la storia sembra essersi fermata. Qui il barocco è inteso, sulla scia dell’interpretazione del saggista spagnolo Eugenio d’Ors, come categoria che si oppone al “classico” e che trascende il tempo e anche il mondo delle arti. Non a caso esso si estende dalle arti e dall’architettura all’artigianato, ma anche alla morfologia della natura salentina (il barocco «naturale» della «scontorta vegetazione» di ulivi e fichi d’India), nonché all’anima stessa degli abitanti di Lecce, «ai loro astuti ideali e gesticolamenti».
Un ruolo decisivo per la nascita «di questo «assurdo miracolo del barocco leccese» l’ha avuto, secondo Bodini, la pietra locale con cui sono stati edificati le chiese e i palazzi della città:
Santi di tufo vegliano sulle mura della città a guardia del loro secolo. Lecce è tutta costruita in questa pietra poroso che si estrae dai dintorni e che appena tagliata ha la morbidezza e il colore della polpa di banana. Un temperino può scolpirla, e questa docilità ad assecondare le più estrose richieste dell’immaginazione non avrà mancato di avere un effetto decisivo sulla nascita di questo assurdo miracolo del barocco leccese, sorto con caratteri propri e inconfondibili in una città così separata e lontana dai centri vivi dell’arte. È probabile che una materia di maggiore resistenza sarebbe stata una bara per una fantasia così irrequieta e volubile, avvezza per lo più a bruciare i propri fantasmi prima ancora di realizzarli[13].
Ecco allora che il barocco leccese diventa, per lo scrittore, una condizione dello spirito in cui si riflette un disperato senso del vuoto, un horror vacui, che si cerca di colmare con l’esteriorità, l’ostentazione, l’oltranza decorativa, ma anche con certi atteggiamenti visti come altrettanti modi per sfuggire al sentimento del negativo che si avverte «in questa estrema pianura dove l’Europa ha termine». Da qui la lotta incessante tra vuoto e pieno, tra luce e ombra, che si volge sulle facciate degli edifici barocchi di Lecce e che allude a quella, ben più concreta, tra la vita e la morte, tra l’esistere e il suo contrario:
Da questo terreno è nata in un supremo momento di grazia, poi venuta a mancare, una complicata foresta di figure e di simboli destituiti di senso, al di fuori d’una frenetica eleganza in cui un’intera popolazione non priva di sangue arabo e aragonese e più remotamente greco, ha giocato tutte le sue carte, gareggiando col caso nel creare un numero infinito di combinazioni d’una lucidissima incoerenza.
Guardate come neanche il più piccolo spazio è lasciato libero: il vuoto e il troppo semplice si direbbe che repugnino all’artefice quasi sempre anonimo di questi prodigi, in cui non c’è esagerazione che non sia prontamente ricondotta nei confini di un’abile finezza[14].
D’altra parte, la stessa città di Lecce, più che un luogo della geografia, è per lo scrittore «una condizione dell’anima», dove sembra «s’arrivi solo casualmente, scivolando per una botola ignorata della coscienza»:
Non si riesce a capire com’abbia fatto il Seicento a scavalcare queste terribili inerzie dello scirocco, e a scoprire la verità dell’arte gettandosi a capofitto nei più deprecabili errori. L’arte è nata nel punto più incredibile: nel divertimento spinto al suo parossismo, alla frenesia. Ed è che nel duello fra l’angoscia del nulla e il cieco impulso a sottrarvisi, l’attività creatrice ha oltrepassato il proprio stimolo, liberando con quel “di più” una fantasia pura e invaghita della libertà casualmente acquistata. Ecco perché in presenza di questi tufi squisiti si ha fermamente il sospetto che quest’arte sia meno al servizio di Dio che del suo Avversario[15].
In una avvertenza finale, l’autore precisava che quel testo era servito da traccia per un documentario, Cantarono nel ‘600, realizzato l’anno prima dal regista parmense Antonio Marchi. Del documentario, fino a poco tempo, fa si erano perse completamente le tracce A distanza di oltre settant’anni, invece, esso è stato inaspettatamente ritrovato in un fondo della Cineteca nazionale dal regista Primo Giroldini, anch’egli di Parma[16].
Il cortometraggio, in bianco e nero, della durata di 8’10’’, prodotto dalla Cittadella Film-Filmeco, con sottofondo musicale di Paul Abel, è un documento di particolare rilievo e valore storico-culturale. Lo scrittore incomincia costruire, qui e nella prosa citata, il mito della cittadella barocca, «vedova del suo tempo», dove la storia non riesce a procedere. Una chiave interpretativa della sua città per lui era rappresentata proprio, come s’è detto, dal barocco inteso nel senso che si è cercato di chiarire poc’anzi. Nel documentario, però, destinato a un pubblico più ampio (di solito questo genere di opere veniva abbinato a un film che si proiettava nelle sale cinematografiche), questa interpretazione è assente e il carattere lirico-evocativo della prosa è sostituito dal tono più neutro e descrittivo del commento parlato, sempre di Bodini.

Le immagini si soffermano su alcuni dei monumenti più significativi del capoluogo salentino: la facciata di Santa Croce, «quasi una selva di figure e di simboli»[17], su cui si incentrerà esclusivamente, come vedremo, il documentario di Bene, del 1968, dedicato appunto al barocco leccese; la chiesa di San Matteo che presenta una «più salda e evidente struttura architettonica in armonico equilibrio con gli elementi decorativi»; Piazza del Duomo, dove spicca la «sobria intonazione stilistica della chiesa», opera dello Zimbalo, che «riuscì a cancellare completamente sulla facciata ogni traccia dell’originaria forma romanica»; la chiesa del Rosario, dove «l’arte seicentesca completamente libera raggiunse un suo stato di grazia creando un incanto perfetto». Ma la macchina da presa mette in luce anche, quasi accarezzandoli, certi suggestivi dettagli: l’infinità dei balconi leccesi che «presentano un nuovo assortimento di faune e popolazioni», le cariatidi e gli «strani personaggi» scolpiti nella docile pietra locale.
Non mancano nemmeno i riferimenti ai «segreti legami con la Spagna, col Messico» e un accenno alle moderne figure di cartapesta, «che forse non meno del barocco hanno resa famosa la città». Una sorta di filo conduttore è rappresentata dalla processione dei chierichetti e delle “angiolette” che sfilano davanti alle chiese cittadine. Costituisce una curiosità invece l’immagine dell’antica fontana con i cavalli alati in Piazza Duomo, successivamente abbattuta. Lo stesso Bodini, infine, compare nel documentario mentre suona la chitarra, quasi a dare il senso di un totale coinvolgimento nella narrazione.
Anche per Carmelo Bene la riflessione sul barocco è stata centrale in tutta la sua attività artistica. Non a caso i critici hanno fatto spesso riferimento al barocco, e a quello leccese in particolar modo, parlando della sua opera teatrale e cinematografica[18]. Già Ennio Flaiano, in una recensione del suo spettacolo Il Rosa e il Nero, andato in scena a Roma, al Teatro delle Muse, il 12 ottobre 1966, lo tirava in ballo insieme all’artigianato di cartapesta e, ancora una volta, alla figura identitaria, e tanto amata da Bene e Bodini, di san Giuseppe da Copertino: «Non a caso – scriveva Flaiano – Carmelo Bene è nato a Lecce, nel barocco più fiorito, dove sopravvive un artigianato di santari di cartapesta e dove Giuseppe (da Copertino) fu elevato alla gloria degli altari grazie ai voli che spiccava in chiesa evoluendo elegantemente sui fedeli, riscoprendo che la meraviglia è il fine non solo del poeta ma dell’attore»[19].
Anche un autorevole studioso di Bene ha osservato che «all’“origine” [della sua arte] deve aver pesato la visione e il gusto di un barocco leccese, fatto di facciate e cornici e balconi, fioriti di simboli, scolpiti su una pietra morbida, rapidamente deformata e erosa, subito illeggibili e d’un tratto persino invisibili. Assenti!»[20].
D’altra parte, anche per i primi due film, Nostra Signora dei Turchi e Capricci, i critici avevano parlato di barocco e lo stesso Bene, in una occasione, aveva definito «barocco» il suo teatro in quanto «senza centro»[21], come tutta l’arte moderna. Per quanto riguarda specificamente il barocco leccese, invece, egli ha spesso negato una diretta influenza sulla sua opera, forse per non legarla direttamente al territorio d’origine e non darle, in tal modo, un senso limitativo. E infatti, nel corso di un’intervista, a una domanda sulle sue «origini etniche», pur riconoscendo l’importanza di esse, così rispondeva:«Ecco, avere avuto nascendo un piede in terra d’Otranto, è stato per meimportante. È una culla particolare della grecità antica, poi i turchi, poi uncattolicesimo tollerante con la cultura islamica. Questa confluenzagrecoaraba è una sorgente importante, ma non, badi, come dicono di me, ilbarocco leccese»[22].
[In Da questo altrove. Carmelo Bene e il Sud del
Sud dei santi. Una cartografia, a cura di S. Giorgino e A. Paiano,
Martignano, Kurumuny, 2023, pp. 39-58].
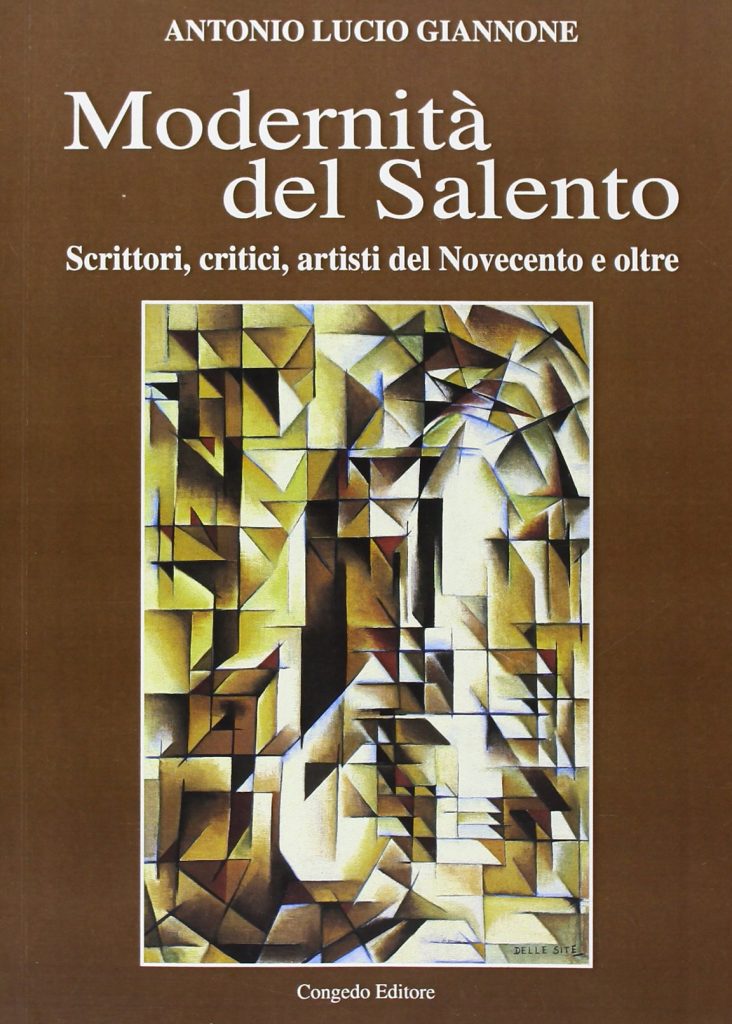
[1] C. Bene, Sono apparso alla Madonna, in Id., Opere. Con l’Autografia d’un ritratto, Milano, La nave di Teseo, 2023, p. 758.
[2] C. Bene-G. Dotto, Vita di Carmelo Bene, Milano, Bompiani, 1998, p. 191.
[3] Ivi, p. 382.
[4] C. Bene, Sono apparso alla Madonna, in Id., Opere…, cit., p. 693. Ma questa espressione compare anche altre volte nell’opera di Bene.
[5] Ivi, p. 740.
[6] Cfr. A.L. Giannone, Nel «sud del Sud»: il Salento di Vittorio Bodini e Carmelo Bene, in «L’Idomeneo», n. 6, 2004, pp. 71-80, poi in Id., Modernità del Salento. Scrittori, critici e artisti del Novecento e oltre, Galatina, Congedo, 2009, pp. 55-60.
[7] Sull’interpretazione della figura del santo da parte di Bene cfr. pure S. Giorgino, «Bisogna tagliare lo filo». L’estasi di San Giuseppe da Copertino fra Carmelo Bene e Orodè Deoro, in Bisogna tagliare lo filo. L’estasi di San Giuseppe da Copertino fra Carmelo Bene e Orodè Deoro, a cura di L. Nolasco, Neviano, Musicaos editore, 2021, pp. 1-17.
[8] Su questo aspetto cfr. O. Macrì, Vittorio Bodini ispanista, in Le terre di Carlo V. Studi su Vittorio Bodini, a cura di O. Macrì, E. Bonea, D. Valli, Galatina, Congedo, 1984, pp. 625-679.
[9] In «Letteratura / Arte contemporanea», a. I, n. 6, novembre-dicembre 1950, pp. 52-54.. Ora è compreso in V. Bodini, Barocco del Sud, a cura di A. L. Giannone, Nardò, Besa, 2004, pp. 79-83.
[10] V. Bodini, Tutte le poesie (1932-1970), Introduzione e edizione di O. Macrì, Milano, Mondadori (“Oscar”), 1983, p. 91. Di questa edizione esiste una ristampa delle edizioni Besa di Nardò.
[11] Poi in V. Bodini, Tutte le poesie (1932-1970), cit., p. 122-123.
[12] Sulle varie interpretazioni del barocco leccese ci sia permesso di rimandare a A.L. Giannone, «Un carnevale di pietra»: interpretazioni del barocco leccese nel Novecento, in Id., Scritture meridiane. Letteratura in Puglia nel Novecento e oltre, Lecce, Edizioni Grifo, 2020, pp. 211-222.
[13] V. Bodini, Barocco del Sud, cit. p. 80. Tutte le citazioni sono tratte da questo testo.
[14] Ivi, p. 81.
[15] Ivi, p. 83.
[16] Su questa vicenda cfr. M. Grasso, Un poeta, un regista e il barocco leccese: Vittorio Bodini e Antonio Marchi, in Metodo e passione. Studi sulla modernità letteraria in onore di Antonio Lucio Giannone, a cura di G. Bonifacino, S. Giorgino, C. Santoli, Napoli, La scuola di Pitagora, 2022, II vol., pp. 703-722.
[17] Tutte le citazioni sono tratte dal commento parlato di Bodini.
[18] Cfr. anche, ad esempio, Carmelo Bene. Il circuito barocco, a cura di M. Grande, Roma, Centro sperimentale di cinematografia, 1973.
[19] E. Flaiano, rec. a Il Rosa e il Nero, in «L’Europeo», 10 novembre 1966; poi in C. Bene, Opere. Con l’Autografia d’un ritratto, cit., p. 945 e, in parte, in C. Bene-G. Dotto, Vita di Carmelo Bene, cit., p. 165.
[20] P. Giacché, Carmelo Bene. Antropologia d’una macchina attoriale, Milano, Bompiani, 20072, p. 114.
[21] Uscite dalle cantine e vedremo chi siete, intervista cura di F. Cordelli, in «Paese Sera», 7 ottobre 1973; poi in C. Bene, Si può solo dire nulla. Interviste, cit., p. 236.
[22] Bene: Nostra Signora la Voce, intervista a cura di P.F. Listri, in «La Nazione», 2 dicembre 1982; poi in C. Bene, Si può solo dire nulla. Interviste, cit., p. 881.




























































