Non sfuggono a questi consolidati canoni della letteratura odeporica nemmeno le pagine raccolte da Levi nelle Parole sono pietre, nelle quali l’autore intende descrivere la realtà sfaccettata della Sicilia in tutti i suoi diversi e spesso contrastanti aspetti, in un momento particolare di transizione e di mutamento profondo, qual era quello dei primi anni Cinquanta. Così, da un lato, vi sono rappresentati gli aspetti più drammatici e nascosti di questa realtà, che ispirano le parti ancora oggi più emozionanti e coinvolgenti del libro, come la descrizione delle terribili condizioni di vita e di lavoro dei minatori di Lercara Friddi, dei braccianti di Bronte e dei contadini di Sciara, e dei loro tentativi di affermare la propria dignità di uomini, nonostante la resistenza opposta ad essi da forze avverse come la mafia e il feudo. Ma, dall’altro, trovano posto nel libro anche gli aspetti più appariscenti e noti della realtà siciliana, riguardanti gli splendidi paesaggi naturali, i monumenti e i vicoli di Palermo e di Catania, i resti di una civiltà millenaria, il lusso della nobiltà e le innumerevoli manifestazioni folcloristiche, che fanno parte del più tipico “colore locale” dell’isola: il Cimitero dei Cappuccini di Palermo, i carretti dipinti, i “mostri” di Bagheria, l’Opera dei Pupi, le specialità dolciarie, le tradizioni religiose, i cantastorie, la “festina” di Santa Rosalia con le gare dei fuochi d’artificio, la “Vucciria”, i paladini di zucchero, ecc. Né bisogna meravigliarsi di questo. Qui non ci troviamo di fronte infatti a saggi di tipo teorico o politico, né a inchieste o a semplici cronache, ma a scritti creativi, che pure indagano nella realtà più sconvolgente della Sicilia degli anni Cinquanta e sono tuttora strumenti formidabili di conoscenza della nostra storia più recente. C’è da aggiungere inoltre che spesso quelle parti più leggere e disimpegnate, che a taluni critici sono parse addirittura superflue, sono invece strettamente funzionali al racconto, perché mettono in rilievo, come cercheremo di dimostrare attraverso una lettura unitaria dell’opera, proprio il contrasto di problemi, di situazioni, ambientali e sociali, esistenti nell’isola.
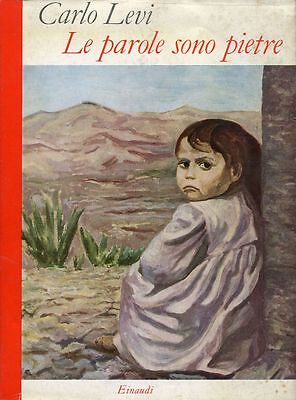
Non a caso Gaetano Trombatore, nella sua recensione al libro, ritrovava qui lo schema dei viaggi in Sicilia inaugurato nell’Ottocento da Leopoldo Franchetti con le sue famose inchieste: “Anche l’esperienza di Levi ‒ scriveva ‒ procede su due parallele: quella delle bellezze naturali, della ricchezza del suolo, dei millenni di civiltà; e quella delle piaghe sociali, della miseria, del feudo e della mafia” (3). D’altra parte Levi era a tal punto consapevole della natura di queste sue pagine che, come confessa nell’Introduzione, dopo essere stato lungamente incerto, decise di escludere, proprio per la diversità del “genere”, e quindi anche dello stile, uno scritto strettamente collegato a questi per l’argomento trattato e composto alla fine del secondo viaggio in Sicilia, intitolato Contadini di Calabria, che era apparso in rivista nel ’53 (4). Questo articolo, infatti, scrive Levi, era una “relazione precisa e minuziosa sullo stato delle cose nelle prime terre della Riforma nell’anno 1952”. In esso “lo stile letterario vi è perciò, naturalmente, almeno in parte, diverso […] risente dell’inchiesta; l’attenzione vi è rivolta a un problema, sia pure nei suoi riflessi psicologici e umani, piuttosto che [come succede nei reportages] a quello che delle vicende e delle cose l’occhio scopre, senza prevenzioni o programmi, sul viso degli uomini e dei paesi” (p. 21). E in effetti il tono dello scritto, asciutto e serrato, è completamente diverso da quello del libro: l’autore qui va al sodo del problema, attraverso la pura registrazione delle reazioni dei contadini, dei funzionari, dei tecnici di fronte alla difficile attuazione della riforma agraria, senza quelle divagazioni, quegli abbandoni, quei compiacimenti letterari che invece qui, come s’è detto, non mancano.
Gli scritti raccolti nelle Parole sono pietre hanno un’importanza e un significato particolari nella produzione di Levi perché segnano il ritorno dello scrittore al Sud vent’anni dopo l’esperienza del confino lucano, da cui era scaturito il Cristo. Ovviamente assai diverse sono la situazione storica, l’occasione, le circostanze che hanno ispirato le due opere e diverse sono anche le conclusioni a cui perviene Levi. Mentre lì, infatti, aveva scoperto un mondo immobile, fuori della storia, immerso in una dimensione atemporale e magica, ora si accorge che quel mondo, sia pure lentamente e a prezzo di enormi sacrifici, ha incominciato a muoversi, a prendere coscienza di sé, e a entrare finalmente nella storia, rompendo quella situazione stagnante in cui si trovava a vivere da sempre. Questo è, indubbiamente, il motivo principale del libro, presente anche in due altri scritti collegati in qualche modo ad esso, che lo stesso Levi richiama nell’Introduzione: il già citato Contadini di Calabria (1953) e la Prefazione a L’uva puttanella di Rocco Scotellaro, che apparve lo stesso anno, nel 1955.
Nel primo, rispondendo a una domanda di una signora che gli aveva chiesto che cosa fosse avvenuto, nei paesi contadini, vent’anni dopo i tempi del Cristo si è fermato a Eboli, egli scriveva che “molte cose erano avvenute, e molte andavano maturando nella profonda vita del paese: ma che di tutte la più importante era […] la fine della secolare immobilità contadina, la rottura di quella situazione cristallizzata e feudale che teneva da tempo immemorabile chiusa la vita del Mezzogiorno d’Italia” (5). Altrettanto chiaramente nella Prefazione a L’uva puttanella sosteneva che “l’uva puttanella è il mondo contadino che per la prima volta si muove, che per la prima volta prende coscienza di sé, e pur sentendo la disperazione e l’angoscia della sua nuova lotta, pur sentendo il peso tradizionale delle forze che tendono a chiuderlo nella secolare immobilità […] tuttavia si muove e non torna indietro e oscuramente si dice che, forse, gli ultimi saranno i primi” (6). Sotto questo aspetto, quindi, il discorso che Levi fa per la Sicilia nelle Parole sono pietre, ferme restando le peculiarità della situazione siciliana, si può considerare valido per tutto il Mezzogiorno.
Al contrario però di quello che succede in questi due scritti, nel libro sono meno evidenti le personali convinzioni ideologiche di Levi, il quale qui si limita a riferire quello che ha osservato, senza prevaricazioni e prevenzioni di tipo ideologico appunto. Non ripropone cioè, almeno esplicitamente, quella tanto discussa e contestata concezione dell’autonomia contadina, che numerose polemiche aveva suscitato tra gli intellettuali marxisti fin da quando l’aveva esposta nelle pagine conclusive del Cristo, e basti pensare agli articoli di Mario Alicata e Carlo Muscetta (7). L’unica volta che compare questa espressione è nell’Introduzione, con riferimento per l’appunto a Contadini di Calabria. Tanto è vero che anche per questo motivo il libro venne accolto in maniera complessivamente positiva dalla critica marxista del tempo (com’è noto, gli venne assegnato anche il Premio Viareggio nel 1956).
Giorgio Napolitano, ad esempio, scrisse che da Le parole sono pietre “le astrazioni e deformazioni ideologiche sono quasi totalmente bandite” e che invece “quelle che danno il tono al libro sono ben vive e concrete esperienze, fatte per di più a contatto col movimento reale, col movimento organizzato dei contadini e dei lavoratori meridionali” (8), vale a dire con i partiti della classe operaia e con il sindacato, mentre criticava duramente la Prefazione a L’uva puttanella, uscita quello stesso anno, e la concezione dell’autonomia contadina che li veniva ancora una volta riproposta e così terminava il suo articolo: “Al Levi ideologo preferiamo francamente, e di gran lunga, il Levi delle Parole sono pietre ” (9). Analogamente Carlo Salinari sosteneva che qui lo scrittore, soprattutto nell’ultima parte del libro, era andato “oltre le premesse teoriche dell’introduzione (e anche e soprattutto di quelle della presentazione del nuovo volume di Rocco Scotellaro, L’uva puttanella…)”, in quanto qui “la concezione dell’autonomia contadina acquista il suo giusto valore e la sua reale misura venendo a coincidere con la esigenza non sopprimibile della creazione di strumenti autonomi del riscatto contadino (nei quadri, nei modi di lotta, nella stessa organizzazione) all’interno del generale movimento di emancipazione dei lavoratori e di rinnovamento della società” (10). E anche Niccolò Gallo parlava di un “Levi meno velleitario ideologicamente, più disposto a piegarsi dinnanzi alla realtà” (11).
E ora passiamo ad esaminare il libro più da vicino, rivolgendo un’attenzione particolare alla sua struttura. Le parole sono pietre è preceduto da una lunga Introduzione, che dà modo a Levi di entrare già nel vivo degli argomenti affrontati nelle pagine successive, sia che accenni alla vicenda del giovane pittore di Cesena, al quale viene impedito, dal padrone delle miniere, con la complicità delle autorità locali, di dipingere e di fotografare i minatori di Lercara al lavoro, sia che racconti di un invito rivoltogli, anni prima, da una piccola banda di briganti-contadini siciliani, sia che aggiorni il lettore sulle vicende narrate più avanti. La parte centrale di essa è dedicata proprio allo scritto Contadini di Calabria, che qui viene sintetizzato e permette a Levi una commossa rievocazione di Rocco Scotellaro, scomparso da appena due anni, con cui aveva compiuto appunto il viaggio nei paesi di Calabria e con cui aveva condiviso le idee sull’autonomia contadina e la speranza di un risveglio del mondo contadino meridionale:
Nel mio racconto non avevo parlato di lui, ma tuttavia egli era presente in ogni pagina, in ogni parola. Non mi aveva lasciato un momento in questa breve corsa nelle terre della Riforma; e volle prendere per me gli appunti, con l’affettuosa modestia dei suoi modi di ragazzo, scrivendoli, come era sua abitudine, su pezzetti di carta, su pacchetti di sigarette, su scatole di cerini; parlò con i contadini con quella sua capacità di rapporto diretto che riusciva ad aprire facilmente anche le bocche e gli animi più serrati, discusse con gli astratti propagandisti trovati a Melissa, cantò coi cantori albanesi quando ci fermammo la sera, che sull’altipiano cadeva un primo freddo nevischio (p. 22).
La Parte prima contiene tre episodi di argomento e tonalità assai diversi, che si alternano come in una sorta di ideale trittico siciliano. Il primo è un episodio di cronaca, trattato da Levi in modo garbatamente ironico e lievemente satirico: la visita del sindaco di New York, Vincent Impellitteri, a Isnello, suo paese natio. E qui non può non colpire il ritorno del tema del “Paradiso Americano” (p.35), già trattato nel Cristo. D’altronde anche Isnello assomiglia “a un paesetto lucano” (p. 39) e anch’esso “non ha avuto finora altra storia che preistorica” (p. 40). Le analogie però terminano qui, perché poi il racconto va avanti attraverso la divertita osservazione degli atteggiamenti degli abitanti del villaggio di fronte a questo illustre compaesano, che rappresenta per loro il simbolo del successo e del potere, la descrizione dei preparativi, dei festeggiamenti, dei discorsi ufficiali delle autorità con la “loro retorica domenicale” (p. 50), del pranzo organizzato dalle monache dell’Orfanotrofio. Il sindaco di New York viene ben presto assunto in una dimensione mitica, favolosa dagli abitanti di Isnello, che vedono in lui quasi una nuova incarnazione della divinità: “dopo la fuga in Egitto avvenuta cinquanta anni fa, era l’ingresso di Cristo a Gerusalemme” (p. 47); “egli entrava nel suo paese, più che come un Conte o un Signore Feudale, come un Sindaco d’America, un Re del Cielo” (p. 50); “Egli era come Cristo, un Dio-Uomo” (p. 51). E la sua visita si trasforma quindi, in modo quasi naturale, in una sorta di “sacra rappresentazione” (pp. 46, 53), di cui Levi rievoca argutamente i momenti principali, come la Natività e l’Adorazione. L’umile casa dove era nato, che si trovava, guarda caso, all’angolo del vicolo Betlemme, diventa la “casa della Natività” (p. 52) e davanti a quella “sostarono, adorando, Re, Magi e Pastori” (p. 53). Non mancano anche altri episodi gustosi narrati da Levi, come la folla di Impellitteri, sedicenti cugini del sindaco, che si rivolgono allo scrittore per essere presentati a lui, o quello della donna, “vestita col velo nero delle contadine”, che poi si scoprirà essere una Sottosegretaria di Stato, la quale grida, rivolgendosi a Impellitteri: “Vincenzino! Bedduzzo di mamma! I fimmini di Isnello qua stanno! Guardaci, Vincenzino” (p. 47).
In evidente contrasto con l’episodio narrato (ed è questo il primo di una serie di contrasti che, come s’è detto, si incontrano nel libro e lo caratterizzano) sono le pagine dedicate agli zolfatari di Lercara Friddi. D’altra parte lo stesso Levi ne è consapevole al punto da scrivere alla fine di quell’episodio:
Volevo andare a Lercara Friddi, a vedere le miniere di zolfo. Là avrei incontrato davvero un’altra faccia del mondo, dei mostri feudali, di un tempo remotissimo e incredibile, e tuttavia vivi oggi, e in lotta feroce coi magri zolfatari. Un altro mondo si apriva, un’altra Sicilia, nella contemporaneità dei tempi. Impellitteri era partito (p. 57).
E, in effetti, qui si passa dalla “favola” (p. 37) della visita di Impellitteri alla “storia vera” (p. 80) dei minatori di Lercara e del loro primo sciopero, “il primo che si facesse, a memoria d’uomo” (p. 71), che essi attuavano contro lo sfruttamento di tipo feudale, l’assoluta mancanza di diritti, di garanzie, di sicurezza sul posto di lavoro. Anche il paesaggio siciliano, descritto da Levi sempre con notevole abilità coloristica, da pittore appunto, quale egli era, cambia improvvisamente: alla “distesa verde e azzurra della terra e del mare” (p. 65), della costa palermitana, si sostituisce il paesaggio desolato e aspro dell’interno:
La strada saliva, in luoghi sempre più deserti […]. Soffiava un vento freddo, il cielo si era coperto di nuvole grige, il sole era scomparso, quando, a una svolta, apparve lontano il paese di Lercara Friddi. Stava disteso con le sue case basse, lungo sulla terra, e a sinistra si allargava una zona brulla, grigia e giallognola, coperta di monticciuoli conici di detriti gialli: erano le miniere (p. 70).
E anche il tono di queste pagine muta: diventa asciutto, sobrio e puramente informativo come quello di un’inchiesta o di una relazione (abbastanza simile, questo sì, a Contadini di Calabria), fino alla denuncia dell’atroce episodio che aveva dato il via allo sciopero:
Ma il 18 giugno, un ragazzo di diciassette anni, Michele Felice, un “caruso” che lavorava nella miniera, venne schiacciato da un masso caduto dalla volta di una galleria, e morì. È un fatto frequente: anche il padre del morto aveva avuto una gamba schiacciata da una frana, nella zolfara. Alla busta-paga del morto venne tolta una parte del salario, perché, per morire, non aveva finito la sua giornata; e ai cinquecento minatori venne tolta un’ora di paga, quella in cui avevano sospeso il lavoro per liberarlo dal masso e portarlo, dal fondo della zolfara, alla luce (p. 73).
Questa vicenda permette a Levi di fare una fondamentale scoperta, che è un po’, come s’è detto, il leitmotiv del libro e dei due scritti ad esso collegati: scopre cioè che qualcosa anche in queste terre sta lentamente cambiando, dopo secoli e secoli di immobilità, e che la gente siciliana, anche la più umile e dimenticata, sta prendendo coscienza della propria dignità e della possibilità di un cambiamento della propria situazione, avviandosi ad entrare da protagonista “nel mobile fiume della storia” (p. 81), dopo esserne stata da sempre esclusa:
Ero venuto per visitare, da semplice curioso, una vecchia zolfara, in uno dei mille paesi dell’immobilità contadina; e mi trovavo invece in un centro vivo, in pieno movimento e cambiamento, dove tutti i sentimenti sono nuovi, le azioni appassionate, le volontà tese e violente, e qualche cosa che prima non esisteva nasce nel cuore degli uomini (p. 71).
Questo senso di “rinascita”, di “resurrezione” (p. 82), questa sorta di palingenesi si manifesta anche nell’espressione fiera e felice dei volti dei minatori, i quali “erano contenti di sé, tutti […] come se fossero nati ieri” (p. 82); “Erano fieri, ‒ scrive ancora Levi ‒ e sicuri di vincere, e felici di essersi sco- i come esseri umani e liberi, felici di una felicità nuova, commossa e commovente su tutti i visi” (p. 81).
Contrapposte alle facce felici dei minatori stanno invece quelle degli oppressori, dei mafiosi che subito colpiscono l’attenzione dello scrittore al suo arrivo in paese, come il “viso ottuso e feroce” di un giovane “con due neri baffetti filiformi sul labbro, la guardata obliqua e sfuggente, l’andatura insieme proterva e inquieta” (p. 72), che sembra allo scrittore l’aspetto tipico ed esemplare di un mafioso. Memorabile poi è il ritratto del signor Ferrara, chiamato in paese col nomignolo di Nerone, il gabellotto e padrone delle miniere, che amministrava le sue proprietà “con metodi preistorici” (p. 73), un ritratto di plastica evidenza, che sta a dimostrare le straordinarie doti ritrattistiche di Levi:
Nell’ingresso stava seduto un vecchio, un uomo gigantesco, pesante, grosso, con un collo corto e robusto, una camicia aperta e un grigio abito trasandato; con una testa dalla pelle come un cuoio, dalle enormi mascelle, una bocca piena di denti, e degli occhi sottili, sfuggenti dietro le spesse lenti di un paio di occhiali di ferro (p. 74).
Egli sembra a Levi quasi il simbolo della millenaria oppressione delle genti siciliane, al punto che commenta: “Ebbi viva l’impressione di trovarmi con un raro rappresentante di una razza perduta, con un uomo non di oggi, né di ieri, né di cento anni fa, ma con uno di coloro che vivevano mille anni or sono… “(p. 74); e ancora: “e la faccia del signor N., contro cui lottano, non è di cento anni fa, ma di mille, non è il viso di un industriale inglese del 1848, ma forse quello di un padrone dei servi dell’ottavo o nono secolo, prima del Mille, e forse neppure quello” 81). Tanto è vero che l’unico paragone possibile è con la faccia di Gano di Maganza (“Canimanza”), il traditore dei paladini diventato il simbolo della ferocia e del tradimento nella tradizione popolare siciliana. La Parte prima termina con un altro episodio, di tono completamente diverso, tutto basato sul pittoresco, che rientra invece nei canoni più tipici del reportage: la visita al Cimitero dei Cappuccini di Palermo, al lume fioco di una candela che rende ancora “più misteriosa e profonda l’oscurità” (p. 85) nei lunghi corridoi, con la sfilata di corpi mummificati e imbalsamati allineati sulle pareti. Questa visita, però, dà modo a Levi di riflettere sulla “presenza”, sulla “familiarità” (p. 91) dei morti in Sicilia, dove la morte “conserva in sé piena l’immagine della vita” (p. 91). E lo scrittore, in queste pagine, gioca appunto abilmente sulla compresenza di morte-vita sui corpi dei defunti: su alcuni visi “si sarebbe cercato il brillare di uno sguardo” (p. 85); due bambine “parevano uscire da una nicchia, fra le altre molte tutto intorno in gesti di vive colpite da una comune sventura, come se tutte ancora respirassero” (p. 89); un “enorme vescovo” sembra “attaccato a questa nostra vita come nessun vivo può esserlo” (p. 90); un altro morto ignoto “ricorda i vivi dei campi di concentramento di Buchenwald e di Belsen” (p. 90). E tutti, insomma, “stanno là come dei vivi, con maggior carattere personale, asciugati dal provvisorio e dall’incerto della vita” (p. 90).
[In A.L. Giannone, Scrittori del Reame. Ricognizioni meridionali tra Otto e Novecento, Lecce, Pensa Multimedia, 1999, pp. 165-186]
NOTE
- 1 C. LEVI, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia, Torino, Einaudi, 1955. Da questa edizione sono tratte le nostre citazioni.
- 2 Su questo genere letterario e la sua diffusione nel Novecento cfr. G. PULLINI, Letteratura di viaggio nel dopoguerra, in Volti e risvolti del romanzo italiano contemporaneo, Milano, Mursia, 1971, pp. 309-318.
- 3 G. TROMBATORE, Sicilia di ieri e di oggi, in “L’Unità”, 19 gennaio 1956, poi in ID., Scrittori del nostro tempo, Palermo, Manfredi, 1959, pp. 161-166.
- 4 Questo scritto, apparso in due puntate in “L’Illustrazione italiana”, n. 5, maggio 1953, pp. 27-30, 77-80 e n. 6, giugno 1953, pp. 28-32, 81, è stato recentemente ristampato in “Lares”, a. LV, n. 2, aprile-giugno 1989, pp. 181-207.
- 5 C. LEVI, Contadini di Calabria, cit., p. 182.
- 6 ID., L’uva puttanella, in Coraggio dei miti. Scritti contemporanei 1922-1974, a cura
- di G. De Donato, Bari, De Donato, 1975, p. 9.
- 7 Ci riferiamo a M. ALICATA, Il meridionalismo non si può fermare a Eboli, ora in Scritti letterari, Milano, Il Saggiatore, 1968, pp. 309-330 e C. MUSCETTA, Leggenda e verità di Carlo Levi, ora in Realismo neorealismo controrealismo, Milano, Garzanti, 1976, pp. 52-67.
- 8 G. NAPOLITANO, rec. a Le parole sono pietre, in “Rinascita”, a.XII, n. 12, dicembre 1955, p. 796.
- 9 Ibid.
- 10 C. SALINARI, Le parole sono pietre, in ” Il Contemporaneo”, a. ll, n. 50, 17 dicembre 1955.
- 11 N. GALLO, Testimonianze del Sud, in “Società”, a. XI, n. 1, febbraio 1956, p. 199.





























































