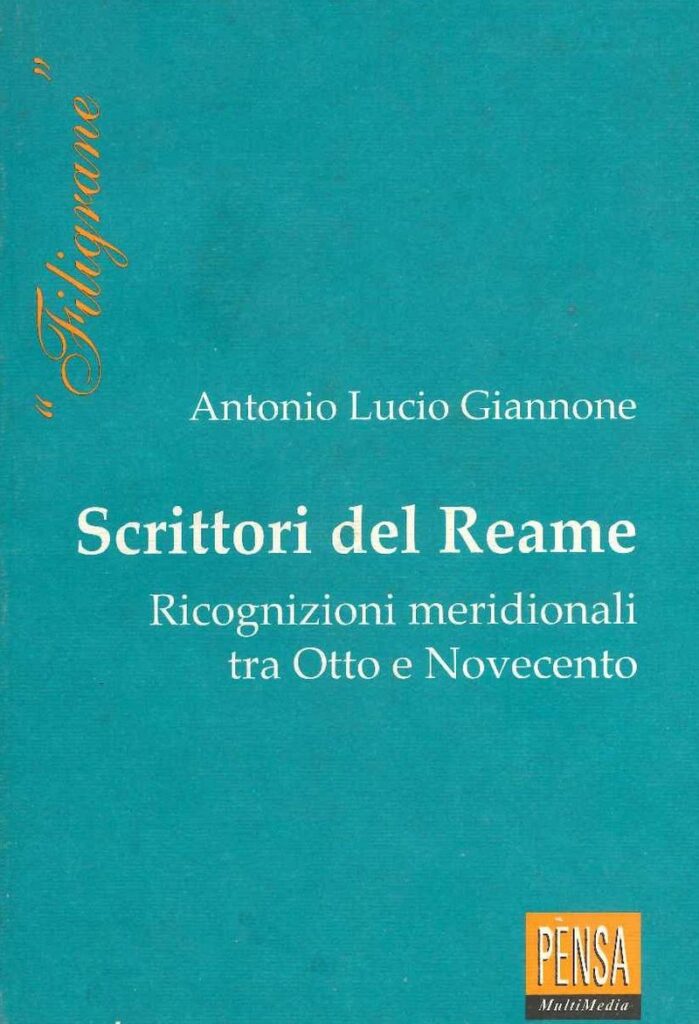
De Sanctis, negli anni in cui incominciava ad operare Gigli (cioè negli anni Ottanta dell’Ottocento), non godeva certo di una grande fortuna in Italia, anzi si può dire che fosse stato quasi del tutto dimenticato, anche prima della morte, a causa del sopravvento che ormai aveva preso proprio la “scuola storica”, ma il grande critico irpino era ancora il punto di riferimento per molti letterati meridionali. Nel Salento, in particolare, la sua lezione era tenuta in vita e apprezzata da numerosi scrittori e critici che si erano formati o direttamente con lui all’Università di Napoli, o sulle sue pagine 3: da Francesco Muscogiuri, allievo diretto del De Sanctis 4, a Luigi Tinelli, professore al Liceo Palmieri e maestro di Gigli, a Francesco Rubichi. Era difficile, perciò, anche per un critico più giovane come era Gigli, riuscire a sfuggire al fascino della figura di De Sanctis, del quale egli riprende spesso i giudizi a conclusione dei suoi lavori critici, quasi come a volersi appoggiare su un’indiscussa auctoritas. Romantica e desanctisiana inoltre è anche la sua concezione della letteratura, che è sempre strettamente collegata agli sviluppi della società italiana.
Ma è soprattutto Carducci la guida ideale per Gigli fin dai suoi esordi e non solo, com’è noto, in campo critico. Già nella sua famosa conferenza sullo Stato delle lettere in Terra d’Otranto è riportato un brano in cui il vate maremmano esortava alle storie particolari, allo studio delle varie letterature regionali, dei dialetti, senza le quali non era possibile, scriveva, far “compiuta e vera la nostra storia nazionale” 5. Da Carducci, più in generale, Gigli riprende poi soprattutto il gusto della lettura diretta delle opere e l’attenzione per gli aspetti tecnico-formali dei testi letterari, come la metrica.
Verso la critica positivistica, che pure è quella che influenza maggiormente, dal punto di vista metodologico, i suoi lavori, Gigli ebbe a esprimere invece più di una volta qualche riserva, non accettando mai integralmente certi suoi postulati. Ha ragione, perciò, Marseglia quando sostiene che in fondo il positivismo offre a Gigli un metodo, degli strumenti di lavoro, ma non una vera e propria concezione filosofica, dei principi di carattere teorico a cui attenersi 6.
Nella conferenza Cose della scuola e della patria, ad esempio, Gigli lanciava una frecciatina polemica nei confronti dei critici positivistici, i quali negavano la possibilità di una creazione assoluta in arte, ritenendo, in base a un’idea evoluzionistica della letteratura, come osservava Pio Rajna, che “il nuovo, considerato da vicino, non è che la metamorfosi del vecchio” 7. Gigli, infatti, così scriveva: “Il nuovo assoluto in arte dove sta? Non son certo io tra coloro che affermano essere necessità ineluttabile degli ingegni il continuo ripetersi; penso però che magistero principale dell’arte è la forma che rinnovella tutto, e dà a tutto la sua impronta originale” 8. Dove c’è il recupero di un concetto, quello di “forma”, che non deriva tanto da De Sanctis, quanto, come s’è accennato, da Carducci, nel quale forma è sinonimo di stile.
Nel discorso commemorativo Giosuè Carducci è possibile cogliere ancora un altro riferimento a uno dei capisaldi della critica positivistica, la ricerca delle fonti. Gigli sostiene qui che è sufficiente “scrutare” nell’opera di un grande per coglierne “il segreto e la bellezza”, senza che la grandezza sia dimostrata per altre vie, “affaticandoci nella ricerca delle fonti d’ogni pensiero animatore di forme e di spiriti d’arte” 9. E, in effetti, anche nei suoi contributi critici più impegnativi, si può notare che i riferimenti alle fonti di un’opera, pur comparendo normalmente, hanno molto meno spazio in rapporto a quello che gliene davano i maestri della scuola storica. Ciononostante, però, come si diceva, Gigli si inserisce a pieno titolo nel filone della critica positivistica, per alcune caratteristiche del suo metodo che emergono soprattutto negli studi su alcuni classici della letteratura italiana, come la minuziosa ricerca biografica, la ricostruzione cronologica delle opere, i precisi riferimenti storici, ecc.
La prima attività critica di Gigli, mettendo da parte i contributi manduriani, è costituita da alcune conferenze, le quali non sono opere di critica letteraria in senso stretto ma offrono preziose indicazioni sulle idee di Gigli in campo letterario e metodologico, sulla sua poetica, essendo strettamente intrecciate con la sua produzione creativa. Esse sono indicative soprattutto dei suoi primi interessi, rivolti in quel periodo, anche nel campo della creazione poetica e nello studio delle tradizioni popolari, verso la “piccola patria”, della quale si voleva mettere in luce il contributo di idee, di opere, di uomini recato alla nazione finalmente unificata. E in questo campo Gigli si collocava sulla scia di altri studiosi ed eruditi salentini, della generazione precedente, come Giacomo Arditi, Sigismondo Castromediano, Luigi Maggiulli, Pietro Palumbo, Luigi De Simone e altri, i quali avevano ricercato con le loro opere la peculiare “identità” storica, culturale e antropologica del Salento.
La prima di esse, in particolare, la già citata Stato delle lettere in Terra d’Otranto, oltre ad essere uno degli scritti più noti e fortunati di Gigli, ha il merito di essere anche il primo panorama della cultura salentina contemporanea. Qui, infatti, Gigli dà un quadro sintetico ma esaustivo dei contributi portati dai salentini non solo in campo strettamente letterario, ma anche nella scienza, nel diritto, nella filosofia, nella storia e nell’erudizione locale, intendendo per letteratura, come scrive lui stesso, un po’ alla maniera romantica, “tutte le manifestazioni della coltura d’un popolo”10. E anzi all’inizio rivendica proprio il valore di scienziati, medici, zoologi, botanici, giuristi, filosofi, pedagogisti, nati in Terra d’Otranto e sparsi allora presso varie università italiane. A questo proposito faceva notare il progresso che gli studi positivi avevano portato, negli ultimi decenni dell’Ottocento, anche nel Salento, nei campi più diversi dello scibile umano, mentre si lamentava dell’isolamento e dell’abbandono in cui vivevano i nostri letterati, del tutto sconosciuti e poco apprezzati dai loro stessi conterranei anche per ragioni storiche e sociali:
Li ho chiamati solitari, e tali sono. I nostri scrittori vivono quasi nell’abbandono di se stessi, l’uno ignoto all’altro. In tale rincresciosa condizione di fatti, poeti e prosatori cercano fuori quel fraterno appoggio, che qui manca. Il carattere delle nostre genti non è ancora educato ad apprezzare le qualità dell’uomo. Si voglion fatti, non parole, giacché parole sembrano alla maggior parte dei salentini i buoni volumi che molti dei nostri scrittori cacciano, non alla luce del mondo, ma a quella del proprio paese, avverandosi nella maggior parte dei casi, che i nostri libri, dirò così, nascono, vivono e muoiono nell’oblio delle strette mura d’una borgata di campagna 11.
Proprio questa, com’è noto, è l’ipotesi storiografica da cui parte Donato Valli nella sua ricostruzione di un secolo di vita letteraria nel Salento 12. Ebbene, a parte il fatto che in queste considerazioni entrano anche motivi di carattere personale (probabilmente una certa frustrazione che era derivata al giovane scrittore all’inizio della sua attività), vorrei osservare che in fondo qui Gigli si limitava a fotografare una particolare situazione di quel periodo, tipica del resto anche della nazione, un periodo nel quale gli studi positivi avevano ormai, come s’è detto, una netta prevalenza sulla ricerca letteraria. D’altra parte, le ricerche compiute in questi ultimi tempi hanno più volte smentito quelle affermazioni, scoprendo quasi sempre rapporti intensi e collegamenti a volte inaspettati tra scrittori salentini di vari periodi storici e figure di livello nazionale. Così pure, nelle secolari vicende letterarie del Salento, sono emersi frequenti tentativi di aggregazione, di costituzione di gruppi tra gli scrittori, che vanno in direzione opposta rispetto a quella condizione di solitudine di cui parla Gigli.
Direttamente collegate alla sua attività di insegnante sono invece altre due conferenze, Ne’ solenni parentali di Luigi Tinelli e Cose della scuola e della patria. Nella prima emerge soprattutto una concezione alta della scuola e dell’insegnamento, che per Gigli hanno la funzione fondamentale di formare integralmente l’individuo. E un modello, in questo senso, è rappresentato dalla figura di Luigi Tinelli, suo professore al Liceo Palmieri, che per lui aveva avuto anche il grande merito di essere stato un combattente per la patria. Così Gigli descrive il suo metodo:
La sua scuola era una famiglia, nella quale meravigliosamente si stabiliva una corrente di simpatia tra maestro e discepoli. Egli non imponeva le proprie idee, ma persuadeva della verità di queste e la rendea così patrimonio delle giovani menti. Egli sapea dimostrare, col De Sanctis, che “la letteratura è il culto della scienza, l’entusiasmo dell’arte, l’amore di ciò ch’è nobile, gentile e bello”, e perciò istruendo i giovani, ne raddrizzava il carattere, e prima che dotti, li faceva uomini 13.
Nell’altra conferenza, invece, passa in rassegna i principali esponenti della poesia patriottica in Italia, da Dante fino ai poeti dell’Ottocento. Ma non è tanto questo analitico excursus, basato peraltro sul libro di Raffaello Barbiera, Poeti della Patria, che oggi interessa, quanto la posizione di Gigli nei confronti della principale corrente letteraria del secondo Ottocento, il naturalismo. E qui, nei confronti dei romanzi naturalisti, l’autore assume, secondo l’insegnamento desanctisiano, una posizione mediana, cioè di una cauta apertura con alcune riserve verso quelle che erano ritenute degenerazioni di questa corrente, la stessa posizione che nel Salento avevano tenuto anche, tra gli altri, i già citati Muscogiuri e Rubichi. Così scrive infatti:
Noi dobbiamo convenire che la forma letteraria oggi maggiormente logica, si è quella del romanzo, e perciò vogliamo che il romanzo ci dia il quadro della vita reale, co’ suoi vizii, colle sue colpe, colle sue depravazioni, co’ suoi delitti, ed ingegni e sproni al ben fare mostrandoci anco le virtù […]. Non possiamo convenire però con coloro che vorrebbero addirittura togliere all’arte ogni impronta ideale del genio, per trasformarla in medichessa, che tocchi il polso alla inferma umanità, ne scruti i malori, ci mostri le sue piaghe sanguinose, e ci dica: Ecco il mostro! 14.
Successivamente Gigli, in un’altra conferenza intitolata Il romanzo nella società contemporanea, che risale al 1900, ritornerà su questo argomento, attenuando, come ha osservato Marseglia, il giudizio negativo espresso verso il naturalismo. Qui infatti si apre a questa nuova corrente vedendo in Zola un acuto osservatore della società, anche se in effetti scorge in Tolstoi il narratore capace di fondere l’analisi dell’ambiente e della società con quella psicologica 15.

La vera e propria attività critica di Gigli ha inizio nel 1900, con una serie di studi e di edizioni commentate di classici italiani, che hanno, in massima parte, una destinazione scolastica, sono rivolti, cioè, esplicitamente a un pubblico di studenti delle scuole secondarie. In particolare, spiccano i suoi contributi dedicati al Boccaccio, che vanno avanti per diciassette anni, dal 1900 al 1917, e culminano nell’Antologia delle opere minori volgari, apparsa nel 1907 nella “Biblioteca scolastica di classici italiani diretta da Giosuè Carducci” presso la casa editrice Sansoni. Ma questi studi comprendono anche un’antologia commentata del Decameron (1900), edizioni commentate del Trattatello in laude di Dante (1908), della Fiammetta (1910), del Corbaccio (1917), oltre ad alcuni saggi, recensioni e una traduzione dal francese di una monografia su Boccaccio (1914) di Henri Hauvette, con il quale fu anche in rapporto epistolare.
Un carattere comune di tutti questi contributi è la lettura delle opere in chiave autobiografica, secondo il più tipico indirizzo della critica boccacciana di quegli anni. Vittore Branca, a questo proposito, proprio nella sua presentazione alla ristampa del volume curato da Gigli, Antologia delle opere minori volgari di Boccaccio, ha chiarito come meglio non si potrebbe questo momento particolare della “fortuna” critica del grande trecentista in età positivistica. Il Boccaccio minore ebbe grande fortuna nel primo Ottocento, derivata “dalla fede romantica nello scrittore narratore di se stesso, nella poesia sfogo dei sentimenti più segreti, nell’amore eccezionale che doveva essere al centro di ogni esperienza artistica”16. Da qui si sviluppa nei decenni successivi un’attenzione che mirava ad analizzare questi aspetti “quasi fisiologicamente”, “misurarli col più rigido metro della realtà, fissarli scrupolosamente in giorni, ore, minuti” 17. Le opere giovanili del Boccaccio “furono così, punto per punto, scrutate al microscopio per cogliere ogni possibile riferimento autobiografico; e quando questi non erano assolutamente rintracciabili si ricorreva al sottile gioco delle allusioni indirette e delle costruzioni per enigmi o per sciarade” 18.
A dire il vero, nel primo contributo di Gigli, Il disegno del Decameron, questa tendenza non è ancora presente, anche perché si tratta di un’antologia commentata del capolavoro di Boccaccio, “ad uso delle scuole secondarie”. Qui c’è semmai un tentativo di offrire non soltanto una scelta di novelle, ma di dar conto, sia pure in forma sintetica, della struttura complessiva dell’opera (“presentare il gran quadro del Decameron in un ristretto disegno”19), affiancando quindi alle novelle due per ciascuna giornata), anche il proemio e l’introduzione, le introduzioni alle dieci giornate e i rispettivi finali, contenenti le dieci ballate.
Ma già nei due saggi dedicati ad altrettanti gruppi di sonetti del Boccaccio, l’attenzione del critico si rivolge principalmente alla precisazione di date e di aspetti biografici. Nel primo articolo, Di alcuni sonetti del Boccaccio, Gigli, ad esempio, si sofferma soprattutto sul problema della malattia che afflisse lo scrittore negli ultimi suoi anni, discutendo se si trattasse di scabbia o di diabete 20. E nell’altro, intitolato I sonetti baiani del Boccaccio, affronta il problema della disposizione logica di questi sonetti per arrivare alla “relativa assegnazione cronologica” 21, mettendo sempre in stretto rapporto la poesia con i fatti biografici, e in particolare con la storia d’amore, vera o presunta, tra Boccaccio e Maria d’Aquino, la figlia di re Roberto d’Angiò.
Questa storia diventa poi il filo conduttore dell’interpretazione delle opere giovanili data da Gigli nella già ricordata Antologia. Nell’Avvertenza iniziale, egli chiarisce quali sono le ragioni che l’hanno indotto a compilare il volume: far conoscere agli studenti delle scuole queste opere, “nelle quali si rintracciano spesso le prime fonti della concezione delle cento novelle” 22 e nelle quali inoltre, secondo il curatore, si ritrova il “Boccaccio intimo”, che “ha più veracemente e liberamente espresso l’animo suo” 23. Per quanto riguarda il testo delle opere, Gigli non offre un contributo personale, ma si limita a scegliere tra le edizioni ritenute migliori o da lui o dagli altri critici, non essendoci ancora in quei tempi un’edizione critica delle opere di Boccaccio. E su questo trova l’assenso di uno dei maestri della scuola storica, Pio Rajna, che in una lettera a lui indirizzata, in data 16 gennaio 1907, dopo aver ricevuto il volume, gli scriveva che era stato “assai buono di certo il pensiero di comporre un’Antologia delle opere minori volgari del Boccaccio ed è stato bene – continuava – non ritardarne l’esecuzione fino a quando di ciascuna di esse si avessero edizioni critiche” 24. Al tempo stesso però faceva notare che “interrogare un pochino la traduzione manoscritta sarebbe stato certo giovevole” anche se, continuava, “a lei questo non dovett’essere possibile” 25. E più avanti osservava ancora che il volume più che a studenti liceali poteva essere utile a “insegnanti, a persone colte in genere, e non dovrebbe riuscire disadatto -proseguiva – qual testo per qualche corso universitario, specialmente fuor d’Italia” 26, esprimendo così, tutto sommato, un lusinghiero apprezzamento per l’opera del critico salentino, anche se poi ne faceva notare qualche imprecisione.
[In A. L. Giannone, Scrittori del Reame. Ricognizioni meridionali tra Otto e Novecento, Lecce, PensaMultimedia, 1999, pp. 25-47]
Note
1 Cfr. Giuseppe Gigli e documenti vari di cultura, a cura di D. Valli, Lecce, Milella, 1982 (“Biblioteca salentina di cultura”, diretta da M. Marti), p. 11. A questo volume si rimanda per un profilo dello scrittore manduriano.
2 Cfr. G. GIGLI, Carteggio inedito, a cura di L. Marseglia, Bari, Adriatica editrice, 1983, dove la lettera cit. di A. D’Ancona è a p. 104.
3 Sulla cultura letteraria nel Salento nel secondo Ottocento si rimanda a D. VALLI, Cento anni di vita letteraria nel Salento (1860-1960), Lecce, Milella, 1985, pp. 21-70.
4 Sulla figura di Muscogiuri si veda A. L. GIANNONE, Un critico di scuola desanctisiana: Francesco Muscogiuri, in La “permanenza” della poesia. Studi di letteratura meridionale tra Otto e Novecento, Cavallino di Lecce, Capone, 1989, pp. 7-34.
5 Il brano di Carducci è citato in G. GIGLI, Stato delle lettere in Terra d’Otranto. Conferenza letta la sera del 3 maggio 1890 nella sala dell’Associazione Giuseppe Giusti in Lecce, Lecce, R. Tip. Ed. Salentina dei fratelli Spacciante, 1890, p. 23. La conferenza è compresa ora in Giuseppe Gigli e documenti vari di cultura, cit., pp. 299-315.
6 Cfr. L. MARSEGLIA, Introduzione a G. GIGLI, Carteggio inedito, cit., p.18.
7 P. RAJNA, Le fonti dell’Orlando furioso, Firenze, Sansoni, 1900, p. 609.
8 G. GIGLI, Cose della scuola e della patria. Lettura tenuta la sera del 26 Febbraio 1891 all’Associazione Giuseppe Giusti di Lecce, Lecce, Lazzaretti, 1891, p. 9.
9 ID., Giosuè Carducci. Discorso commemorativo. Letto nella sala maggiore del Palazzo comunale di Cesena il XVI febbraio MCMVIII, Cesena, Tip. Biasini-Tonti, 1908.
10 ID., Stato delle lettere in Terra d’Otranto, cit., p. 6.
11 Ivi, p. 14.
12 Cfr. D. VALLI, Cento anni di vita letteraria nel Salento (1860-1960), cit., p. 9.
13 G. GIGLI, Ne’ solenni parentali di Luigi Tinelli. 1. Febbraio 1891. Parole pronunziate nell’aula maggiore del R. Liceo Palmieri, Lecce, Lazzaretti, 1891, p. 10.
14 G. GIGLI, Cose della scuola e della patria, cit., p. 7.
15 Cfr. L. MARSEGLIA, Introduzione a G. GIGLI, Carteggio inedito, cit., p. 45.
16 V. BRANCA, Presentazione a G. BOCCACCIO, Antologia delle opere minori volgari, a cura di G. Gigli, Firenze, Sansoni, 1961, (1 ed. 1907), p. IX.
17 Ibid.
18 Ivi, p. X.
19 Il disegno del Decameron di Giovanni Boccaccio, con commento di G. Gigli, Livorno, R. Giusti, 1907 2, p. VI.
20 Cfr. G. GIGLI, Di alcuni sonetti del Boccaccio, in Miscellanea di studi critici edita in onore di Arturo Graf, 1903, pp. 483-490.
21 ID., I sonetti baiani del Boccaccio, in “Giornale storico della letteratura italiana”, vol. XLIII, 1904, fasc. 128-129, p. 1.
22 G. GIGLI, Avvertenza a G. BOCCACCIO, Antologia delle opere minori volgari, cit., p. IV.
23 İbid.
24 In G. GIGLI, Carteggio inedito, cit., p. 98.
25 Ivi, p. 99.
26 Ibid.






























































