di Rosario Coluccia
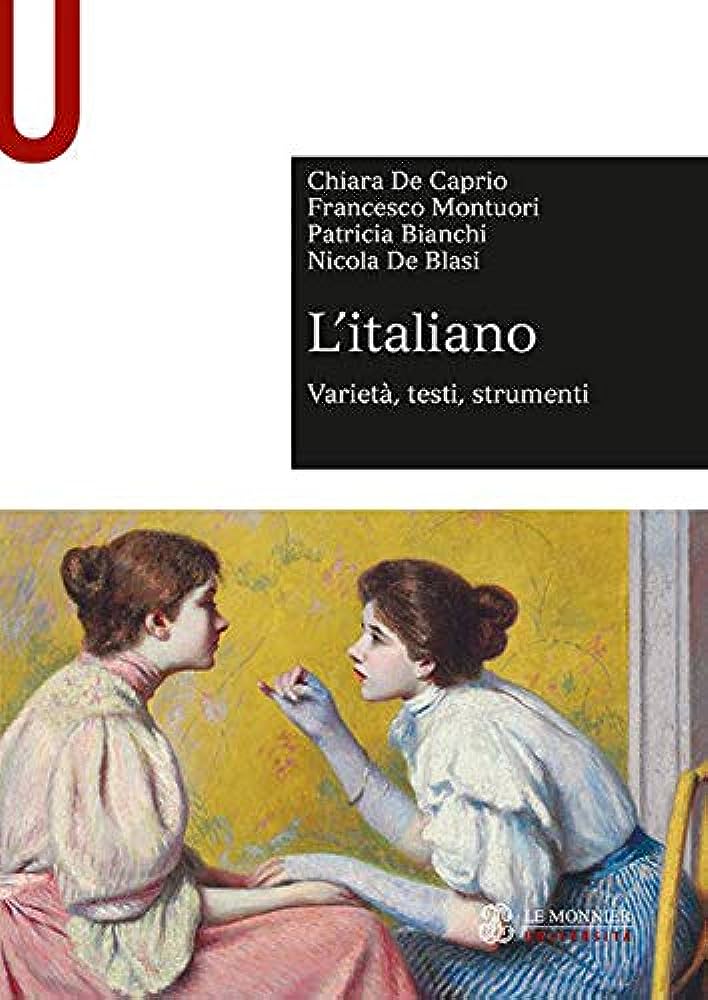
Le parole non possono cambiare il mondo, ma gli danno forma. Le nostre reazioni di fronte alle parole (quelle che altri usano, che noi ascoltiamo, che a volte ripetiamo, anche inavvertitamente) rivelano chi siamo e i nostri pensieri profondi. Anche le testimonianze del passato possono violare la nostra sensibilità. In un articolo di qualche settimana fa abbiamo parlato della presenza di parole razziste nella lingua di «Via col vento» (romanzo e film) e di «Lessico famigliare» (romanzo). Manifestazioni d’arte (romanzi e film) giustamente famose, che ci piacciono e inoltre ci turbano, perché attraversate da venature linguistiche di razzismo che (pur non intenzionalmente aggressive) risultano evidenti ai nostri occhi. Non si tratta di fenomeni isolati, i fatti si ripetono. Ricordiamo le polemiche nate dall’uso ripetuto, quasi ossessivo, della parola «nigger» (‘negro’) nell’originaria versione americana di «Django Unchained» di Quentin Tarantino. Alle critiche rivolte al suo film, Tarantino ha replicato che lui si è sentito obbligato a far ricorso a quella parola, negli anni della schiavitù con quella normalmente ci si rivolgeva agli schiavi. Oggi negli USA «nigger» è termine politicamente scorretto e bandito dagli usi ufficiali della legislazione americana, ma negli anni in cui si svolge la vicenda di «Django Unchained» la situazione generale era molto diversa, quella parola era usata senza molto badarci.




























































