Un giudizio assai diverso dai precedenti è stato espresso invece da Giovanni Raboni il quale, in occasione della riedizione delle due opere nel 1979, rivendicava l’autonomia del “Sinisgalli narratore” soprattutto a proposito di Belliboschi, per cui “risulta inadeguata – scriveva – una lettura che vi scopra o vi sottolinei prevalentemente un deposito di impressioni buone per nutrire le fulminee epifanie lirico-epigrammatiche di Vidi le Muse o dei Nuovi Campi Elisi, o che – più in generale – le incaselli in un clima surrealrondista”. Se per la prima raccolta – continua Raboni – “prevale ancora il momento dell’evocazione”, nella seconda “la presa su un materiale emotivo non di rado identico è ben più ferma e creativa, il taglio e il montaggio ben altrimenti secchi, tesi, incalzanti, cosicché la pasta tenera del ricordo o magari della confessione riesce ormai a solidificare, a farsi serie o sequenza di apparizioni autonomamente eccitanti dentro stampi di ricostruzione fantastico-oggettiva, di racconto”[16].
In verità, tra i due libri, accanto alle evidenti affinità (la materia autobiografica comune, che permette un esame d’assieme come sarà quello condotto nel presente articolo), esiste anche una sensibile differenza riguardo al genere di prosa, che si spiega col periodo di composizione dei vari scritti, del tutto trascurato finora dai critici che se ne sono occupati. Fiori pari fiori dispari comprende ventotto “capitoli”, pubblicati tra il 1934 e il 1942[17], e rappresenta ancora un chiaro esempio di prosa d’arte. In particolare, qui ci troviamo di fronte quasi sempre a una prosa di tipo lirico, che tende nettamente cioè verso la poesia, secondo la direzione impressa alla prosa d’arte nella seconda metà degli anni Trenta dagli ermetici[18]. L’ermetismo infatti, in questi anni, favorisce la crisi di questo genere, trasformandone il linguaggio, che “da logico e ‘costruito’ diventa analogico con venature vagamente surreali”[19]. La prosa d’arte perde così “l’autonomia di genere letterario e diventa ancilla della poesia”[20].
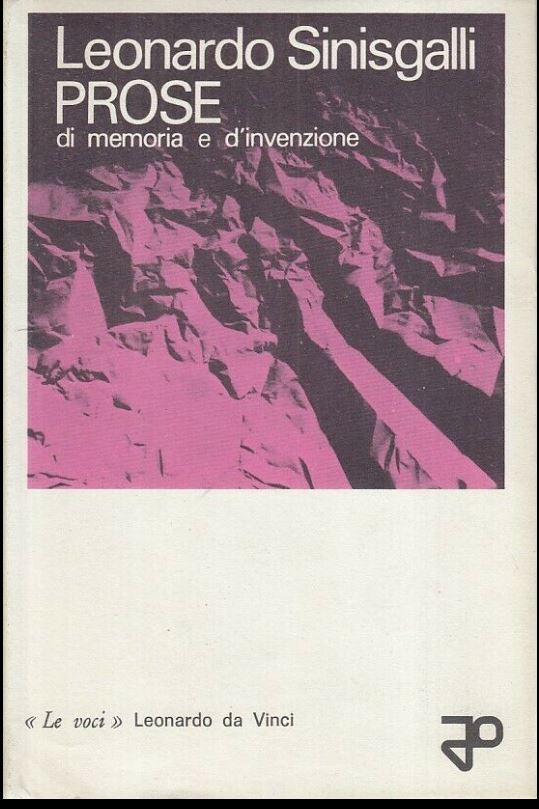
Belliboschi invece contiene trenta pezzi di tipo narrativo, composti tra il 1941 e il 1947, secondo le indicazioni apposte dallo stesso autore in calce a ciascuno di essi. Con questi scritti insomma siamo già in una fase della letteratura italiana diversa rispetto a quella precedente. Negli anni della guerra e dell’immediato dopoguerra, tramontata definitivamente la prosa d’arte, in campo letterario emergono infatti nuove urgenze di tipo contenutistico e espressivo e il racconto e il romanzo diventano i generi privilegiati della prosa, anche da parte dei poeti.
Altre indicazioni importanti su questo specifico problema ci vengono dallo stesso autore, il quale, nell’Avviso ai nuovi lettori, contenuto nella ristampa del 1964, così afferma all’inizio:
Non volevo scrivere come D’Annunzio e neppure come Cecchi. All’abilità preferii l’autolesionismo. Il mio sforzo non stava tanto nel fabbricare una prosa, quanto nel fabbricarmi un’anima.
La lettura di certe operette, il raptus della Vita nova, le biografie dei santi, gli epistolari dei poeti, la pratica della confessione e della penitenza, il gusto e il disgusto della solitudine mi incoraggiarono a sperimentare dispositivi vibranti, la pneumatica della tenerezza e della disperazione.
Tentai di conservare l’innocenza, esercitandomi su fatti trascurabilissimi. Le mie giornate, già allora, mi sembravano tanto più vere quanto più erano incerte, vegetative, incoscienti.
Una prosa di nervi più che di colori e di costrutti, di accidenti più che di norme, dove pareva abolita la storia e stranamente onorata la geografia, dove i minimi moti della esistenza parevano una diminuzione di vita, dove la stessa morte era un merito e un premio il castigo: fu, dunque, questa scrittura trepida che mi restituì lo stato d’animo puro e mostruoso del ragazzo esiliato che scrive ai parenti lontani, del ragazzo impedito che è chiamato a sostenere la prova di maturità, del ragazzo pudico che è costretto a spogliarsi davanti ai giudici di leva (10).
Qui c’è un riferimento, ma in negativo, proprio a due maestri della prosa d’arte, D’Annunzio e Cecchi, che Sinisgalli disconosce come suoi modelli, pur ammettendo la loro “abilità”. In secondo luogo, egli mette l’accento più sul “contenuto” delle prose che sulla loro “forma” (“una prosa di nervi più che di colori e di costrutti, di accidenti più che di norme”), tese a uno scavo interiore e a una maggiore conoscenza di sé (“i minimi moti dell’esistenza”). Non a caso cita opere esemplari in tal senso, come la Vita nova dantesca, le biografie dei santi e gli epistolari dei poeti. D’altra parte, questa affermazione coincide sostanzialmente con una osservazione fatta a proposito della prosa d’arte, in un articolo del 1940, da Curzio Malaparte, secondo il quale la “giovane scuola”, vale a dire quella degli ermetici, si rifiutava in quel periodo “di limitare i problemi della letteratura italiana, e quelli propri della sua generazione, a problemi di scrittura”[21], come invece era successo negli anni Venti e nella prima metà dei Trenta, quando questo genere era al suo culmine.
Ma che significa “fabbricarsi un’anima”? Ecco, qui Sinisgalli offre una precisa chiave di lettura di questi due libri. I quali, come s’è detto, sono una rievocazione delle varie tappe della sua vita, dalla irripetibile stagione dell’infanzia, trascorsa nella terra natia, fino agli anni della seconda guerra mondiale, passando attraverso l’esperienza dei collegi, dell’“esilio”, per motivi di studio e poi di lavoro, a Roma e Milano, del servizio militare. È quasi insomma, per dirla alla maniera dell’Ungaretti de I fiumi, un tentativo di “ripassare” “le epoche / della sua vita”, o, come dice lo stesso Sinisgalli in una poesia di Vidi le Muse, di andarsi incontro “a ritroso” per “cercar scampo e riposo / nella sua storia più remota” (18 Poesie, 2).
Questa spasmodica ricerca del tempo perduto non è mai però pura nostalgia del passato, rimpianto accorato degli anni trascorsi, ma si configura piuttosto ora come ricerca delle ragioni più profonde della propria esistenza, ora come una sorta di esame di coscienza, ora come confessione, fino a diventare una vera e propria storia di un’anima:
Io cercavo il ragazzo che veniva a dormire dentro l’ombra delle foglie. Egli non si è mosso mai di qui, non se n’è mai allontanato (Capitolo ventottesimo, FPFD, 85); Mi trovavo a un punto morto della mia vita: dopo una lunga assenza trascorsa in una grande città del Nord […], ero tornato a casa mia ricapitolando nel lunghissimo viaggio […] le ragioni della mia incapacità a costruirmi, anche in anticipo di un giorno, la vita del giorno successivo (Due primavere, B, 105); io stesso non sapevo più trovare le radici dei miei errori (Pietro, B, 117); versai lacrime amare per tutto quanto della mia vita mi pareva fosse rimasto inconcluso (ivi, 119); Non so se quell’anno servì a farmi diventare più forte, oppure maturò in me il mio cruccio, la mia inclinazione a consumare in anticipo ogni risorsa di felicità (L’albero bianco, B, 182); Forse fui messo per la prima volta di fronte alla mia sorte, intravidi anche che la mia strada era breve e tortuosa, sentivo come un terribile lezzo la vita da vivere ancora (Dormire a Potenza, B, 186); S’era impantanato per dieci anni il fiume della mia vita (Un gruppo di lettere oscene, B, 203).
Per questo le prose di Sinisgalli, e in particolare le memorie d’infanzia, della propria terra, dei genitori, non sono quasi mai puramente descrittive o realistiche, né tantomeno scadono nel bozzetto, ma si caricano di valenze simboliche e mitiche. Proviamo allora a ripercorrere i momenti principali di questa autobiografia ideale, nel senso or ora chiarito, costituita dalle due raccolte, seguendo il filo cronologico degli avvenimenti narrati.
Anche in questi scritti come nella prima fase della poesia di Sinisgalli, lo “spazio privilegiato”[22] è costituito dalla terra natia, la Lucania arcaica, fuori del tempo, separata dal resto della nazione, ricca di suggestioni antropologiche, di leggende, tradizioni, superstizioni. Questa realtà, osservata con gli occhi di un bambino, il piccolo Leonardo, attraverso la rilettura dei suoi quaderni scolastici, affiora già nel Capitolo primo di Fiori pari fiori dispari, con la figura della vecchia Apollonia, “castigata” per la sua “magia” da un fulmine che la brucia viva, e con lo stuolo delle “lamentatrici”, una presenza costante dei riti funebri meridionali, le quali ritornano anche in Parenti lontani di Belliboschi. Ma si veda anche il Capitolo sesto di Fiori pari fiori dispari, dove viene evocata una tradizione antichissima, il passaggio dei buoi nelle strade del paese, con lo spettacolo cruento dell’uccisione e dello scuoiamento di alcuni di essi, e la vicenda della bambina calpestata da uno degli animali e salva per un “miracolo” accaduto. O, ancora, Il piccione di Belliboschi, dove la raccolta periodica delle ulive rivela la condizione di secolare repressione sessuale della gente lucana. Certe credenze poi, come quella di poter conoscere il proprio destino dalle faville del rami bruciati, restano impresse al poeta anche da adulto: “Il fuoco ha un incanto, ha la virtù di portarci davanti, non come gli specchi la nostra immagine, ma addirittura il nostro destino” (Due primavere, B, 107).
Ma, in queste prose, emergono anche le memorie storiche e archeologiche della Lucania. Frequenti, infatti, sono i riferimenti ai suoi lontani abitatori, ai vari popoli che la invasero e la sottomisero (i normanni, gli svevi, gli arabi), agli antichi riti della Magna Grecia, ai preziosi reperti affioranti dal sottosuolo. Questo, com’è noto, è un elemento in comune ai poeti meridionali del Novecento, nei quali il sentimento di nostalgia verso un passato favoloso si unisce all’orgoglio di appartenere a una razza che affonda le radici nella preistoria, se non proprio nella leggenda, nel mito. Si vedano questi significativi esempi tratti dai due libri:
Questo panno rosso fa da richiamo alla mia noia: io ci ritrovo la ragione di tutti i vizi dei miei antenati arabi, il sonno, la tristezza del sesso, i rimorsi e tutto quello che c’è di ilare, di capriccioso nel mio sangue (Capitolo decimo, FPFD, 45); Volevo mettere ordine e calma dentro di me, e quella pura grammatica mentale, che aveva tanto occupato i miei antenati arabi, quelle cifre, quei segni […] mi consolavano come la musica consola i prigionieri… (Capitolo tredicesimo, FPFD, 53); L’anno 1857 segna il principio del nuovo medioevo. Senza dubbio ci sono legami stretti tra il nostro popolo brutale e ombroso e i pellegrini della Mecca (Viaggio, B, 143); I mulattieri di Sant’Arcangelo erano piccoli e malarici, poveri saraceni che le zanzare millenarie avevano ridotto pelle e ossa. Gli asini di Grumentum erano invece trascinati dalle femmine monumentali di quel mandamento, rosse donne normanne o sveve che mettevano lo scompiglio tra le meschine massaie arabe del mio paese (Il piccione, B, 153); Le rispondevo semplicemente: “Ma è il colore dei capelli di tuo marito! Federico non è arabo come noi” (Elisabetta al Giardino del Lago, B, 158); il frutto orfico per eccellenza, il bulbo agrodolce, rosaviola, del lampascione (Lo scheletro cinto d’oro, B, 216); Stretta all’inguine [dello scheletro], offuscata dalla polvere scura, vibrava miracolosamente intatta una piccola corona di metallo (ivi, 218); Come nei nostri antichi riti fallici (Le Pleiadi, B, 221); dissepolto da uno dei tanti cimiteri orfici che gremiscono il suolo della valle? (ibid.); Con una battuta salace in dialetto orfico-armentese (La corte dei vecchioni, B, 223).
Perennemente associata alla terra natia è l’infanzia che, insieme a quella, costituisce uno dei “miti fondamentali” del poeta, “inscindibili nella loro funzionalità catartica”[23]. L’infanzia è vista come periodo di suprema beatitudine, un autentico “paradiso” (Capitolo decimo, FPFD, 44), dove nemmeno le sciagure, a volte terribili, riescono a turbarne l’incanto. Non a caso l’io narrante, nel Capitolo primo di Fiori pari fiori dispari, confessa che non riesce a trovare sui suoi vecchi quaderni di scuola alcuna eco di certi avvenimenti tragici verificatisi nel suo paese in quegli anni lontani (“Una stagione di morti improvvise, di vendette celesti, di cui l’infanzia non si diede alcun conto” 15; “Il ragazzo non li tenne in nessun conto”, ibid.). La condizione più tipica di quella età non è infatti la preoccupazione, il timore, ma l’“ebbrezza”, un “continuo stato di estasi” (Capitolo ventottesimo, FPFD, 85), a cui basta pochissimo per arrivare:
Un tempo quanta ebbrezza per noi nati in quella calda cova svegliarci al suono delle campane e delle fanfare, e scoprire che anche la madre era allegra nonostante la sua corona di spine che porta in testa dal giorno del suo sposalizio (Capitolo nono, FPFD, 42); Ma la ebbrezza si scarniva in un sentimento più dolce che forse era estasi e che già conteneva una bontà insensata e un cruccio (ibid.); A mettermi in uno stato di ebbrezza, ricordo, bastava il fruscio di una macchina da cucire più che il canto della cicala lì presso, quei lunghi crepuscoli da cui spuntavano le prime immagini, le primi facili arie: “Colombe è questa l’ora – Di tentare la fuga!”(Capitolo diciottesimo, FPFD, 62)[24].
La stagione dell’infanzia trascorsa nel proprio paese è, per lo scrittore, l’epoca della “felicità”, una felicità che non ha una ragione precisa ma è semplicemente felicità di “esistere”. Si noti come solo nel Capitolo ventottesimo di Fiori pari fiori dispari questo sostantivo e l’aggettivo “felice” vengono ripetuti ben sei volte, spesso abbinati proprio con “estasi” e “ebbrezza”:
Io ricordo ch’egli era felice. Oggi, non mi fa spavento la certezza che egli aveva della sua felicità, se riusciva a resistere giorni interi in un continuo stato di estasi (85); “A sfogliare i sui quaderni, a leggere i suoi versi non si riesce assolutamente a capire qualcosa che non sia la sua stessa presenza in ogni cosa. Non si trova alcuna ragione della sua felicità (ibid.); “Io non gli avrei domandato niente altro che il segreto della sua felicità, la felicità che non gli si è mai negata tutte le volte che l’ha voluta, la felicità di esprimersi o semplicemente di esistere che lo faceva crepare di ebbrezza, come crepa l’ape nel miele” (86).
E infatti, nella prosa Un gruppo di lettere oscene di Belliboschi, Sinisgalli dichiara esplicitamente: “La felicità non l’avevo più incontrata dai lontanissimi giorni dell’infanzia quando correvo d’estate in mezzo alla polvere soltanto desideroso di buttarmi a capofitto nell’acqua fresca del fiume” (203).
Indissolubilmente legata, nel ricordo dell’autore, agli anni felici dell’infanzia è la sua famiglia, i genitori innanzitutto, ma anche le sorelle e il fratello. Il motivo dei genitori in particolare, assai presente nelle prose e nelle poesie di Sinisgalli, come anche negli altri ermetici meridionali, richiama una concezione arcaica, tradizionale, della famiglia, tipica di una società patriarcale e contadina, con i ruoli ben definiti. In tutti questi poeti, infatti, il padre viene inserito, di solito, in una dimensione rituale e quasi sacrale, mentre la madre è vista in una luce più intima e familiare.
Non c’è dubbio però che la figura che assume maggiore spicco nelle prose sinisgalliane sia proprio quella della madre alla quale sono dedicate alcune delle pagine più intense e struggenti dei due libri. La figura materna costituisce un altro “mito” nell’opera del poeta lucano, nella quale essa se, da un lato, “è segnata da una venatura segretamente accorata”, dall’altro “è vista con l’impegno di smorzare i toni e le immagini troppo confidenti, di non cedere alle suggestioni sentimentali che il tema sollecita”[25]. A prevalere, in queste prose, però è nettamente il tono dell’accoramento e della tenerezza. Si legga, ad esempio, il seguente brano del Capitolo ventiseiesimo di Fiori pari fiori dispari, dove una visita ai propri morti nel camposanto si tramuta in desiderio di autoannullamento, tanta è la tranquillità interiore che la vicinanza alla madre e quel luogo ispirano a Leonardo bambino:
Ci sedemmo io e mia madre. Sono così brevi i pomeriggi di autunno. Mia madre accese i piccoli lumi alla urne e cominciò a dire le sue preghiere. Io ero così tranquillo accanto a lei, che sarei rimasto lì in eterno. Erano finite le mie ansie, le mie speranze. Avrei voluto che il fulmine ci avesse colpiti, me e mia madre, quel giorno. Non mi pareva un grave peccato desiderare ardentemente, in quell’ora, la sua morte insieme alla mia (81).
Ma si potrebbero citare altre prose in cui emerge la centralità della figura materna per Sinisgalli e il senso di intensità affettiva e di intima comunione che si stabilisce tra i due. Si veda, ad esempio, Due primavere, di Belliboschi, il bellissimo racconto dei preparativi e poi del viaggio che madre e figlio compiono, all’insaputa del padre, per andare a trovare Angela, la sorella del poeta fattasi suora col nome di Suor Crocifissa. In questo passo viene descritta la notte immediatamente prima della partenza, trascorsa insieme dai due in un’intimità da “sposi”:
Restammo noi soli accanto al fuoco quella notte fino a tardi, come due sposi, quei due sposi bambini di cui si racconta che trascorsero la prima notte a mangiare tanti confetti, fino a farne un’indigestione, e dovettero tornare a casa dai parenti per farsi purgare. Mia madre aveva indossato il suo abito nuziale che non era bianco ma di un indefinibile colore bigio, guarnito ai polsi, al collo, alla cintura, di un merletto d’argento. Il panno odorava un poco di canfora, ma s’era conservato integro in tanti anni. E a mia madre ch’era stata assai scura di pelle, quel colore, quelle guarnizioni donavano più grazia quella sera, perché il trascorrere del tempo aveva reso armonici tutti i contrasti, aveva reso visibile una verità che solo noi possiamo scoprire quando ne siamo già vittime.
Quella notte parlammo a lungo io e mia madre, e si fece così tardi ch’essa dovette coprire, per difendersi dal gelo notturno, la magnifica veste con un soprabito di lana consunta (108).
Ma la prosa forse più toccante, a questo riguardo, è Non è cambiato nulla, di Belliboschi, in cui l’autore racconta il suo ritorno a Montemurro nove mesi dopo la morte della madre, quasi in un’ideale restituzione del periodo della sua vita che essa gli aveva dato, quando egli era ancora nel suo grembo: “ ‘Nostra madre’ dissi, ‘soltanto questa sera comincia a morire per me. Io l’ho creduta viva in questi nove mesi. Ho restituito alla mamma i nove mesi ch’essa mi diede della sua vita’” (160). Ebbene, il primo segnale dell’evento luttuoso abbattutosi sulla sua famiglia, che il poeta nota appena mette piede in casa, è rappresentato dal camino vuoto, privo della fiamma che la madre teneva costantemente accesa e che aveva quasi il senso di un simbolo di continuità di vita e di comunione d’affetti tra i dispersi membri della famiglia:
Quella grande buca vuota, in quel pomeriggio, vuota di fiamme in quella giornata d’afa, e le croste visibili della fuliggine furono per me l’avvertimento più doloroso della irreparabile sventura che aveva colpito casa nostra. Mia madre non avrebbe lasciato spegnere il fuoco, raffreddare la grande lastra di vivo sasso: mi accoglieva sempre seduta accanto al focolare, d’estate o d’inverno, le rare volte che negli ultimi anni io ritornavo vicino a lei, a lei che negli ultimi anni aveva i bordi larghi della veste un poco bruciacchiati (159).
La figura paterna è descritta invece da Sinisgalli in maniera ambivalente, contraddittoria. Come ha osservato Aymone, primario tra i sentimenti che tale figura sollecita nell’autore adolescente è “un vissuto di estraneità, contrapposto alla piena interiorizzazione della figura materna, cui viene contrapposto anche il ruolo dell’altra”[26]. Nel Capitolo terzo di Fiori pari fiori dispari, è rievocato l’incontro col padre in collegio, dove l’autore bambino lo rivede invecchiato dopo il suo ritorno dall’America, provandone una forte delusione e un senso di inferiorità rispetto agli altri compagni che avevano genitori giovani e “robusti”:
Tutta la notte io piansi sopra il guanciale stretto fra le braccia. Non sapevo che mio padre fosse già tanto vecchio. Avevo conosciuto in due anni quasi tutti i genitori dei miei compagni, le loro mamme così giovani e fiorenti, i loro papà robusti che parlavano ad alta voce col nostro direttore nel cortile. Mi ricordavo la nuca secca di mio padre come l’avevo vista quand’egli era uscito dalla porta, la sua voce bassa e un po’ rauca. Era partito tanti anni prima per l’America: quella stessa mattina per difendere la mia famiglia dagli insulti di un compagno di giochi, ero tornato a casa con la fronte insanguinata da una sassata […]. Mio padre ora tornava ma non era più forte. Chi allora avrebbe fatte tutte quelle vendette immaginarie che avevo sognato in tanti lunghe notti? (22).
Al tempo stesso, la rappresentazione della figura del padre assume toni quasi solenni in altri brani dei due libri nei quali emergono invece le sue qualità, come le competenze in campo agricolo e amministrativo e la straordinaria capacità oratoria:
Mio padre conosce le migliaia di viti ad una ad una. (Andirivieni, B, 122); È commovente l’interesse e la competenza che quest’uomo di settant’anni dimostra per i piccoli problemi amministrativi della tribù. (Viaggio, B, 139); Mio padre aveva parlato con la sapienza dei suoi padri, come avrebbe parlato Salomone. (ivi, 140); Mio padre è un uomo che ha fatto tutti i mestieri, è stato dieci anni in America, ha cresciuto sette figli. Ma qualche volta, quando parla, eccitato dall’ira come certi profeti, dice cose straordinarie (ivi,141); Mio padre scese nel bosco a guardare il lavoro degli operai che accatastavano la legna per l’inverno. Aveva segnato meticolosamente a una a una le piante destinate a scomparire: un uomo lo seguiva e con un colpo di accetta intaccava il fusto delle querce periture. Ma non c’era caso che in quella scelta mio padre rivelasse una minima esitazione: gli bastava un colpo d’occhio (Belliboschi, B, 146).
Altre volte però Sinisgalli arriva anche a una demitizzazione della figura paterna, (“Mio padre non è un grand’uomo, forse è un uomo qualunque”, Viaggio, B, 139), giungendo in un’occasione a descriverlo in una posizione quasi comica e buffa, mentre dorme su una sedia russando: “Una sera mio padre, stando vicino al fuoco, s’era addormentato seduto sulla sedia. Mia madre si alzò senza far rumore e si allontanò nelle stanze. Russava, il respiro usciva qualche volta strozzato dalla gola: allora si svegliava di soprassalto e, cogli occhi socchiusi, borbottava qualche frase, poi riprendeva a dormire” (Due primavere, B, 107).
Un certo spazio nelle prose hanno anche altri familiari e parenti, come le sorelle, il fratello, la nonna, il nonno e soprattutto la cugina Elisabetta. Quest’ultima, sulla quale l’autore ritorna in tre occasioni, è per lui una figura perturbante forse proprio perché assai somigliante alla madre (“Mia madre la odiava perché Elisabetta aveva il suo profilo, le sue manie, ed io amavo tutte le donne che somigliavano a mia madre”, Capitolo ventitreesimo, FPFD, 74). Non a caso, quando a Roma la rivede, ormai adulta e in attesa di un figlio, la paragona alla luna, simbolo materno per eccellenza: “L’ho incontrata ch’era felice, che camminava nell’aria con un passo profondo. Era qualcosa come la luna, lenta e piena, uno specchio carico d’un immagine amata” (ivi, 75). Ma il poeta subisce il fascino di Elisabetta fin da ragazzo, allorché, da lei bendato, compie una passeggiata in sua compagnia, in un’atmosfera magica e incantata, in cima alla collina, alla volta di una misteriosa “Città” (Belliboschi,B).
Nella seconda raccolta poi l’autore va ancora più a ritroso nel tempo scavando nella storia più remota della sua famiglia, come in Parenti lontani di Belliboschi, quasi a volersi interrogare sul senso di un destino che avrebbe potuto essere diverso se non fossero accaduti certi fatti, come una sciagura che coinvolse i suoi avi nell’Ottocento: “Io penso tante volte che mia madre, piccola e bruna, avrebbe potuto essere alta e rossa, e noi stessi, anziché venire alla luce sui colli, avremmo potuto nascere in un paese di mare” (93). In America, invece, è narrata, in tono quasi favolistico e leggendario, la saga degli zii emigrati in Colombia.
In Belliboschi l’attenzione si allarga poi anche a singolari personaggi del paese, conosciuti da bambino, dei quali Sinisgalli riesce a delineare i ritratti con notevole abilità narrativa, collocandoli nel contesto della specifica realtà ambientale e sociale lucana: dal maestro del racconto L’albero bianco a Nadina, la ragazza barbuta dell’omonima prosa, dove è rievocato l’antico mestiere delle “pettinatrici”; dall’orologiaio (Orologi) a don Donato, un singolare prete amante della flora e della fauna (Un prete picaresco), a don Nicola Pascarella, una bizzarra figura di avvocato (La corte dei vecchioni).
Agli anni trascorsi nei collegi sono dedicate invece alcune prose nelle quali emerge soprattutto il motivo della solitudine. Già la partenza per il collegio a Caserta in compagnia di Silvestro e del parroco e il definitivo abbandono del paese equivale a una “morte” simbolica:
(Io dico qualche volta per celia che sono morto a nove anni, dico a voi amici che il ponte sull’Agri crollò un’ora dopo il nostro transito; mi convinco sempre più che tutto quanto mi è accaduto dopo di allora non mi appartiene, io sento di non aderire che con indifferenza alla spinta del vento, al verde al rosso. Io so che la morte arriva all’ora prescritta; non è un’ingiuria, non è un sopruso: io so di essere stato tradito per tutta la vita uscendo fuori dalle mie dolci mura, io che non ero innamorato di carte e di stampe, ch’ero nato senza appetiti, senza fiamme nella testa, e volevo semplicemente perire dentro la mia aria. Forse siamo pochi a lamentarci di non saper più trovare una patria fuori dalle nostre colline) (Capitolo secondo, FPFD, 20).
Da allora il piccolo Leonardo incomincia ad assaporare “il veleno della solitudine” (ibid.), imparando a sue spese che l’infanzia “bisogna scontarla con lunghi anni di solitudine” (Capitolo decimo, FPFD, 44). Non a caso, al periodo passato in collegio è legato, fra l’altro, il ricordo di un giovane istitutore, Silvio, sulla cui fronte grava l’“ombra oscura” della perdita del padre avvenuta in circostanze misteriose. Silvio diventa così una sorta di alter ego dell’autore che in lui rispecchia il proprio stato d’animo di malinconia e di tristezza:
Quell’ombra nera sulla fronte di Silvio tradiva la nostra aspettazione. La delusa presenza di lui, il suo passo stanco, la sua testa di ragazzo già un poco reclina, la sua solitudine, rappresentavano per noi il messaggio minaccioso di quel regno che avevamo sempre sognato, così splendido oltre quelle mura (Il giovane istitutore, B, 102).
Un altro periodo della vita del poeta rievocato nelle prose è quello trascorso nelle grandi città, Roma e Milano, dove studia, si forma e poi comincia a lavorare. È il periodo, come ha scritto Giuseppe Pontiggia, dell’“irrequieto nomadismo” del “succedersi di camere ammobiliate, di alberghi, di città, cui fa da ironico contrappunto l’immobilità dello scriba”[27]. È, questo, l’altro “polo”[28] dell’esistere di Sinisgalli, che si contrappone a quello rappresentato dalla sua terra E qui in primo piano balza il motivo del malessere esistenziale che caratterizza questi anni. Altamente significativi, in tal senso, sono i termini e le espressioni che connotano questo stato d’animo disseminati nel Capitolo ottavo di Fiori pari fiori dispari:
Tutte le notti questa malavoglia di rincasare: niente mi appartiene della mia stanza, disabitata (38); Non mi basta ormai la consolazione degli amici e il rammarico mi prende alla gola (ibid.); Pare impossibile che si possano così distruggere i giorni, uno dietro l’altro, e sentirsi nella propria stanza come una bestia in un serraglio, riuscire a vincere la pena (ibid.); Quanti miei giorni passano nella sola smania di far notte. Le lunghe giornate di luce mi portano un disagio che cresce tutti gli anni ad ogni ritorno (ibid.); Ora allungo le notti quanto più posso per consumare il mio disamore (39)
Il periodo trascorso in queste città è considerato sempre un periodo di “esilio” e in esse il poeta si sente come un “forestiero” o un “pellegrino”:
Mi trovavo a un punto morto della mia vita: dopo una lunga assenza trascorsa in una grande città del Nord, come un esule che mai era riuscito ad abituarsi alla scarsa luce di quei cieli, ero tornato a casa mia (Due primavere, FPFD, 105); Di quella mia piccola stanza, dove ero sempre vissuto da forestiero, conobbi tutti i particolari, le ore di sole e le ore di ombra (Il rospo, FPFD, 169); Avevo già ripreso le mie spoglie di pellegrino e mi pareva che le siepi mormorassero al mio passaggio parole misericordiose per la mia sorte (Zinzigorro, FPFD, 192); Mi lamentavo della mia sorte di pellegrino, e dovevo battere i denti se qualcosa simile a un rapido tremito dei denti mi colpiva le orecchie (ivi, 195).
Anche certi personaggi incontrati a Milano o a Roma sono, più che altro, proiezioni del suo malessere e causano nel poeta improvvisi sensi di colpa o riaccendono irrisolti conflitti interiori. Si veda, ad esempio, la figura del compagno d’infanzia Pietro, fattosi sacerdote e ospitato da lui per una notte nella capitale, che gli appare in sogno nell’atto di bruciargli tutte le sue carte, quasi per vendicarsi di essere stato “escluso per sempre dalla sua vita” (Pietro, B, 118). Ma non meno inquietante è la figura di Fratel Mauro, assistente del collegio a Benevento e rivisto casualmente per le strade di Milano, al quale è legato il ricordo di un episodio sgradevole che ancora lo turba: il disegno di un rospo fatto alla lavagna da un compagno per offendere l’odiato assistente, a cui il giovane Leonardo si accosta per “un istintivo moto di carità”, dopo che gli aveva confidato che “soffriva dolori atroci a causa di un male inconfessabile” (Il rospo, B, 166). Nemmeno le giovani donne conosciute e amate per brevi periodi riescono a consolare la sua solitudine, con la conseguenza che le relazioni si rivelano tutte effimere e di scarsa importanza. Esemplare, in tal senso è Un gruppo di lettere oscene, di Belliboschi, dove viene rievocata la breve storia d’amore, di gusto quasi crepuscolare, vissuta con Anna a Roma subito dopo la laurea.
I soli momenti lieti vissuti nelle grandi città sembrano essere quelli rappresentati dall’incontro fortuito con persone del suo paese o originarie della Lucania. È il caso della signora Anna, padrona della gatta Bianchina, protagonista dell’unico vero raccontino di Fiori pari fiori dispari (Capitolo settimo,FPFD), che ritorna anche in La gatta milanese di Belliboschi. Ma gli incontri più significativi descritti nei due libri sono quelli con alcuni artisti: Scipione innanzitutto, su cui Sinisgalli tornerà tante altre volte nei suoi scritti, e Gianfilippo Usellini. Del primo sono rievocati gli ultimi giorni di vita, in un’atmosfera febbrile e allucinata che ricorda la sua pittura (Capitolo quindicesimo, FPFD). Di Usellini invece l’autore mette in luce la particolare sensibilità che lo faceva somigliare a un ragazzo (Capitolo ventesimo, FPFD)
Anche le letture rappresentano dei momenti fondamentali nella sua vita in questo periodo: da Lautréamont letto a Roma durante gli anni d’università, ma anche dopo, con cui si instaura quasi un rapporto diretto (Capitolo sedicesimo, FPFD), a Julien Green e al suo romanzo Voyager sur la terre, da lui tradotto (Capitolo ventunesimo, FPFD), fino a Petrarca e Shakespeare, i cui libri appartenuti a un arcivescovo egli trova casualmente nella stanza di un vecchio albergo romano (Capitolo ventiquattresimo, FPFD).
Ma frequenti, soprattutto in Fiori pari fiori dispari, sono i rapporti che Sinisgalli stabilisce tra la propria terra e i luoghi dove in quel momento si trova a vivere. A volte si tratta di situazioni particolari. Nel Capitolo ottavo, ad esempio, mette a confronto il desolato ritorno di notte nella pensione, dove accanto alla sua camera riposa un vecchio a lui estraneo, con il rientro a casa da ragazzo nel suo paese con la rassicurante presenza dei genitori che lo attendono per potersi addormentare in santa pace:
Un tempo quand’io tornavo tardi la notte, dovevo passare davanti al letto dei miei genitori, che non prendevano sonno fino a quando io non fossi rientrato. Tra una porta e l’altra della loro camera, io mi sentivo liberato da tutti i mali, felice di ritrovarli pazienti con me. Mi dicevano: hai chiuso bene la porta; ma capivo per il solo bene di sentirmi al buio parlare. Rispondevo che non era troppo tardi e che c’era fuori la luna piena (Capitolo ottavo, FPFD, 40).
Altre volte è un oggetto, come una bandierina legata all’antenna dell’autobus vista a Milano, che stimola il ricordo:
Un panno colorato che si muove nel vento dà sempre piacere alle pupille: non a caso mi ricordo delle logge meridionali con la biancheria appesa alle corde e che a me bambino pareva suscitasse per simpatia il moto lento delle nuvole e l’irritazione delle galline” (Capitolo nono, FPFD, 42).
O una coperta rossa sul letto, da lui richiesta nelle camere delle pensioni frequentate perché in questo modo si illude di portarsi dietro la sua infanzia: “Questo panno rosso fa da richiamo alla mia noia: io ci ritrovo la ragione di tutti i vizi dei miei antenati arabi, il sonno, la tristezza del sesso, i rimorsi e tutto quello che c’è di ilare, di capriccioso nel mio sangue” (Capitolo decimo, FPFD, 45).
Negli scritti dedicati al periodo del servizio militare in Sardegna, durante la guerra, è presente infine soprattutto il motivo della monotonia che caratterizza quei giorni “vuoti e bellissimi” (Capitolo dodicesimo, FPFD, 49), trascorsi in caserma giocando a carte, fumando e parlando di donne e di cavalli con i commilitoni o a diretto contatto con la selvaggia natura dell’isola. Qui una presenza benefica è costituita dagli animali che tengono compagnia all’autore, attraverso i quali ritornano ancora suggestioni antropologiche della sua terra. Si veda, ad esempio il Capitolo quattordicesimo di Fiori pari fiori dispari nel quale l’apparizione improvvisa prima di una capretta e poi di un cane gli fa pensare a persone care nascoste sotto quelle sembianze, come se fossero “anime” di defunti venuti a consolarlo:
Un giorno di pioggia una capretta sarebbe venuta a ripararsi sotto la mia tenda, si sarebbe fatta avanti nella tempesta come chi ha voglia di dire una cosa molto segreta […]. Avrei avuto la certezza che i cari esseri sanno prendere qualunque sembianza per consolare la nostra solitudine (56); Era un cane, un cane che cominciò a leccarmi le mani come avrebbe fatto col suo padrone morto e resuscitato. Io mi misi a seguire la strada che il cane m’indicava. Un cane a quell’ora, quella notte, era certamente un’immagine cara che mi veniva in soccorso (ibid.).
Un’altra “consolazione” è rappresentata dalla passione per la geometria che non lo abbandona mai:
Quelle misure erano una cosa emozionante per me: pensavo che gente come noi, usando il passo del piede e il palmo della mano, aveva misurato il delta del Nilo e disegnato il primo triangolo. Io cercavo di comunicare a quei miei ragazzi della pattuglia, falegnami, meccanici e agricoltori, la mia commozione nel ritrovarmi dopo tanti anni a risolvere ancora triangoli, a tracciare cerchi col compasso, a riscoprire quelle virtù straordinarie legate a delle forme così semplici e così folli (Capitolo tredicesimo, FPFD, 53).
Come pure continua l’ininterrotto interrogarsi dell’autore sul senso della propria esistenza: “ecco, pensavo con una curiosa ebbrezza, che non mi conoscevo, questo viaggio potrebbe essere l’ultimo della mia vita. I miei giorni sono stati anonimi e noiosi, anonimi e noiosi lo saranno sempre più dopo questa straordinaria vacanza” (Capitolo quattordicesimo, FPFD, 56). Anche in queste pagine insomma ritornano i motivi più tipici delle prose di Sinisgalli.
[In A.L.
Giannone, Tra Sud ed Europa. Studi sul
Novecento letterario italiano, Lecce, Milella, 2013]
[1] L. Sinisgalli, Fiori pari fiori dispari, Milano, Mondadori, 1945.
[2] Id., Belliboschi, Milano, Mondadori, 1948
[3] Id, Prose di memoria e d’invenzione (Fiori pari fiori dispari, Belliboschi), Bari, Leonardo da Vinci, 1964, da cui sono tratte le nostre citazioni. Per queste due opere si sono adottate le seguenti sigle: FPFD = Fiori pari fiori dispari; B = Belliboschi. Alle sigle segue il numero della pagina.
[4] Id., Belliboschi, Milano, Mondadori, 1979.
[5] Il riferimento è ovviamente a Ph. Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Editions du Seuil, 1975 (trad. it., Il patto autobiografico, Bologna, Il Mulino, 1986).
[6] Per un’efficace sintesi del dibattito critico su queste due raccolte cfr. G. Mariani, L’orologio del Pincio. Leonardo Sinisgalli tra certezza e illusione, Roma, Bonacci, 1981, nota 4, pp. 59-60.
[7] Ivi, p. 60.
[8] D. Valli, Dal frammento alla prosa d’arte con alcuni sondaggi sulla prosa di poeti, Lecce, Pensa Multimedia, 2001, p. 11.
[9] E. Falqui, Belliboschi, in “Tempo”, 21 giugno 1929, ora in Id., Novecento letterario italiano, vol. IV, Firenze, Vallecchi, 1970, p. 200.
[10] E. Falqui, Fiori pari fiori dispari, in “Risorgimento liberale”, 1° novembre 1945, ora in Id., Novecento letterario italiano, cit., p.197.
[11] Id., Belliboschi, in Id., Novecento letterario italiano, cit., p. 200.
[12] V. Branca, rec. a Fiori pari fiori dispari, in “Il Ponte”, dicembre 1945, p. 859.
[13] G. Mariani, L’orologio del Pincio, cit., p. 62.
[14] Cfr. L. Sinisgalli, Vidi le Muse, a cura di R. Aymone, Cava dei Tirreni, Avagliano, 1997.
[15] G. Pampaloni, Sinisgalli prosatore, in Atti del Simposio di studi su Leonardo Sinisgalli, Matera, Liantonio, 1987, p. 69.
[16] G. Raboni, C’è un narratore dietro il poeta, in “Tuttolibri – La Stampa”, 14 aprile 1979.
[17] Al 1934 risale la pubblicazione del Capitolo ottavo. Nel 1942 invece, tra il !° marzo e il 1° dicembre, vennero pubblicate su “Primato” ben dodici prose di Fiori pari fiori dispari. Devo queste informazioni a Franco Vitelli, che qui ringrazio.
[18] Su questo argomento cfr. D. Valli, Dal frammento alla prosa d’arte con alcuni sondaggi sulla prosa di poeti, cit.
[19] Ivi, p. 30.
[20] Ibid.
[21] C. Malaparte, Aver voce in “Capitoli”, in “Prospettive”, n. 8-9, 15 agosto-15 settembre 1940, riportato da D. Valli, Dal frammento alla prosa d’arte, cit., p.16.
[22] G. Pontiggia, Le Muse di Sinisgalli, in L. Sinisgalli, L’ellisse. Poesie 1932-1972, a cura di G. Pontiggia, Milano, Mondadori, 1974, p. 16.
[23] G. Mariani, L’orologio del Pincio, cit., p. 54.
[24] I corsivi in questi e negli altri brani citati sono nostri.
[25] G. Mariani, L’orologio del Pincio, cit., p. 61.
[26] R. Aymone, commento della lirica A mio padre, in L. Sinisgalli, Vidi le Muse, cit., p. 245.
[27] G. Pontiggia, Le Muse di Sinisgalli, cit., p. 16.
[28] Ibid.






























































