di Antonio Prete
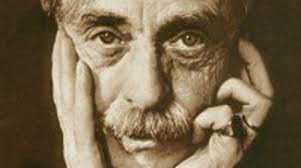
Centocinquanta anni dalla nascita di Paul Valéry. Walter Benjamin, negli anni parigini, immaginava di offrire al poeta, nell’occasione di un suo anniversario, un ex-libris che figurasse un compasso. Un compasso con una gamba nel fondo del mare e l’altra aperta verso l’orizzonte. Benjamin ricorreva all’iconologia, ai suoi emblemi: la scrittura di Valéry come ricerca di una verità che resta sempre nascosta e che la navigazione nei saperi può sì intravvedere ma mai disvelare, e allo stesso tempo la scrittura come sguardo rivolto verso l’orizzonte, verso il confine. Che è confine tra la terra e il cielo, tra il visibile e l’invisibile, tra il noto e l’ignoto. In effetti, quel che Valéry, nella sua poesia, nei suoi saggi e dialoghi e soprattutto nei suoi Cahiers – questo rigogliosissimo Zibaldone novecentesco – mette in scena è l’avventura di un pensiero in costante stato di interrogazione: la verità, anzi la sua assenza, è sorgente di un’immaginazione che si affida di volta in volta alla lingua della poesia, al frammento, all’aforisma, alla trattazione teorica, all’indagine psichica, all’escursione erudita sulle lingue e sulle discipline fisiche e matematiche, alla narrazione, all’autobiografia intellettuale. Per questo movimento di un’inesauribile curiosità che cerca le forme del dire, del comporre, del raccontare, per questa apertura senza limiti ai linguaggi di tutte le arti, e soprattutto alle loro corrispondenze e reciproche rifrazioni più che alle loro tecniche – forte su questo piano è la lezione del Baudelaire critico – la figura dell’uomo rinascimentale, e in particolare di Leonardo, diventa per Valéry il centro per dir così interiore che alimenta la raggiera del suo ricercare.




























































