di Antonio Errico
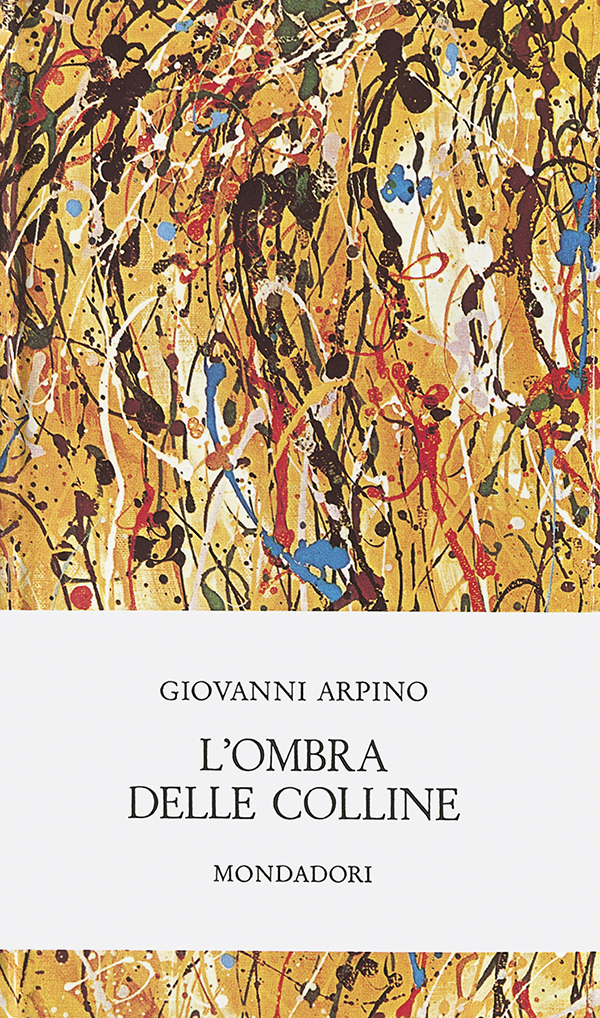
Se per caso vi fosse capitato di non aver ancora letto il premio Strega, non lo dite. Potreste essere redarguiti, severamente. A me è successo, qualche giorno addietro. Ho confessato candidamente di non aver ancora letto Due vite di Emanuele Trevi, e sono stato redarguito: severamente. E’ impensabile; è inammissibile. Non si può non leggere, tempestivamente, chi vince lo Strega, e se capita che non lo si legga, tempestivamente, comunque quantomeno non lo si deve confessare.
Io invece ho confessato. Ingenuamente. Come se fosse una cosa normale. Giustificandomi anche con il fatto che in questo periodo avevo peraltro messo in conto di rileggere qualcosa di un autore che pure ha vinto il premio Strega, nel Sessantaquattro, e che poi è stato pressoché dimenticato, ingiustamente. Perché dimenticare è sempre ingiusto. Si tratta di Giovanni Arpino. Negli occhi di chi mi aveva appena redarguito, intravedo un’ombra di disorientamento. Sì, Giovanni Arpino, dico. Il disorientamento diventa crescente. Allora ripeto il nome: Giovanni Arpino. Uno di quegli scrittori che sanno perfettamente che la scrittura può anche non essere arte pura ma che dev’essere necessariamente accurato artigianato, lavoro costante e paziente di costruzione e di lima. E’ uno di quegli scrittori che non si fanno nemmeno sfiorare dall’idea balzanachela scrittura possa in qualche modo sostituirsi alla vita.
Chiedo a chi mi ha redarguito di dirmi qualcosa del romanzo di Trevi. Mi risponde che vuole sentire qualcosa di Arpino, invece. Non lo conosce, non lo ha mai letto. Confessa anche lui, adesso. Dimenticare è sempre ingiusto, dice lui, adesso.
Allora gli dico che in un racconto brevissimo, di appena tre pagine e mezza, intitolato C’è stata una sera, Arpino dice qual è il nodo che mette insieme il racconto e la vita, in che cosa consiste la pena, e la fatica, di cercare parole che sappiano dire quello che si è fatto o non si è fatto, la bellezza di un istante, l’allegria di una sera con gli amici.




























































