di Rosario Coluccia
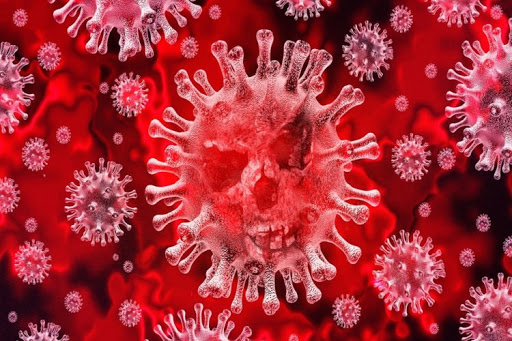
Domanda: al tempo della pestilenza può aver senso occuparsi dei fenomeni linguistici che scorgiamo intorno a noi? Almeno una ragione esiste, se non m’inganno. Tutti avvertiamo il bisogno di essere informati su quel che succede, ma in questo non ci aiuta il diluvio di anglicismi che, con riferimento al coronavirus, promana dai media. Si chiamano droplet le micidiali goccioline di saliva emesse starnutendo (circa 40mila goccioline sparate a 160 chilometri orari), tossendo (3mila goccioline a 80 chilometri orari) o anche semplicemente parlando. Queste microgocce possono veicolare agenti infettivi, sono più pesanti dell’aria e mediamente hanno un raggio di ricaduta di un metro e mezzo (o forse un po’ di più) dalle vie aeree. Ecco perché non dobbiamo stare vicini a chi ci parla, se vogliamo preservarci dal rischio del contagio. Pervasivo è lockdown, variamente scritto: in corsivo (lockdown), tra virgolette (“lockdown”), in tondo (lockdown), con differenti modalità che parrebbero indicare i diversi coefficienti di acclimatamento del forestierismo nella nostra lingua. Il termine nella lingua inglese significa ‘confinamento’, ‘carcere’, anche ‘sicura’ (di un computer). Entrato nell’italiano, nella maggioranza dei casi le fonti (orali e scritte) vi ricorrono senza alcuna spiegazione, come se si trattasse di una parola a tutti nota. Ma forse comunicheremmo meglio se scegliessimo parole conosciute, se dicessimo serrata, isolamento, chiusura, blocco, o addirittura coprifuoco. Tutto sarebbe più chiaro e magari anche quei pochi che dicono di non aver capito (e perciò vanno in giro quando non dovrebbero) non avrebbero più scuse.




























































